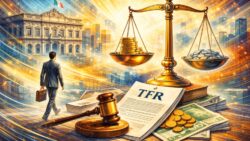Il comporto nell’era digitale: tra certezza formale e linguaggi della fragilità
Abstract. La recente sentenza Cass. n. 26966/2025 ha riaffermato il primato della forma nella prova della malattia, escludendo la rilevanza giuridica delle comunicazioni informali via chat. Il presente contributo esplora la disciplina del comporto alla luce di tale pronuncia, riflettendo sulla tensione fra certezza e realtà, tra formalismo probatorio e linguaggi digitali della vita quotidiana. Si propongono, in chiave comparata e prospettica, possibili evoluzioni normative e contrattuali idonee a coniugare la dimensione umana del lavoro con le nuove modalità comunicative dell’era digitale.
***
Nel rapporto di lavoro esiste un tempo in cui la produttività cede il passo alla fragilità.
È il tempo della malattia: quello in cui la prestazione si sospende e il lavoro rivela la sua natura più autentica, quella di esperienza umana, fatta di limiti, bisogni, cura.
In quel tempo sospeso, anche il linguaggio cambia.
Non è più quello dei protocolli o delle formalità, ma quello essenziale della vita: «Sto male, oggi non riesco». Un messaggio breve, sincero, affidato a una chat, che tenta di tradurre la sofferenza in parole.
Eppure il diritto, custode della forma e della prova, fatica a riconoscere quella lingua.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26966/2025, lo ha ribadito con nettezza: la comunicazione informale, anche se tempestiva, non è idonea a interrompere il decorso del periodo di comporto.
In assenza di certificazione medica, la malattia rimane un fatto privo di valore probatorio.
E quando il tempo di comporto si consuma, il licenziamento è legittimo.
Legittimo, sì. Ma non sempre equo.
Il comporto rappresenta uno dei punti di maggiore tensione del diritto del lavoro: è la soglia tra il diritto alla salute del lavoratore e l’esigenza organizzativa dell’impresa.
Nasce dall’art. 2110 c.c., ma trova concreta attuazione nella contrattazione collettiva, che ne determina la durata e le modalità di computo, differenziandole in base a settore, qualifica e mansione.
La distinzione fra comporto secco (assenza continuativa) e comporto per sommatoria (assenze frazionate) incide non solo sulla durata della tutela, ma anche sulla valutazione della legittimità del recesso.
Si tratta, in definitiva, di un istituto di bilanciamento: un tempo di sospensione reciproca, in cui il datore sostiene l’assenza e il lavoratore non ne abusa.
Una tregua, non una resa.
Oggi il lavoro non si misura più soltanto in timbri e lettere raccomandate, ma si consuma in flussi digitali: e-mail, chat aziendali, piattaforme di messaggistica.
La relazione di lavoro vive in una dimensione immediata, dialogica, informale.
Il diritto, tuttavia, resta ancorato a una logica cartacea della certezza: pretende la prova formale, la certificazione, la firma.
Così, mentre la vita si racconta in chat, la verità giuridica continua a esistere soltanto su carta.
In questa distanza si nasconde un rischio: che la tutela si trasformi in formalismo e la certezza in cecità.
La Cassazione ha scelto la coerenza sistematica, non l’inerzia.
Ha ribadito che la prova della malattia, ai fini dell’interruzione del comporto, richiede documentazione medica idonea.
Una posizione coerente con la giurisprudenza costante (ex multis, Cass. n. 7755/2011; Cass. n. 22152/2019), ma che solleva un interrogativo più profondo: può un diritto che si definisce “del lavoro”, e dunque vicino alla persona, ignorare i linguaggi reali attraverso cui quella persona oggi comunica?
In altri ordinamenti, la risposta appare diversa.
In Germania, il licenziamento per malattia è ammesso solo se l’assenza incide in modo serio e permanente sull’organizzazione, con valutazione caso per caso.
In Francia, la legittimità del recesso è misurata sulla base della proporzionalità.
In Spagna, la legge vieta il licenziamento fondato su assenze dovute a patologie gravi.
Nel Regno Unito, l’obbligo di reasonable adjustments impone al datore di adeguare ambiente e condizioni lavorative alle esigenze del dipendente malato o disabile, anche durante assenze prolungate.
A livello sovranazionale, la Convenzione OIL n. 158/1982, la Carta Sociale Europea e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delineano una visione più inclusiva, nella quale la malattia è considerata condizione, non inadempimento.
La tutela si modella sull’individuo, non sul modello astratto del prestatore “sempre disponibile”.
Il diritto del lavoro italiano, per quanto vivo e mutevole, continua spesso a muoversi entro schemi rigidi, poco permeabili alla dimensione digitale delle relazioni.
Ma la realtà del lavoro contemporaneo chiede un linguaggio nuovo: capace di leggere la chat non come un atto irrilevante, ma come manifestazione tempestiva di buona fede.
Occorre elaborare una nuova grammatica della tutela, che integri la comunicazione elettronica nel sistema delle prove senza smarrire il requisito della certezza.
Ciò potrebbe realizzarsi attraverso:
previsioni contrattuali che riconoscano valore alla comunicazione digitale come primo avviso di malattia, con obbligo di formalizzazione entro un termine ragionevole;
protocolli organizzativi inseriti nei Modelli ex D.Lgs. 231/2001, dedicati alla gestione delle assenze e delle comunicazioni digitali;
formazione mirata di datori e consulenti a una lettura empatica e responsabile della fragilità.
In questo modo, la compliance aziendale diventerebbe anche cultura della relazione, riducendo il contenzioso e rafforzando la fiducia reciproca.
Il comporto, più che un limite temporale, è una narrazione: quella di un diritto che misura la distanza fra regola e vita.
La Cassazione ha parlato la lingua della certezza; spetta al legislatore e alla contrattazione collettiva rispondere con la lingua dell’ascolto.
Perché il lavoro, prima ancora che contratto, è relazione.
È corpo, voce, presenza.
E se oggi la malattia si scrive in chat, il diritto non può fingere di non saper leggere.
Non per dissolvere la forma, ma per restituirle senso.
Perché la forma, senza umanità, non tutela: esclude.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Aldo Andrea Presutto
Avvocato & DPO
Ultimi post di Aldo Andrea Presutto (vedi tutti)
- La forma sostanziale della tutela: impugnazione del licenziamento e validità della PEC senza firma digitale - 10 Gennaio 2026
- TFR e indennità risarcitoria nel pubblico impiego: la Corte costituzionale chiarisce con la sentenza n. 144/2025 - 26 Dicembre 2025
- Disabilità e licenziamento per comporto: la sentenza CGUE C-5/24 tra diritto dell’Unione e ordinamento interno - 16 Dicembre 2025