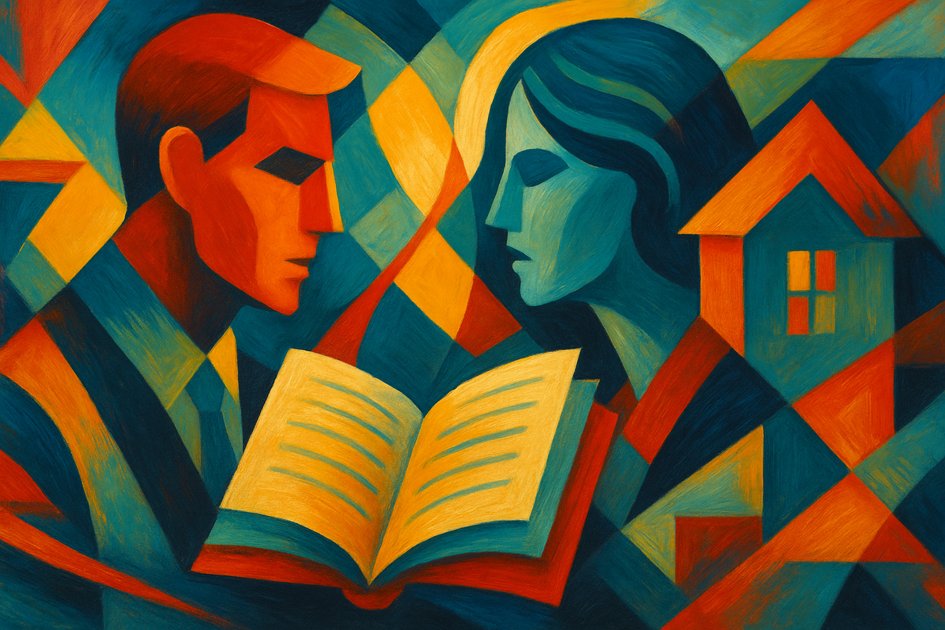
Il testamento concordato nel diritto tedesco
a cura della dott.ssa Michela Falcone
L’espressione “testamento concordato”, coniata da Maurizio Lupoi nel libro intitolato “I trust nel diritto civile”, indica una particolare forma di testamento caratterizzata da un accordo ad esso sottostante, in base al quale due persone, solitamente i coniugi, redigono un testamento l’uno a favore dell’altro o, comunque, al fine di farne beneficiare uno o più soggetti terzi.
I testamenti concordati vengono distinti in due categorie: i testamenti congiunti che sono contenuti in un unico documento e i testamenti corrispondenti che, invece, sono contenuti in documenti separati.
Le predette tipologie di testamento sono caratterizzate da un comune intento delle parti: ciascuna fa affidamento sul fatto che l’altro non modifichi la propria disposizione, sia durante la vita di entrambi sia una volta sopravvenuta la propria morte.
In molti ordinamenti europei tale tipologia di testamento è vietata in virtù del principio di ambulatorietà, secondo cui ciascuno è libero di revocare il proprio testamento fino alla sua morte, secondo il celebre brocardo latino: Ambulatoria est voluntasdefuncti usque ad vitae supremum exitum (D. 34, 4, 4).
Il nostro legislatore vieta all’articolo 589 c.c. la redazione dei cd. testamenti congiuntivi o reciproci, al pari del legislatore d’Oltralpe, anche se divieti simili si rinvengono nella codificazione belga, portoghese, olandese e spagnola.
Tali testamenti, frutto della prassi consuetudinaria dell’epoca tardo-medioevale, che ebbero una grande fortuna nel diritto comune, vennero cancellati all’improvviso durante il periodo delle codificazioni.
Il sistema tedesco e il sistema inglese, invece, ammettevano e ammettono tuttora entrambe le forme di testamento concordato, senza che ciò determini la violazione del principio di ambulatorietà, pur addivenendo a tale risultato in maniera differente.
Nel sistema inglese, va precisato, l’assenza di regole precise e una giurisprudenza poco affidante, induce a rifuggire da tale strumento negoziale, che prende il nome di mutual wills.
In Germania il testamento concordato è sempre stato affiancato alla particolare figura del contratto ereditario cd. Erbvertrag, a noi giuristi precluso, con cui condivide senza dubbio delle similitudini, pur, al tempo stesso, distinguendosi dal momento che il secondo ricade appieno nell’orbita contrattuale.
Il diritto successorio tedesco nell’enucleare la figura del testamento concordato individua tre distinte ipotesi: il testamentum mutuum ,il testamentum reciprocum e il testamentum corrispectivum.
Il primo tipo indica i testamenti contenuti nello stesso documento, il secondo indica i testamenti che contengono disposizioni reciproche, infine, il terzo indica quei testamenti in cui l’esistenza e la validità di un testante sono condizionate alla esistenza e alla validità dell’altro.
Nell’area germanica questi testamenti si svilupparono a partire dal XVI secolo e, fin da subito, la dottrina e la giurisprudenza teutonica dovettero cercare un punto comune per ammetterne la loro validità, alla luce dell’immanente principio di ambulatorietà e dei relativi problemi della revocabilità e della tutela dell’affidamento.
Il problema della revocabilità comincia a porsi, con forza, nel dibattito dottrinale tra i Pandettisti a partire dal XVII secolo.
Una prima linea di pensiero era incline ad ammettere la libera revocabilità di entrambi i testamenti, anche se solo rispetto a quelli contenuti in un unico documento, tuttavia, era prevalente l’orientamento che valorizzava l’unicità dell’atto, poiché sintomatico della comune volontà di entrambe le parti di dare vita ad un certo vincolo, o al reciproco affidamento delle parti stesse sul fatto che nessuna avrebbe provveduto a modificare la propria destinazione.
La tesi, da sempre prevalente in seno alla dottrina e alla giurisprudenza tedesca, ritiene che alla base di tali testamenti vi sia un’intesa tra le parti, che costituisce una figura sintomatica di un elemento contrattuale cd. Vertragselement, ma che non è qualificabile come un contratto vincolante e formale.
L’intesa contrattuale permette di ritenere ammissibile la libera revocabilità del testamento durante la vita dei testanti, a patto chela revoca venga comunicata all’altro, invece, per quanto riguarda la revoca dopo la morte è possibile solo se si rinuncia a quanto ricevuto.
Tale meccanismo permette, quindi, di rispettare il fondamentale principio di ambulatorietà alla base del testamento, e al tempo stesso di accordare tutela all’affidamento riposto nel superstite.
Il codice civile tedesco BGB (Bügerliches Gesetzbuch) ammette i testamenti concordati, nonostante la prima commissione che lavorò all’elaborazione del codice era favorevole a disconoscerli, tuttavia, li ammette solo rispetto alle persone dei coniugi.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Michela Falcone
Ultimi post di Michela Falcone (vedi tutti)
- I conferimenti societari e il problema delle criptovalute - 16 Dicembre 2025
- Mandati successori e divieto dei patti successori: guida essenziale - 8 Dicembre 2025
- La prelazione impura - 1 Dicembre 2025







