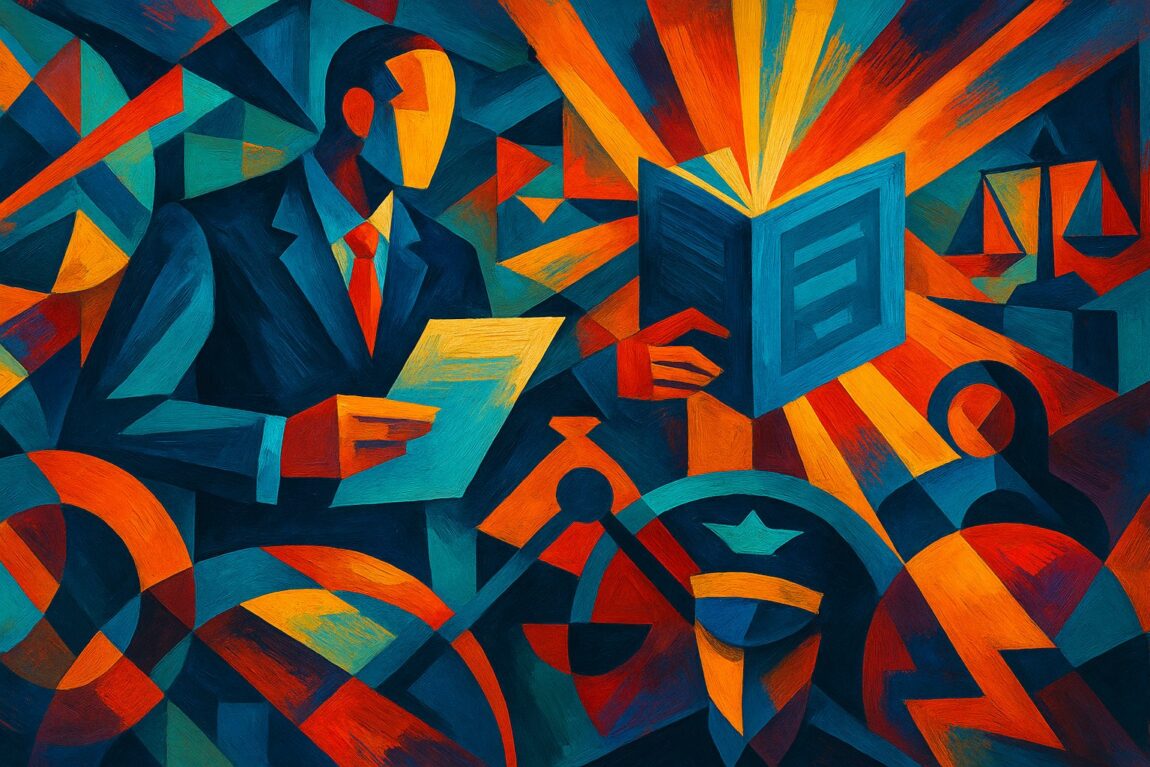
Il decreto ingiuntivo: nuove prassi operative all’interno del procedimento di arbitrato
Sommario: 1. Il decreto ingiuntivo nell’ordinamento giuridico vigente – 1.1. Il procedimento d’ingiunzione: compendio operativo generale sulla profilassi ex artt. 633 e ss. – 1.2. Il procedimento monitorio in sede di processo civile arbitrale – 1.3. Considerazioni finali
Il decreto ingiuntivo nell’ordinamento giuridico vigente
Il decreto ingiuntivo nell’ordinamento giuridico vigente si colloca negli ambiti degli istituti ricompresi dal libro IV c.p.c., quello dei procedimenti speciali; nella specie all’art. 633 c.p.c. il legislatore ci consegna quella che possiamo definire un’attestazione di identità del decreto in commento, ovvero ci informa che il decreto ingiuntivo consente a chi sia titolare di un diritto di credito, avente come oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, oppure una specifica quantità di cose fungibili o anche la mera consegna di una cosa, di richiedere all’organo giurisdizionale competente (come vedremo nel corso della trattazione anche e soprattutto al giudice arbitrale) di determinarsi nell’emanazione del decreto per ingiunzione di pagamento o di consegna.
Dal procedimento sin qui richiamato sono esclusi quelli che in gergo sono definiti i “crediti di fare e non fare”, oppure quei crediti che hanno ad oggetto il rilascio di cose immobili oppure un quantitativo di denaro o di altri beni mobili fungibili che di fatto non siano determinate o determinabili.
Tali requisiti rappresentano le condizioni essenziali ai fini dell’applicazione dell’istituto in commento e, se mancanti, ne precludono di fatto la sua applicabilità.
1.1. Il procedimento d’ingiunzione: compendio operativo generale sulla profilassi ex artt.. 633 e ss.
Il procedimento ingiuntivo in linea generale si compone di due fasi: la fase monitoria in senso stretto, che è sempre necessaria e trova attuazione dal deposito del ricorso sino al momento della notifica del decreto ingiuntivo; e la fase dell’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza.
Quello appena descritto è l’essenza del procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale e superficiale che non entra nel merito della futura ed eventuale causa giudiziale, ma che si limita, sulla base di una cognizione di superficie, a valutare la mera sussistenza degli elementi previsti dalla norma giuridica ai fini del riconoscimento dei diritti degli istanti, sottesi all’espletamento di tale procedimento.
La seconda fase, invece, possiamo in questa sede definirla eventuale, ed è attivata su specifica iniziativa della controparte che, tramite notifica di un atto di citazione ovvero per mezzo di un ricorso, ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo che gli era stato notificato in precedenza, instaurando di fatto l’introduzione di un processo ordinario destinato quindi a concludersi con un pronunciamento giurisdizionale sul merito.
Nello specifico, la norma in esame ci informa di quelli che sono i requisiti essenziali ai fini dell’ammissibilità giuridica (da parte dell’autorità giudicante) della domanda di ingiunzione, e precisamente:
a) la presenza di una prova scritta del diritto che si intende far valere nel procedimento; sul punto è necessario specificare che il significato di prova scritta debba intendersi in senso ampio, senza limitarsi alle disposizioni sancite dall’art. 2702 c.c.; in tal modo sarà quindi possibile attribuire efficacia probatoria anche agli atti scritti provenienti da un soggetto terzo o dal debitore, anche se questi non li hanno riconosciuti.
b) il credito che è stato vantato deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo.
c) il credito deve riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
In merito a quanto appena indicato, si specifica che, a differenza della generalità dei creditori (i quali sono tenuti all’osservanza di quanto prescritto dall’art. 634 c.p.c.), i soggetti indicati ai punti b e c godono di fatto di un trattamento probatorio meno rigido, grazie alle disposizioni che si trovano all’interno dell’art. 636 c.p.c., il quale prescrive un’attenuazione del requisito della prova scritta, riducendolo alla mera produzione della “parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.
Nella clausola di chiusura sancita con la dicitura “chiunque altro” è possibile ricomprendere sia gli ausiliari del giudice previsti dal capo III del titolo I del codice di rito (ovvero il consulente tecnico d’ufficio, custode, etc.), ma anche quegli specifici soggetti che svolgono analoghe funzioni nei processi penali ed amministrativi.
A questa categoria appartengono i consulenti tecnici nominati dalle parti; invece dalla stessa si devono escludere i testimoni, i quali, a norma dell’art. 107 disp. att. c.p.c., hanno diritto a percepire una mera indennità.
Quanto detto in precedenza, in merito alla facoltà di richiedere all’organo giudicante l’emissione del procedimento ingiuntivo, sulla base del comma 3 della norma in parola, la facoltà di esperire ricorso al procedimento monitorio viene quindi riconosciuta non solo a quei soggetti sopra richiamati che esercitano una libera professione, ma anche a quelli che esercitano un’arte, a condizione che anche per questi sia individuabile una tariffa delle prestazioni lavorative legalmente approvata.
L’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c. ci parla del caso in cui il diritto di credito, oggetto dell’istanza, sia sottoposto a condizione sospensiva ovvero che possa dipendere dall’adempimento di una controprestazione da parte del soggetto creditore; sul punto si specifica che si rende necessario che il creditore produca la prova che tale condizione si sia verificata e quindi di aver adempiuto alla propria prestazione.
Da quanto appena esplicato si assume che non è consentito dalla legge il pronunciamento di un’ingiunzione condizionata, essendo compito dell’organo giudicante la mera verifica in ordine alla sussistenza degli elementi che determinano l’attualità della richiesta creditoria.
Da ultimo, sempre facendo specifico riferimento alla controprestazione dell’istante, si richiama all’attenzione dell’interprete l’istituto dell’art. 1460 c.c., il quale qualifica l’eccezione di inadempimento come “propria” ovvero “in senso stretto”, in questo modo sarà rilevabile solo dalla parte che avrebbe dovuto produrla, con la conseguenza che l’organo giudiziale della fase monitoria potrà quindi richiedere al ricorrente di fornire la prova del relativo fatto costitutivo (quindi dell’adempimento della controprestazione) soltanto se dagli atti da lui stesso formati si evinca l’esistenza a suo carico dell’obbligo della suddetta controprestazione.
In caso contrario, tale mancanza potrà costituire soltanto oggetto dell’eventuale atto di opposizione da parte della controparte.
Una volta depositato da parte dell’istante, l’organo giudiziale adito entro 30 giorni ha facoltà di: rigettare il ricorso, che in ogni caso può essere ripresentato; fare specifica richiesta al fine di avere integrazioni probatorie; oppure accogliere il ricorso.
Il debitore, invece, ricevuta la notifica, ha 40 giorni di tempo per poter decidere cosa fare. Le possibilità che l’ordinamento gli riconosce sono tre:
pagare quanto è dovuto al creditore ricorrente oltre le spese legali liquidate dall’organo giudicante;
proporre opposizione al decreto ingiuntivo innanzi lo stesso organo giudiziario che ha emesso il decreto in commento (come vedremo nel corso di questa monografia la stessa procedura si applica nel procedimento monitorio instaurato tramite procedimento arbitrale);
non pagare il dovuto, ma in questo caso il creditore ha diritto a procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Passati i 40 giorni, il creditore notifica alla controparte l’atto di precetto. Tramite quest’azione lo invita a pagare entro 10 giorni quanto dovuto o ad adempiere alla prestazione cui è obbligato, informandolo che, se non lo farà, procederà ad avviare il procedimento di pignoramento.
A conclusione di questo compendio sull’istituto in commento, si richiamano gli ultimi aggiornamenti introdotti con la Riforma Cartabia, ovvero: in materia di decreto ingiuntivo, è stato abrogato l’art. 476 c.p.c., così da eliminare un adempimento burocratico che comportava, in quasi tutti gli uffici giudiziari, rallentamenti del procedimento monitorio causati dalla negligenza degli impiegati.
Inoltre, fino al 28 febbraio 2023 era necessaria l’apposizione della cosiddetta formula esecutiva, ovvero una formula tipica che comunicasse il comando, rivolto agli ufficiali giudiziari incaricati, di porre in esecuzione il titolo per cui era stata emessa. Infatti, la mancata apposizione della formula determinava, come conseguenza impeditiva agli aventi diritto, la possibilità di recuperare in forma coattiva il loro credito.
Non vi è più necessità di richiedere l’autorizzazione ai fini del rilascio di un’ulteriore copia esecutiva del titolo oltre all’originale. Vi è quindi la possibilità di eseguire un numero anche illimitato di copie attestate conformi di un titolo, purché l’istante sia in possesso dell’originale della copia riprodotta.
Sin qui si è operata un’analisi generale dell’istituto del decreto ingiuntivo; nel prosieguo di questa monografia, si darà conto all’interprete di come tale istituto possa trovare effettiva applicazione anche e soprattutto nell’ambito del procedimento arbitrale.
1.2. Il procedimento monitorio in sede di processo civile arbitrale
Il procedimento civile arbitrale rituale è un procedimento civile ad ogni effetto di legge in quanto previsto e disciplinato dal vigente codice di procedura civile, già riconosciuto come tale anche dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013, che ha sancito che l’attività dei giudici arbitrali, anche in relazione alle precedenti discipline giuridiche del 1994 e del 2006, ha natura giurisdizionale.
Pertanto, l’attività processuale posta in essere dai giudici arbitrali è tipicamente di natura giurisdizionale ordinaria, come è stato anche formalmente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2013, con la quale, ancora una volta, si riconosce al procedimento arbitrale e ai giudici arbitrali che lo dirigono, natura giurisdizionale.
Sul punto, infatti, la predetta sentenza richiama un precedente pronunciamento della stessa Corte, la quale si era già determinata nel riconoscere piena corrispondenza tra la giustizia arbitrale e quella ordinaria e quindi ha pienamente riconosciuto la natura giurisdizionale del procedimento arbitrale; infatti, in sentenza si legge che:
«L’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria.
Sotto l’aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie»,
e ha affermato che il giudizio degli arbitri «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione» (sentenza n. 376 del 2001).
Da quanto sin qui detto, discende in termini giuridici e scientifici (non dimentichiamo che l’istituto del procedimento arbitrale sia rituale sia irrituale è previsto e disciplinato dal codice di procedura civile, quindi è tipicamente previsto come istituto giuridico appartenente alle scienze giuridiche del procedimento civile, dal quale non può essere eluso o escluso per mera ignoranza degli operatori del diritto!) che il procedimento arbitrale (rituale) è un procedimento ordinario, dato che si fonda ed è disciplinato dalle norme del vigente codice di rito, che trova la sua funzione nella tutela dei diritti disponibili.
Fatta questa necessaria premessa, ci occuperemo ora del tema principale di questa analisi, ovvero l’applicazione del procedimento monitorio nel processo civile arbitrale.
Per chi scrive, pare alquanto strano che, ancora oggi, la stragrande maggioranza dei giuristi italiani sconosca l’esistenza del procedimento arbitrale, e quindi di conseguenza non sia a conoscenza (cosa alquanto improbabile, dato il loro conseguimento della laurea in Giurisprudenza o in facoltà ad essa afferenti) della portata innovativa dei suoi istituti; la restante minoranza, invece, interpreta l’arbitrato come una forma di mediazione tra le parti priva di ogni valore giuridico di natura giurisdizionale.
Come abbiamo sin qui esplicato, però, il processo civile arbitrale, sulla base dei dati scientifici incontrovertibili, ovvero le formule giuridiche consacrate nel vigente codice di rito e sulla base delle pronunce della Suprema Corte e della Corte Costituzionale sin qui richiamate, è ad ogni effetto di legge, quindi nel rispetto dei canoni di scientificità ad essi afferenti, un procedimento civile di natura ordinaria (in forma speciale) e come tale deve essere inteso ed applicato.
Per quanto sin qui detto, appare logico e appropriato inserire il procedimento monitorio in fase di giudizio arbitrale in quanto pienamente compatibile, essendo la tutela civile arbitrale conformata alla tutela dei diritti disponibili, e i diritti di credito ne sono un’eloquente dimostrazione in tal senso, nel processo civile arbitrale rituale.
Nella specie, ipotizzando che un soggetto creditore voglia far valere le sue ragioni nei riguardi di un altro soggetto, sia privato sia pubblico, ha piena facoltà di ricorrere al procedimento civile arbitrale rituale, ovvero quel procedimento che segue per il suo svolgimento le norme del codice di rito (senza alcuna eccezione) per la tutela dei diritti disponibili.
Infatti, il creditore può formulare ricorso ad un tribunale arbitrale (ex artt. 806 e ss. c.p.c.) che può essere un tribunale arbitrale costituito in forma specifica, come la Camera Arbitrale di Milano, la Camera Arbitrale Internazionale, ecc., oppure può nominare un giudice arbitrale (tra le persone di propria fiducia).
Si ricorda in questa sede che non è richiesto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale arbitrale alcun titolo professionale o accademico specifico.
Chi accetta l’incarico nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti si occuperà di svolgere il procedimento civile arbitrale secondo le norme del codice di rito afferenti agli istituti del procedimento monitorio.
Tutto questo sarà possibile soltanto se la controparte, ricevendo la notifica del procedimento arbitrale, decida di aderirvi; in caso contrario, l’azione civile arbitrale non è vincolante nei riguardi della controparte.
Se la parte debitrice decide di aderire al procedimento arbitrale, questo si svolgerà nelle forme degli artt. 633 e ss. c.p.c.¹, fermo restando l’applicazione degli istituti di natura processuale tipici del procedimento arbitrale ex artt. 806 e ss. c.p.c. e del relativo regolamento di attuazione (di natura contrattuale) sottoscritto dalle parti.
Il giudice arbitrale nominato dalla parte istante dovrà svolgere le proprie valutazioni sulla base della disciplina processuale che fa capo agli istituti degli artt. 633 e ss. c.p.c.
La differenza sostanziale con il procedimento monitorio “tradizionale” è che quest’ultimo si svolge in assenza di processo (salvo poi continuare tramite il deposito dell’opposizione da parte del debitore, iniziando una vera e propria lite civile che segnerà il passaggio in sede processuale), mentre il procedimento monitorio in arbitrato si svolge all’interno di una cornice processuale.
Infatti, il procedimento arbitrale rituale, a prescindere dalla tipologia di tutela apprestata ai richiedenti — sia essa di natura dichiarativa, esecutiva o cautelare (la quale è già stata ammessa per il suo svolgimento anche in arbitrato dalla recente riforma Cartabia sopra descritta) — si svolge sempre tramite un processo e si conclude sempre con una sentenza chiamata lodo arbitrale.
Il procedimento arbitrale prende inizio a seguito della sottoscrizione di una clausola compromissoria dalle parti (o di un apposito compromesso arbitrale) tramite il quale esse dichiarano di sottoporre ogni lite civilistica che possa sorgere tra loro — inerente un rapporto contrattuale o anche per dirimere una lite avente ad oggetto un credito non soddisfatto o un inadempimento contrattuale specifico — come previsto dalla disciplina del decreto ingiuntivo.
Con il deposito dell’istanza da parte del creditore, il giudice arbitrale deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 633 e successivi; il giudice (o i giudici, fino a un massimo di tre), nominato da entrambe le parti o, su richiesta di queste, dal tribunale arbitrale, potrà avere composizione monocratica o collegiale.
Quando il giudice arbitrale avrà valutato tutti gli elementi a sostegno della richiesta creditoria, si determinerà nell’esporre la sua valutazione attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo all’interno di una sentenza: il lodo arbitrale.
Ovviamente questa formalità non incide minimamente sui tempi e i modi tipici del procedimento monitorio, anzi in qualche modo li esalta.
Inoltre, è opportuno ricordare in questa sede che il lodo arbitrale ha valenza internazionale, a differenza della decisione in un procedimento monitorio tradizionale.
Questa tipologia di applicazione del procedimento monitorio ben si adatta alle transazioni e negoziazioni tra soggetti nazionali e controparti internazionali, proprio perché all’interno di tali accordi è possibile inserire la clausola compromissoria ove si prevede specificatamente che anche per quanto attiene i procedimenti monitori e cautelari — come oggi consentito dalla riforma Cartabia del 28 febbraio 2023, divenuta operativa con il D.Lgs. 149/2022, attraverso la modifica dell’art. 818 c.p.c.² — si rimanda alla giustizia arbitrale la loro tutela.
Quello sin qui descritto è solo un esempio di come possa trovare attuazione la soluzione terapeutica³ di natura ordinaria–arbitrale, ma possono esserci svariati ambiti in cui la stessa può trovare applicazione, ad esempio i contratti immobiliari, inserendo al loro interno la clausola compromissoria che specifichi che anche per quanto attiene i procedimenti monitori e cautelari le parti decidono di affidare la controversia ad un tribunale arbitrale.
In questo modo, in ogni caso, i tempi per ottenere la decisione di natura giurisdizionale sono sempre ridotti: infatti il procedimento arbitrale deve concludersi, salvo deroga delle parti, in 180 giorni dal ricevimento dell’istanza o ricorso da parte del soggetto proponente.
Se poi siamo in presenza di un procedimento monitorio all’interno di un procedimento civile arbitrale, allora potremo avere certezza che i tempi per il suo svolgimento saranno sicuramente rispettati a differenza di quanto avviene con il procedimento tradizionale, salvo questioni accidentali di natura improrogabile.
Anche nel procedimento civile arbitrale di natura monitoria può accadere che il debitore si opponga alla richiesta creditoria.
In questo caso, ipotizzando che si svolga un procedimento civile arbitrale per l’emanazione di un decreto ingiuntivo, il debitore che ha accettato di aderire al procedimento arbitrale per l’eventuale emanazione del decreto suddetto ha facoltà di promuovere, all’interno del procedimento arbitrale cui ha aderito, formale opposizione al decreto ingiuntivo (nelle forme e nei modi previsti dalle norme del codice di rito, nel rispetto però del regolamento arbitrale che regola l’intero procedimento) che è stato emesso dal giudice arbitrale, determinando in questo caso l’inizio della “causa” civile da svolgersi in arbitrato, essendo quest’ultima fondata sulla tutela di diritti disponibili.
Su quanto appena detto necessitano alcune specificazioni. Come abbiamo ricordato nel capo precedente, il procedimento arbitrale in materia di tutela di tipo monitorio può svolgersi soltanto se vi è l’adesione della controparte.
Nel caso in cui la controparte abbia aderito al procedimento arbitrale monitorio, ma nella clausola compromissoria non fosse stata specificata la circostanza eventuale di un successivo giudizio ordinario arbitrale seguente l’atto di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (emesso dal giudice arbitrale), si pone il seguente interrogativo: la parte debitrice aderente è obbligata a proseguire nel procedimento arbitrale instaurando, a seguito della propria opposizione, la causa civile all’interno dello stesso procedimento? Oppure ha facoltà di instaurare la causa civile presso una sezione del tribunale “tradizionale”?
Sul punto, a seconda dell’interpretazione — più o meno estensiva — si possono ipotizzare due soluzioni di principio, entrambe pienamente confacenti alle norme vigenti.
La prima è quella estensiva: nel caso di clausola compromissoria sottoscritta anche dalla parte debitrice, senza l’ulteriore previsione della fase di opposizione al pronunciamento monitorio, quest’ultima deve ritenersi obbligata a proseguire in regime di processo civile arbitrale per dirimere quest’ulteriore controversia, in forza della sua sottoscrizione della clausola compromissoria ad oggetto la tutela monitoria, la quale al suo interno ricomprende — almeno in linea puramente teorica — anche la fase oppositiva.
A sostegno di quest’ipotesi vi è il fatto innegabile che la parte debitrice, che decide di partecipare al procedimento de quo nelle forme del processo arbitrale, è stata informata (o si è informata) su quelle che sono le possibili conseguenze dell’emissione del decreto monitorio, in questo caso del decreto ingiuntivo, e soprattutto si presume che la stessa sia consapevole delle norme del processo civile arbitrale e di cosa comporti la sottoscrizione della clausola compromissoria.
Pertanto, se la parte debitrice non richiede espressamente all’altra parte di inserire, all’interno della clausola compromissoria, la specificazione relativa all’eventuale circostanza attinente l’opposizione al decreto ingiuntivo (che la stessa chiede di depositare presso il tribunale “tradizionale”), non vi è motivo di ritenere — anche in ragione del fatto che, anche in questo caso, siamo in presenza di “diritti disponibili” — che la parte eventualmente opponente possa recriminare, adducendo come motivazione la propria mancata accettazione espressa in clausola compromissoria del proseguimento della trattazione della controversia sempre nelle forme del procedimento civile arbitrale, in quanto ella stessa aveva avuto la possibilità, essendo a conoscenza di ogni conseguenza giuridica relativa al procedimento in parola, di far inserire tale previsione, se davvero l’avesse voluto.
Sulla base di quanto ipotizzato, per fatti concludenti, l’omissione di tale richiesta da parte dell’opponente deve valutarsi, in termini di scienza giuridica, come silenzio–assenso, e quindi la stessa deve ritenersi obbligata a proseguire nello stesso procedimento arbitrale, instaurando la causa civile innanzi allo stesso giudice arbitrale tramite la propria opposizione al decreto ingiuntivo, essendole preclusa la possibilità di adire altre sezioni del tribunale “tradizionale” per questioni oggetto di un procedimento già pendente presso altro organo giurisdizionale (quale è appunto il giudice arbitrale), ex art. 819-ter c.p.c.
La seconda ipotesi interpretativa è di segno negativo, ovvero riconosce alla parte debitrice che aveva aderito al procedimento arbitrale, sottoscrivendo la clausola compromissoria ove non era specificato il proseguimento in sede arbitrale della fase oppositiva conseguente all’emissione del decreto de quo, di poter instaurare un procedimento civile — quindi la causa — a seguito dell’atto oppositivo, presso altra sezione del tribunale “tradizionale”.
Da un punto di vista strettamente giuridico, quest’ipotesi potrebbe essere applicabile, se si vuole considerare non assorbente dell’eventuale fase oppositiva la clausola compromissoria (relativa alla tutela giurisdizionale anche in relazione a procedimenti monitori e cautelari) sottoscritta dall’opponente.
Sulla scorta di tale interpretazione, in scienza e coscienza, chi scrive non ritiene possa essere concretamente fattibile tale ipotesi, in virtù della forza giuridica determinata dalla cosciente e volontaria omissione da parte dell’opponente, che avrebbe avuto tempo e modo di far inserire l’ipotesi in commento in sede contrattuale, all’interno della clausola compromissoria.
Quindi, proprio la sottoscrizione di tale clausola sic stantibus rebus determina in fatto e in diritto l’impossibilità per la stessa di sottrarsi alla disciplina arbitrale.
In ogni caso, non è questa la sede per disquisire sui vizi del consenso in materia contrattuale che la stessa parte “ipotetica” può invocare a propria difesa, ma in ogni caso lo farebbe in un procedimento disgiunto e parallelo a quello in cui ella è parte e che, nel rispetto della clausola compromissoria, è tenuta a proseguire sino a sentenza definitiva, ovvero sino al lodo arbitrale.
A conclusione di quest’analisi, ricordiamo che il processo arbitrale, qualunque ne sia la motivazione che lo instauri, non prevede appello: si svolge in unico grado.
Anche in relazione al caso di specie oggetto di quest’analisi, la sentenza arbitrale — ovvero il lodo —, sulla base del riconoscimento di sentenza giurisdizionale anche in materia di esecutività degli atti giudiziali, segue le norme del codice di rito e, in relazione alla tematica in commento, in base a quanto previsto dal rinnovato art. 475 c.p.c., prevede, ai fini dell’esecuzione forzata, che non è più necessario ottenere la formula esecutiva, essendo quindi sufficiente munirsi di una copia del titolo emesso dall’organo giudiziale — e pertanto anche dal tribunale arbitrale (sentenza, provvedimento, atto pubblico) — attestata conforme all’originale.
1.3. Considerazioni finali
Per chi scrive, è innegabile che il procedimento civile arbitrale, se realmente applicato, possa realmente costituire un baluardo di giustizia civile che tanto serve al fine di riuscire a prevenire il carico di procedimenti pendenti presso le cancellerie dei tribunali “tradizionali”.
Ma il processo civile arbitrale riveste un’importanza ancora maggiore: rappresenta infatti un modello di giurisdizione realmente accessibile a tutti, che si può svolgere anche a costo pari a zero, se consideriamo che il giudice civile arbitrale designato dalle parti può svolgere il proprio incarico anche pro bono.
Inoltre, si ricorda in questa sede che il processo arbitrale si svolge in un tempo già prestabilito e, per controversie di valore moderato, può anche svolgersi in una sola udienza, oltre alla possibilità di svolgersi interamente da remoto, con le parti coinvolte collegate comodamente da casa o da altro luogo, senza obbligo di recarsi in aula.
In più, il procedimento arbitrale consente alle parti di farsi assistere da chiunque queste ritengano degno della loro fiducia, senza alcun obbligo per chi si incarica di tale assistenza di possedere titoli di studio o requisiti professionali.
In altri termini, il procedimento civile arbitrale rappresenta quel tipo di processo “democratico”, sino ad ora tanto sperato dai consociati, ma rimasto inattuato a causa di giuristi eretici che hanno sempre negato la valenza di detto procedimento.
In relazione al tema discusso in questa sede, ovvero dell’applicazione del procedimento monitorio in sede di processo arbitrale, appare evidente come questo possa realmente cambiare le prospettive della giustizia civile italiana.
Infatti, la stragrande maggioranza di controversie civili pendenti si riferiscono proprio a questo tipo di controversie che hanno ad oggetto la tutela dei diritti disponibili, e pertanto la celerità del procedimento arbitrale può segnare un percorso di modernizzazione delle prassi giudiziarie, restituendo ai cittadini uno strumento super efficace e risolutivo per le loro controversie di matrice civile.
Quanto oggetto dell’analisi sin qui proposta è solo una piccola dimostrazione delle potenzialità e dell’effettiva utilità dell’istituto arbitrale rituale che, per sua natura, in quanto procedimento ordinario ad ogni effetto di legge, si presta alla trattazione di ogni controversia di natura civile: ad oggi relativa ai diritti disponibili, domani — si spera — anche per la tutela di ogni altro diritto dei consociati.
Note
¹ Art. 633 c.p.c. – “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili…” – [G.U.: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/]
² Art. 818 c.p.c. – “Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari…” – [G.U.: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/]
³ Tripodi C., Affermazione del giudice arbitrale quale organo naturale ex tunc di giurisdizione ordinaria statale e riconoscimento di annesso status di pubblico ufficiale: soluzioni terapiche a fenomeni antinomici invalidanti, Diritto.it, 2020. [https://www.diritto.it/affermazione-del-giudice-arbitrale-quale-organo-naturale-ex-tunc-di-giurisdizione-ordinaria-statale-e-riconoscimento-di-annesso-status-di-pubblico-ufficiale-soluzioni-terapiche-a-fenomeni/]
Avv. Cristiano Tripodi
Ultimi post di Avv. Cristiano Tripodi (vedi tutti)
- Il decreto ingiuntivo: nuove prassi operative all’interno del procedimento di arbitrato - 28 Settembre 2025
- L’udienza preliminare: analisi degli istituti processuali e critica delle prassi applicative illegittime - 21 Settembre 2025
- Il procedimento civile arbitrale: trattamento elettivo su domanda giudiziale ex art. 216 c.p.c. - 4 Aprile 2024







