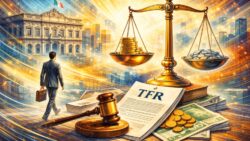Le dimissioni tacite nella riforma del 2025: paradossi giuridici e tutela del lavoratore
Abstract. La riforma del 2025 introduce nell’ordinamento italiano le dimissioni tacite, equiparando l’assenza protratta oltre quindici giorni a un recesso volontario, senza manifestazione di volontà del lavoratore. L’articolo analizza la portata giuridica della norma, il suo impatto sulla libertà contrattuale e sulla tutela previdenziale, le implicazioni per i lavoratori fragili e il confronto con ordinamenti esteri, evidenziando le tensioni tra autonomia individuale e esigenze di certezza organizzativa.
***
La riforma del 2025 ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura delle dimissioni tacite, ossia la possibilità che l’assenza protratta dal lavoro integri una rinuncia al rapporto di lavoro.
L’istituto appare immediatamente come un paradosso sistemico: attribuisce efficacia dispositiva al silenzio, sovvertendo il principio della volontà espressa, da sempre cardine del diritto del lavoro e della tutela previdenziale.
La riforma de qua costringe a riflettere sul rapporto tra libertà del lavoratore, autonomia negoziale e esigenze di bilancio, ma soprattutto ci interroga sulla capacità del diritto di trasformare un comportamento omissivo in una scelta consapevole, quando la volontà reale potrebbe non esserci. Tradizionalmente, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio del lavoratore, disciplinato dall’art. 2118 c.c., che riconosce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini stabiliti dagli usi o secondo equità.
In questa prospettiva, le dimissioni costituiscono un atto dispositivo, espressione della libertà contrattuale del prestatore, che si manifesta all’interno di un contesto segnato da una asimmetria di potere intrinseca al rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza ha sempre insistito sulla necessità che la volontà del lavoratore fosse chiara, inequivoca e consapevole, perché senza di essa il recesso perde la sua natura di atto autonomo e rischia di diventare simulazione o artificio.
Con l’entrata in vigore della L. 203/2024, art. 19, il paradigma cambia radicalmente. L’assenza ingiustificata protratta oltre quindici giorni viene automaticamente equiparata a dimissioni, senza alcuna manifestazione di volontà da parte del lavoratore.
La legge, in questo modo, trasforma il comportamento omissivo in atto dispositivo, creando una presunzione iuris et de iure che si impone sulla realtà dei fatti; ciò genera un effetto paradossale: l’assenza, che spesso è frutto di difficoltà personali, emergenze familiari o fragilità, diventa di fatto scelta, e il silenzio diventa parola.
Il confronto con la disciplina previgente rende chiara la portata della trasformazione. In passato, il diritto italiano richiedeva che le dimissioni fossero espresse e convalidate, procedure telematiche e formali che garantivano autenticità e tracciabilità.
La volontà doveva essere manifesta, registrata e verificabile; l’autonomia contrattuale del lavoratore era tutelata come principio fondamentale.
Oggi, invece, la legge presume la volontà, invertendo il rapporto tra soggetto e norma: non è più il lavoratore a determinare la cessazione, ma la legge stessa, che decide per lui quando l’assenza supera un limite prestabilito.
La ratio della riforma appare duplice.
Da un lato, il legislatore mira a garantire certezza organizzativa al datore di lavoro e contenere la spesa pubblica; dall’altro, tenta di contrastare abusi e comportamenti elusivi nell’accesso alla NASpI. Tuttavia, questa impostazione entra in evidente tensione con la funzione di protezione del lavoratore come parte debole: la presunzione di volontà può colpire chi si trova in situazioni di fragilità, trasformando il bisogno in colpa e la vulnerabilità in scelta volontaria.
La dottrina ha osservato che le dimissioni tacite si collocano in un’area ambigua tra atto unilaterale implicito, presunzione legale relativa e finzione giuridica.
Se fossero considerate atto implicito, si tratterebbe di un recesso desumibile dai comportamenti omissivi; se si optasse per la presunzione legale, il lavoratore dovrebbe superare un onere probatorio gravoso per dimostrare che non ha inteso recedere; se, infine, si accettasse la qualificazione come finzione giuridica, la norma apparirebbe in contraddizione con i principi costituzionali che tutelano la disoccupazione involontaria e la libertà contrattuale.
In ogni caso, l’effetto è lo stesso: la legge attribuisce efficacia dispositiva al silenzio, comprimendo la libertà individuale e sostituendo la volontà presunta a quella reale.
Il confronto internazionale conferma l’eccezionalità della disciplina italiana.
In Francia, l’abandon de poste integra un illecito disciplinare, non costituisce dimissioni; in Germania, l’assenza ingiustificata attiva un procedimento disciplinare con eventuale licenziamento, preservando la centralità della volontà; nel Regno Unito, la constructive dismissal presuppone una condotta datoriale grave, mai inerzia del lavoratore. In nessun ordinamento avanzato il silenzio genera automaticamente dimissioni, rendendo la normativa italiana isolata e potenzialmente problematica sotto il profilo dei principi di autonomia e libertà. Le implicazioni sul piano previdenziale sono altrettanto rilevanti.
La disciplina vigente esclude le dimissioni tacite dall’accesso alla NASpI, accentuando la marginalizzazione dei lavoratori più fragili e precari.
La combinazione tra presunzione di volontà e restrizione contributiva crea un effetto cumulativo: il lavoratore perde il rapporto e contestualmente la copertura sociale, trasformando la fragilità in responsabilità. Le dimissioni tacite, in conclusione, rappresentano un vero paradosso giuridico: atto senza manifestazione, volontà presunta, libertà compressa in vincolo. Pur perseguendo obiettivi di certezza e contenimento della spesa, la norma solleva questioni profonde di legittimità e coerenza sistemica.
L’ordinamento si trova a confrontarsi con la tensione tra autonomia del lavoratore e imposizione normativa, tra efficienza amministrativa e giustizia sociale.
L’unica via per conciliare queste istanze consiste nell’introdurre procedure di verifica della volontà, prevedere clausole di salvaguardia per assenze legittime e rivedere i requisiti NASpI, riportando così la norma entro il perimetro della protezione reale della persona che lavora, senza trasformare fragilità e bisogno in scelta volontaria.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Aldo Andrea Presutto
Avvocato & DPO
Ultimi post di Aldo Andrea Presutto (vedi tutti)
- TFR e indennità risarcitoria nel pubblico impiego: la Corte costituzionale chiarisce con la sentenza n. 144/2025 - 26 Dicembre 2025
- Disabilità e licenziamento per comporto: la sentenza CGUE C-5/24 tra diritto dell’Unione e ordinamento interno - 16 Dicembre 2025
- TFR: la retribuzione che resiste. Natura, funzione e tutela del credito di lavoro - 8 Dicembre 2025