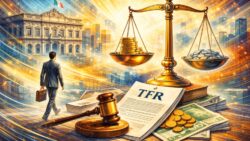Mercato del lavoro e politiche attive: tra evoluzione normativa, intermediazione e nuove vulnerabilità occupazionali
Sommario: 1. Il diritto al lavoro tra garanzie costituzionali e crisi occupazionali – 2. Dalla gestione pubblica al pluralismo dell’intermediazione – 3. Politiche attive e disuguaglianze: limiti di sistema e lavoro sommerso – 4. Conclusioni: un diritto del lavoro in cerca di equilibrio tra efficienza e dignità
1. Il diritto al lavoro tra garanzie costituzionali e crisi occupazionali
Il diritto del lavoro, nella sua concezione più ampia, non si esaurisce nella regolamentazione del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, ma si estende alla funzione proattiva dello Stato nell’assicurare l’accesso al lavoro.
L’articolo 4 della Costituzione italiana[1], nel sancire il diritto al lavoro e il dovere della Repubblica di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo, affida alla materia de qua una missione che supera la dimensione privatistica per inserirsi in quella pubblicistica e sociale.
In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche, il lavoro è diventato un bene scarso e non garantito, soprattutto per le nuove generazioni.
Aumentando i divari tra giovani disoccupati e lavoratori stabilizzati, si va accentuando il cosiddetto “conflitto generazionale” che mette in crisi l’impianto classico della tutela lavoristica. L’evoluzione del mercato del lavoro impone quindi al legislatore di agire su un piano duplice: da un lato conservare e rafforzare le tutele esistenti, dall’altro predisporre strumenti giuridici idonei a promuovere l’occupazione.
In questo quadro si inseriscono le politiche attive del lavoro, che rappresentano la strategia più concreta per dare attuazione al diritto sancito nel richiamato art. 4. Esse si propongono di accompagnare il lavoratore, e in particolare il disoccupato, in un percorso di (re)inserimento attraverso formazione, orientamento e strumenti di sostegno all’occupabilità.
In tale ottica, il diritto del lavoro assume un ruolo strategico nel governare l’incontro tra domanda e offerta, nell’evitare l’esclusione sociale e nell’adattarsi alla velocità del cambiamento economico.
2. Dalla gestione pubblica al pluralismo dell’intermediazione
Storicamente, il sistema italiano di collocamento si è fondato su un modello rigidamente pubblico. Dopo la seconda guerra mondiale, venne istituito un sistema di collocamento pubblico monopolistico, gestito dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione, su base provinciale. Tali uffici avevano il compito di gestire le liste di avviamento e garantire un’equa distribuzione delle opportunità lavorative.
Le imprese, per assumere personale, erano obbligate a presentare una richiesta numerica (ad esempio: tre muratori, due segretarie), sulla base della quale gli uffici inviavano i nominativi dei lavoratori iscritti nelle relative graduatorie. Il principio ispiratore era quello dell’imparzialità, dell’oggettività e della trasparenza nell’accesso al lavoro.
Tuttavia, questo sistema si è progressivamente rivelato inadeguato di fronte ai profondi cambiamenti del mercato.
A partire dagli anni Settanta, l’aumento del livello medio di istruzione, l’emergere di nuove professionalità e la spinta alla competitività hanno richiesto una maggiore selettività e una maggiore aderenza tra i profili dei candidati e le esigenze produttive. Si è così affermata la richiesta nominativa, che ha consentito alle imprese di scegliere i candidati sulla base di criteri professionali specifici. Parallelamente, la gestione del collocamento è stata decentralizzata alle autonomie locali, ritenute più idonee a interpretare le esigenze del territorio. In questo processo si è mantenuto un assetto pubblicistico, ma con un graduale superamento del monopolio.
La svolta è arrivata con la sentenza “Job Centre” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[2], la quale ha affermato che l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro costituisce un servizio economico soggetto al principio di libera concorrenza. La conseguenza di questa impostazione è stata l’impossibilità di mantenere il monopolio pubblico dell’intermediazione.
Il diritto interno ha dovuto quindi aprirsi alla liberalizzazione dei servizi per l’impiego, affiancando ai centri pubblici operatori privati accreditati. Con il tempo, questa apertura è stata recepita in modo sistematico. Il D.Lgs. 150/2015[3], attuativo del Jobs Act, ha rappresentato un punto di approdo normativo importante: ha riformato in senso moderno l’intera disciplina dei servizi per l’impiego, conferendo centralità alla cooperazione tra soggetti pubblici e privati e riformulando anche la definizione di disoccupazione.
Non basta più la mera iscrizione nelle liste: per mantenere lo status di disoccupato è necessario partecipare attivamente alle iniziative di formazione e ricollocamento[4]. Il disoccupato che non collabora con i servizi viene escluso dal circuito delle tutele, con un chiaro segnale di responsabilizzazione del lavoratore nel percorso di reinserimento.
3. Politiche attive e disuguaglianze: limiti di sistema e lavoro sommerso
Le politiche attive del lavoro, come strumento per promuovere l’occupabilità, si basano su percorsi personalizzati di formazione, riqualificazione e inserimento. L’obiettivo è creare le condizioni perché il lavoratore disoccupato possa rientrare nel mercato del lavoro con nuove competenze, adattabili alle esigenze produttive.
Questo approccio, tuttavia, incontra numerose criticità strutturali. La frammentazione delle competenze tra Stato, Regioni e enti accreditati, le diseguaglianze territoriali, la scarsità di risorse e la difficoltà di progettare percorsi efficaci mettono in discussione l’effettività di queste misure. In particolare, i lavoratori anziani, espulsi da settori in crisi, incontrano ostacoli insormontabili alla ricollocazione. Spesso finiscono per essere esclusi sia dal lavoro regolare sia dalle misure di sostegno, cadendo in forme di lavoro grigio o nero.
In questo scenario si colloca il fenomeno del caporalato, espressione patologica del mercato del lavoro, diffuso soprattutto nei settori agricolo e logistico, ma non solo. Il caporalato si configura come una forma di intermediazione illecita, in cui il caporale – soggetto terzo – recluta e gestisce la forza lavoro per conto di un datore occulto.
Il lavoratore viene così sottratto alle garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, e il datore effettivo si nasconde dietro l’interposizione. Già la legge n. 1369/1960[5] aveva previsto il divieto di interposizione non qualificata di manodopera, ammettendo un’unica eccezione: il contratto di appalto, definito dall’art. 1655 c.c. come prestazione d’opera con mezzi organizzati propri e assunzione del rischio d’impresa.
Tuttavia, questa deroga è stata frequentemente abusata attraverso falsi appalti, in cui l’appaltatore si limitava a fornire manodopera, mentre il potere direttivo restava in capo al committente. In tali ipotesi, la legge riteneva sussistente il rapporto diretto tra i lavoratori e il committente, con il riconoscimento pieno di tutte le tutele.
Con l’abrogazione della legge 1369/1960 da parte del D.Lgs. 276/2003[6] (riforma Biagi), il legislatore ha riconosciuto la legittimità di diverse forme di intermediazione, tra cui la somministrazione di lavoro, a condizione che siano rispettati precisi requisiti formali e sostanziali. L’art. 29 del suddetto decreto, inoltre, ha ridefinito il contratto di appalto, precisando che è sufficiente che l’appaltatore eserciti il potere organizzativo, anche in assenza di mezzi propri.
È stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e appaltante in relazione alle retribuzioni, ai contributi e agli obblighi assicurativi. Tuttavia, questo non è bastato a garantire una reale parità di trattamento tra i lavoratori “interni” e quelli degli appaltatori. In molti casi, infatti, si utilizza l’appalto come strumento di compressione dei diritti, favorendo un dumping contrattuale.
Proprio per contrastare le forme più gravi di sfruttamento, il legislatore ha introdotto la fattispecie penale di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., che sanziona l’intermediazione abusiva e lo sfruttamento dei lavoratori, anche in presenza di apparente liceità contrattuale.
4. Conclusioni: un diritto del lavoro in cerca di equilibrio tra efficienza e dignità
L’evoluzione del mercato del lavoro impone al diritto del lavoro di ripensarsi continuamente, per non restare vincolato a modelli obsoleti e per rispondere con efficacia alle nuove forme di vulnerabilità.
Il passaggio da un sistema centrato sulla stabilità a un modello fondato sull’occupabilità implica un cambio di paradigma, che rischia però di scaricare sul lavoratore la responsabilità della propria esclusione. Le politiche attive, seppur essenziali, devono essere realmente accessibili, efficaci e personalizzate, altrimenti restano misure formali.
La lotta al lavoro irregolare, al caporalato e agli abusi dell’appalto richiede un equilibrio tra flessibilità organizzativa e tutela sostanziale dei diritti. Il diritto del lavoro del presente non può scegliere tra efficienza e giustizia, tra dinamismo e protezione: deve saperli tenere insieme, riaffermando il lavoro come fattore di inclusione, dignità e coesione sociale.
In questo senso, le politiche pubbliche e la disciplina giuslavoristica sono chiamate a una rinnovata responsabilità costituzionale.
[1] L’articolo 4 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ogni cittadino, inoltre, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e scelte, un’attività o funzione che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società.
[2] Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 dicembre 1997. – Job Centre coop. arl. – Causa C-55/96.
[3] Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
[4] Marco Esposito e AA. VV., Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, p. 17 e ss., G. Giappichelli, Torino, 2013-2014.
[5] Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi.
[6] Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Andrea Bacchi
Andrea Bacchi è dottore in giurisprudenza e praticante avvocato. Impegnato nelle aule di giustizia, coniuga la pratica forense con una profonda passione per il diritto, che lo spinge a riflettere, approfondire e condividere i propri pensieri attraverso la scrittura. Il suo obiettivo è quello di contribuire al dibattito giuridico con spirito critico e rigore professionale.