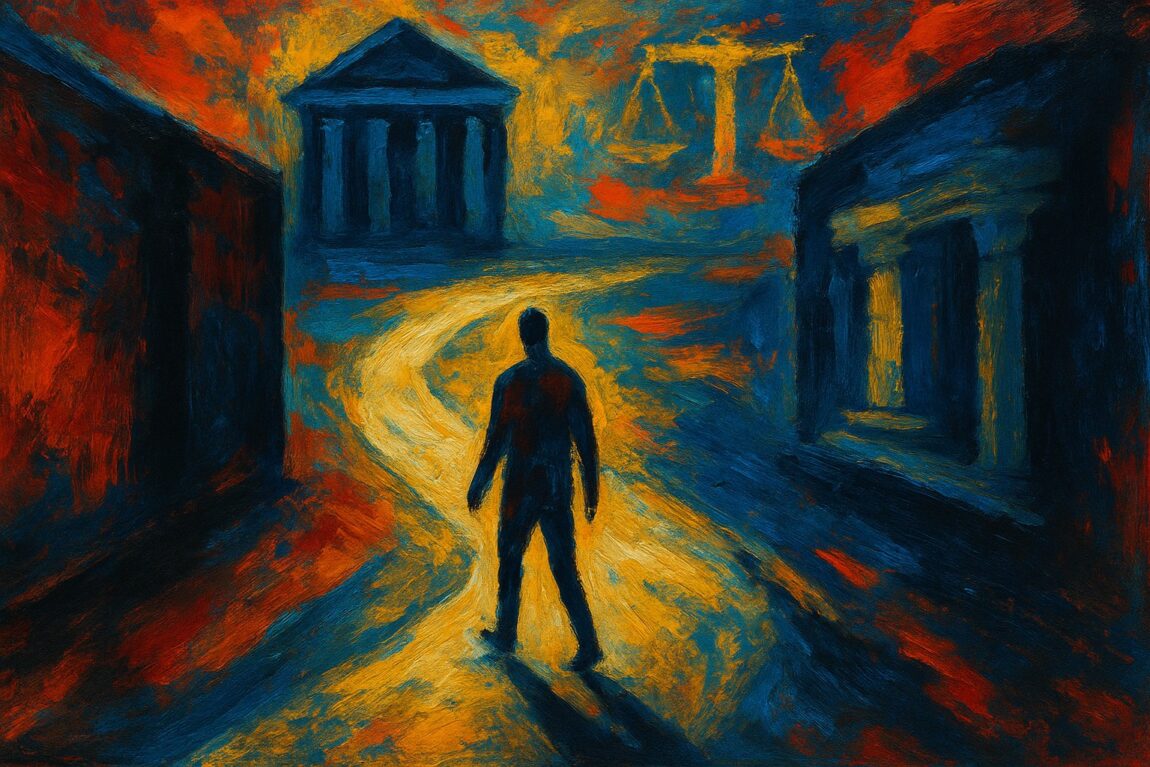
I caratteri degli interessi legittimi nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
Sommario: 1. Premessa: la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo – 2. Il carattere relazionale e qualificato dell’interesse legittimo – 3. Il dibattito sulla natura del potere amministrativo: autoritarietà, discrezionalità e infungibilità – 4. L’interesse legittimo come posizione di diritto sostanziale – 5. L’elaborazione giurisprudenziale e la centralità dei criteri di differenziazione e qualificazione – 6. Conclusione: una posizione giuridica complessa ma essenziale
1. Premessa: la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo
La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo rappresenta uno dei punti cardine del diritto amministrativo italiano. Tale distinzione non è meramente accademica, ma incide profondamente sulla natura della tutela giurisdizionale, sulle modalità di esercizio del potere pubblico e sull’effettività della posizione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Mentre il diritto soggettivo è una situazione giuridica attiva pienamente tutelata in ogni sede e opponibile a chiunque, l’interesse legittimo è una posizione giuridica relativa, correlata all’esercizio del potere pubblico, e riconosciuta a determinati soggetti in specifici rapporti con l’amministrazione.
2. Il carattere relazionale e qualificato dell’interesse legittimo
Secondo una delle elaborazioni più consolidate, l’interesse legittimo si caratterizza per la sua relazionalità: non si tratta di una situazione soggettiva autonoma, ma di una posizione giuridica la cui esistenza dipende dalla presenza e dall’esercizio del potere amministrativo. A differenza dei diritti reali, che sussistono indipendentemente dalla volontà o dal comportamento altrui, l’interesse legittimo emerge solo in presenza di un’attività amministrativa, potenzialmente incidente su una sfera giuridica soggettiva.
Un altro carattere essenziale è la qualificazione dell’interesse: non qualsiasi cittadino è titolare di un interesse legittimo, ma solo colui che si trovi in una posizione diversa dalla generalità, individuabile attraverso i criteri della differenziazione e della qualificazione. Questo significa che l’interesse legittimo è una posizione soggettiva determinata, spettante solo a coloro per i quali l’attività amministrativa assume rilevanza diretta e specifica.
3. Il dibattito sulla natura del potere amministrativo: autoritarietà, discrezionalità e infungibilità
Molte teorie hanno cercato di fondare la natura dell’interesse legittimo sull’essenza del potere amministrativo. Alcuni autori lo hanno legato alla autoritatività del potere, cioè alla sua capacità di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei cittadini. Altri hanno posto l’accento sulla discrezionalità: solo laddove l’amministrazione gode di margini valutativi e decisionali, si potrebbe parlare di interesse legittimo.
Queste tesi sono però limitate, come dimostrano i casi di potere vincolato: anche quando l’amministrazione è tenuta a una sola determinata scelta, è comunque possibile che il cittadino subisca una lesione di un proprio interesse legittimo.
Un’altra teoria ha messo in evidenza l’infungibilità del potere amministrativo, ossia la sua riserva in capo a soggetti pubblici istituzionalmente competenti. Questa lettura porta a considerare l’interesse legittimo come posizione di dipendenza istituzionale: il cittadino, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione, si trova subordinato a essa, e può soltanto reagire a posteriori.
4. L’interesse legittimo come posizione di diritto sostanziale
Una concezione ormai superata sosteneva che l’interesse legittimo avesse natura esclusivamente processuale, utile solo a fondare la legittimazione all’impugnazione degli atti amministrativi. Secondo questa visione, l’interesse legittimo esisterebbe solo in presenza di una lesione, limitando la sua consistenza alla fase contenziosa.
Tale concezione è stata superata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, in particolare alla luce della legge n. 241/1990, che riconosce diritti partecipativi e procedimentali anche prima dell’adozione dell’atto. In questo senso, l’interesse legittimo assume una chiara valenza sostanziale, che si manifesta già nel corso del procedimento amministrativo, e non solo nel momento dell’impugnazione del provvedimento lesivo.
5. L’elaborazione giurisprudenziale e la centralità dei criteri di differenziazione e qualificazione
In assenza di una definizione legislativa precisa, è stata la giurisprudenza – in particolare quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato – a individuare i tratti distintivi dell’interesse legittimo.
I due criteri guida sono:
– Differenziazione: l’interesse legittimo deve distinguersi dalla posizione della collettività generica. È quindi un interesse particolare e specifico.
– Qualificazione: tale interesse deve essere riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento, non in via generica, ma sulla base di una specifica norma o previsione che lo prenda in considerazione.
Questi due criteri, pur non risolvendo ogni ambiguità, costituiscono il fondamento principale per stabilire la titolarità dell’interesse legittimo.
6. Conclusione: una posizione giuridica complessa ma essenziale
L’interesse legittimo non è una posizione minore rispetto al diritto soggettivo, ma una forma diversa di tutela dell’individuo rispetto al potere pubblico. La sua rilevanza non è più confinata alla sede processuale, ma si estende all’intero procedimento amministrativo, dalla fase iniziale fino all’eventuale contenzioso.
Alla luce dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si può affermare che l’interesse legittimo è una posizione soggettiva qualificata, differenziata e sostanziale, funzionale alla garanzia dell’equilibrio tra autorità e libertà nel rapporto tra cittadino e amministrazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Riccardo Renzi
Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.
Ultimi post di Riccardo Renzi (vedi tutti)
- La motivazione del provvedimento amministrativo: una garanzia sostanziale di legalità, trasparenza e partecipazione - 27 Dicembre 2025
- Contratti attivi e affidamento nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato: verso una nuova stagione di legalità amministrativa - 2 Novembre 2025
- Il principio del tempus regit actum e la legittimità del deposito cauzionale per i ripristini stradali: tra potestà regolamentare e tutela del bene pubblico - 26 Ottobre 2025







