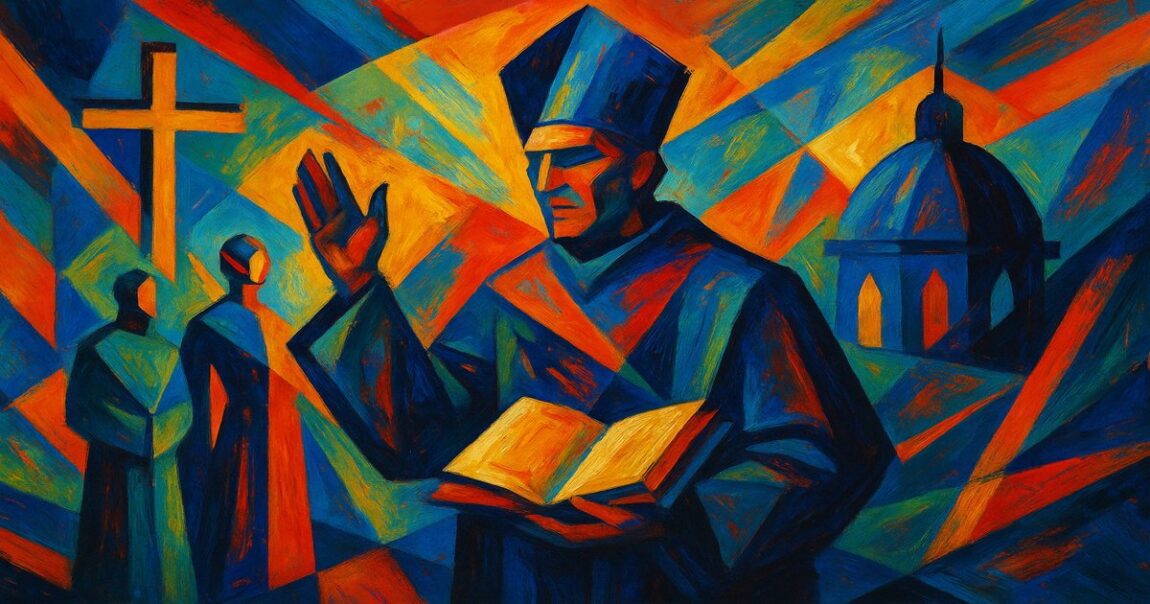
I ministri di culto: tra ordinamento civile e penale
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il ministro di culto nel diritto italiano – 3. Ministri di culto nell’ordinamento civile – 3.1. L’atto di matrimonio – 3.2. Il testamento – 4. Status e prerogative del ministro di culto – 5. Le incompatibilità – 6. Trattamento e previdenza – 7. I ministri del culto nell’ordinamento penale – 8. I reati – 9. Il segreto ministeriale
1. Introduzione
L’ordinamento giuridico italiano attribuisce e riconosce rilievo a talune qualificazioni specifiche confessionali quali quella di ecclesiastico, di religioso, di chierico, di vescovo, di sacerdote… stante che tali a soggetti, nell’ambito delle rispettive comunità, corrispondono specifiche attribuzioni individuate e regolate dal diritto di ciascuna confessione.
Ora, tale riconoscimento e rilievo viene fatto attraverso norme dettate unilateralmente dallo stato, per esigenze di “comunità civile” e attraverso norme che derivano dall’esecuzione di accordi ed intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
C’è da fare un’importante distinzioni tra ecclesiastico, religioso e ministro del culto giacchè quando si fa riferimento alla prima figura, l’ordinamento statale si riferisce a coloro che, nell’ordinamento canonico, hanno ricevuto l’ordine sacro ovvero i vescovi e i presbiteri; con il termine religioso si indicano i fedeli cattolici che professano il voto di obbedienza, carità e povertà, in un istituto religioso o di vita consacrata e, infine, i ministri di culto.
2. Il ministro di culto nel diritto italiano
La nozione di ministro di culto è per lo più laica.
Con il termine ministro di culto, coniato non dall’ordinamento confessionale bensì da quello statale secondo la dottrina, una definizione civilistica che, nel sistema della legislazione pattizia ovvero nell’ Accordo di Villa Madama e nelle Intese, viene attribuita sulla base del potere certificativo riconosciuto alle Autorità confessionali che rimangono libere da qualsiasi ingerenza dello Stato. Invero, la norma statale non definisce chi sia o chi possa essere il ministro di culto ma assume la qualifica confessionale a presupposto per la rilevanza civile di alcuni atti compiuti dai ministri di culto o per la tutela di particolari diritti connessi a siffatta condizione.
La nozione civilistica di ministro di culto sembrerebbe essere una nozione così complessa per la ricorrenza di tre elementi ovvero l’appartenenza del soggetto ad un gruppo qualificabile nel diritto dello Stato come confessione religiosa, lo svolgimento di una attività di cui il soggetto è incaricato qualificabile nel diritto dello Stato come esercizio di ministero ossia avente natura ministeriale e una concreta investitura del soggetto da parte del gruppo religioso[1].
Infine, c’è da dire che, è possibile che lo Stato non riconosca la qualifica di ministro di culto di un soggetto che è ritenuto tale dalla confessione religiosa di appartenenza. In particolare, per le confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato italiano non ci è alcun problema stante che le intese stesse prevedono che la qualifica di ministro del culto si acquista con la nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza senza alcun tipo di ingerenza da parte dello Stato; viceversa, per le confessioni religione prive di intesa, si richiede l’approvazione della nomina da parte del Governo.[2] A tale ultimo proposito, si osservano le regole della L. 1159/1929, che all’art. 3 prescrive un obbligo di notificazione al Ministero dell’Interno per l’approvazione, con la precisazione che “nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa”.
3. Ministri di culto nell’ordinamento civile
Per quanto riguarda i ministri di culto della Chiesa cattolica, vige il criterio dell’autoreferenzialità, disciplinato nell’art. 3 co. 2 del Concordato (legge 121/1985), sulla base del quale “la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica”. Vi è un onere a capo delle autorità ecclesiastiche ovvero l’obbligo di “comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolati di altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento della Stato”.
Il nostro ordinamento riserva particolare attenzione alla qualifica di ministro di culto quando questi è chiamato a svolgere funzioni o attività cui l’ordinamento giuridico riconosce rilevanza civile.
Più nel dettaglio, sono 2 gli atti a cui è riservata particolare attenzione, l’atto di matrimonio e il testamento.
Questi possono essere redatti dal ministro di culto e successivamente trasmessi all’ufficiale di stato civile e, nel far ciò, il ministro di culto adempie ad una pubblica funzione certificativa e pertanto assume la veste di pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda l’atto di matrimonio è necessario in primis riconoscere l’esistenza di tre diversi tipi di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio celebrato dal ministro di culto di una confessione acattolica, che rappresenta una variante del matrimonio civile.
Lasciando stare il matrimonio civile, vengono in considerazione le fonti che regolano le altre due tipologie ovvero il matrimonio concordatario, che è disciplinato dal Concordato lateranense del 1929 e dal successivo Accordo di revisione del 1984 e i matrimoni acattolici di confessioni dotate di Intesa con lo Stato italiano che sono regolati dalle leggi di attuazione delle intese stesse. Da ultimo, i matrimoni acattolici di confessioni privi di intese restano regolati dalla “legge sui culti ammessi” che, come sopra detto, sono regolati dalla L. 1159/1929 e dal R. D. 289/1930 attuativo della stessa.
3.1. L’atto di matrimonio
Le norme menzionate, riconoscono una serie di adempimenti in capo al ministro di culto necessari affinché l’atto di matrimonio acquisti efficacia civilistica.
In primo luogo il ministro è tenuto, una volta prodotti dai futuri coniugi tutti i documenti necessari, a redigere e rilasciare la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale e, durante la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 143,144,147 del c.c., relativi a diritti e doveri dei coniugi e deve ottenere da entrambe le parti la dichiarazione di volontà di prendersi in marito e in moglie, in presenza di due testimoni.
Egli, è inoltre tenuto a redigere l’atto in lingua italiana secondo le norme stabilite per la formazione degli atti di stato civile ed infine, deve trasmettere l’originale dell’atto all’ufficiale di stato civile entro 5 dalla celebrazione per la trascrizione dell’atto stesso.
3.2. Il testamento
Con riferimento all’atto testamentario il ministro di culto assume la qualifica di pubblico ufficiale nell’ipotesi prevista dall’art.609 c.c. in materia di testamenti speciali.
La norma menzionata stabilisce che “quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da notaio (…) o da un ministro di culto in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni”.
4. Status e prerogative del ministro di culto
La condizione giuridica dei ministri di culto nel diritto civile italiano, si rinviene da una serie di disposizioni normative, sia pattizie che statali, con la quale vengono riconosciuti una serie di diritti connessi alla figura di ministro del culto.
Con riferimento al servizio militare, c’è da dire che è venuto meno l’obbligo di leva e viene riconosciuto un trattamento particolare nel caso di mobilitazione generale con trattamenti differenti a seconda della confessione religiosa di appartenenza:
– per i ministri cattolici non assegnati alla cura delle anime è previsto l’esercizio del ministero religioso tra le truppe o l’assegnazione ai servizi sanitari;
– per i ministri delle confessioni acattoliche stipulatarie di intese con lo stato, si fa riferimento all’art. 8 co- 2 della Costituzione;
– per i ministri dei culti ammessi nello Stato, essi hanno il diritto di essere dispensati dalla chiamata alle armi dal Prefetto.
Specifiche previsioni sono poi contenute nell’art. 352 c.c. che riconosce agli arcivescovi, ai vescovi e ai ministri del culto aventi cura d’anime il diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela e dall’art. 609 co. c.c. che attribuisce al ministro del culto l’esercizio di una funzione pubblica, quella di ricevere per testamento, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni.
5. Le incompatibilità
Il nostro ordinamento prevede talune incompatibilità per i ministri di culto, per i religiosi e per gli ecclesiastici con cura d’anime.
Nel dettaglio, la qualifica del ministro di culto e di religioso è incompatibile con l’ufficio di giudice popolare, con l’ufficio di giudice onorario del Tribunale, anche di aggregato onorario, con l’ufficio di giudice di pace, di notaio e con la professione di avvocato.
Anche in materia elettorale sono previste specifiche incompatibilità per gli ecclesiastici con giurisdizione e cura d’anime in quanto non possono essere eletti come consiglieri regionali e, i ministri di culto e gli ecclesiastici con giurisdizione o cura d’anime, non possono ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, metropolitano, provinciale e circoscrizionale.
6. Trattamento e previdenza
Gli ecclesiastici e i ministri di culto ricevono, dalle loro confessioni religiose di appartenenza, una remunerazione per l’attività svolta in favore delle stesse, finalizzata ai loro bisogni di vita e ai loro ruoli istituzionali.
Orbene, la disciplina attualmente vigente in materia di sostentamento di culto è quella prevista dalla L. 222/1985[3].
Per i sacerdoti cattolici, l’art. 24 della legge sopra menzionata, riconosce per lo svolgimento del servizio a favore della diocesi, il diritto a ricevere quanto necessario per il loro “congruo e dignitoso sostentamento”; esso, dunque, è un vero e proprio diritto soggettivo per i sacerdoti da far valere anche dinanzi la giurisdizione italiana.
Fiscalmente parlando, le somme sono equiparate al reddito da lavoro dipendente con ala conseguenza che le ritenute sulle somme in questione sono operate dai singoli enti competenti in materia tributaria.
Ora, la L. 903/1973 all’art. 1, ha istituito presso l’INPS il “Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica” mentre all’art. 5, si è previsto l’obbligo di iscrizione al fondo in capo a tutti i sacerdoti secolari, nonché a tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, anche non aventi la cittadinanza italiana e residenti in Italia o a servizio delle diocesi italiane, nonché ai sacerdoti a ei ministri di culto con cittadinanza italiana ma operanti all’estero, al servizio di diocesi italiane, chiese e/o enti acattolici riconosciuti, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero del culto in Italia e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione di invalidità.
Il fondo eroga la pensione di vecchiaia in favore di chi abbia raggiunto i 65 anni di età e con un’anzianità contributiva di 40 anni, la pensione di invalidità se gli iscritti, dichiarati invalidi, vantino almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva al fondo[4] e la pensione superstiti, erogata a favore dei familiari dell’avente diritto di pensionati o assicurati che al momento del decesso possano far valere almeno 5 anni di contribuzione al fondo.
Vi è di più!
La L. 669/1967 ha fatto sì che per i sacerdoti e per i ministri delle altre confessioni religiose diverse da quella cattolica e ai rispettivi familiari viventi a loro carico fosse riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria[5].
7. I ministri del culto nell’ordinamento penale
Dal punto di vista penale assume rilievo l’art. 61 c.p. .
In particolare, l’art. 61 n. 9 c.p. considera come circostanza aggravante comune “l’aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di culto”.
Dalla locuzione ministro di culto ben si comprende che la categoria alla quale la norma si riferisce, viene individuata considerando la cd. l’investitura confessionale e non viene considerata, invece, l’attività di culto alla quale è confessionalmente deputata.
In più, la norma, fa un riferimento generico ad un culto e ciò comporta come conseguenza l’estensione di questa disciplina a tutte le confessioni religiose, senza distinzioni (sia dunque cattolica che acattoliche).
Da collegare con quanto detto è sicuramente l’art. 61 n. 10 c.p., che al contrario, prevede un’aggravante comune a carico di chi abbia commesso il fatto “contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di servizio”. Da ciò si evince come non vi sia uniformità tra le espressioni che vengono utilizzate dalle due disposizioni dell’art. 61 c.p. .
È qui da richiamare una importantissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la sent. Sez. pen., 1949/2017 in relazione ai casi di incriminazione di ministri di culto per atti di natura sessuale compiuti in danni di minori.
8. I reati
Merita di essere qui accennata, in quanto richiede uno scritto distinto, l’entrata in vigore della legge 85/2006 ha riformato l’intero sistema dei delitti in materia di religione.
Nel dettaglio, con essa è stata inserita la nozione di “confessioni religiose”, nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405 c.p. con ricadute importanti sull’individuazione del bene giuridico tutelato.; è stata in parte riformulata la descrizione del fatto tipico del vilipendio di cose attinenti al culto di cui all’art. 404 co. 1 c.p., ed è stata inserita, all’art. 404 co. 2 c.p., una nuova fattispecie di reato ossia il danneggiamento di cose attinenti al culto; infine, non è stato ripristinato il reato di vilipendio diretto della religione presente nel vecchio art. 402 c.p.
9. Il segreto ministeriale
La disciplina comune del segreto dei ministri di culto trova tutela all’interno dell’art. 200 c.p.p. destinato alla protezione del segreto professionale.
La norma prevede, al co. 1 che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” .
Orbene, si riconosce allora in capo ai ministri di culto delle confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, il diritto di astenersi dal deporre. L’esercizio di tale diritto implica la libera valutazione da parte dei ministri stessi della natura più o meno coercitiva del vincolo di riservatezza derivante dall’esercizio del proprio ministero. Tuttavia, qualora il giudice abbia, ai sensi del co. 2 dell’art. 200 c.p.p. “motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga” .
L’art. 200 va letto in combinato disposto con gli artt. 256, 271 e 362 del medesimo codice. Nel dettaglio, l’art. 256 c.p.p. prevede al co. 1 che le persone indicate negli articoli 200 e 201 (tra le quali anche i ministri di culto) hanno l’obbligo di consegnare “all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti (…) di segreto inerente al loro ufficio o professione.”
A ciò si aggiunge che L’art. 271 c.p.p. vieta l’uso delle “intercettazioni riguardanti conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 co. 1 quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati”, l’art. 362 c.p.p. prevede, invece, che “il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”, salvo il rispetto dell’art. 200 c.p.p. [6]
Per converso, gli artt. 200 e 256 c.p.p. prevedono il diritto dei ministri di culto di astenersi dal deporre su quanto appreso in ragione del proprio ministero, o dal consegnare gli atti, i documenti o ogni altra cosa esistente presso di essi per lo stesso motivo, quest’ultimo articolo tutela il soggetto che si confida con il ministero stesso. Se il ministro di culto opta per non astenersi dal deporre la sua testimonianza è pienamente valida ma va ad integrare la fattispecie di “rivelazione di segreto professionale”. L’esistenza di un giudizio non costituisce, infatti, necessariamente una giusta causa di rivelazione del segreto.
Infine, nel diritto canonico, è posto in capo ai ministri di culto un obbligo al segreto in relazione a tutto ciò che essi abbiano appreso nella loro veste in sede di confessione, anche nel caso di autorizzazione del soggetto penitente, ai sensi dell’art. 983 del codice canonico.
[1] C’è da dire che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell’art.8, co. 2 della Costituzione e di professare la loro fede religiosa, farne propaganda ed esercitare il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume ai sensi dell’art. 19 della Costituzione.
[2] Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’approvazione del governo è diretta alla verifica della personalità del soggetto che rivestirà la carica ed ha fissato un criterio minimo per l’approvazione con un numero minimo di fedeli: 500 in ambito locale e 5000 a livello nazionale.
[3] Con essa si è prevista l’erezione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero (I. D. S. C.) e dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (I. C. S. C.). Tali enti sono persone giuridiche pubbliche dal punto di vista dell’ordinamento canonico (ai sensi dell’art. 1 degli Statuti approvati dall’Autorità canonica), ed enti ecclesiastici dal punto di vista dell’ordinamento civile.
[4] Il fondo prevede anche l’obbligo di iscrizione obbligatoria all’assicurazione generale per l’invalidità e la vecchiaia.
[5] Hanno l’obbligo di pagamento dei contributi per l’assicurazione contro le malattie e all’assistenza provvede l’INPS.
[6] Tale disposizione trova applicazione anche in sede civile per effetto del rinvio operato dall’art.249 c.p.c., relativo alla facoltà d’astensione dei testimoni.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Veronica Riggi
Abilitata all'esercizio della professione forense
Ultimi post di Veronica Riggi (vedi tutti)
- I ministri di culto: tra ordinamento civile e penale - 20 Maggio 2025







