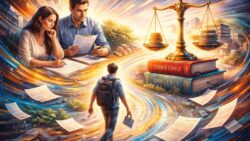Casa familiare e mediazione nelle coppie di fatto con figli
Sommario: 1. La casa familiare: da questione patrimoniale a spazio relazionale – 2. La casa familiare: da questione patrimoniale a spazio relazionale
Negli ultimi decenni, il concetto di famiglia si è notevolmente trasformato e con esso anche il diritto che va a disciplinarlo.
Le convivenze di fatto, oggi riconosciute anche sul piano normativo grazie alla Legge del 20.05.2016 n. 76, alias Legge Cirinnà, sollevano importanti e delicate questioni giuridiche, soprattutto in caso di cessazione del rapporto affettivo, specie quando dalla relazione siano nati dei figli. Tra i nodi centrali e critici la destinazione della casa familiare rappresenta uno degli aspetti più delicati, non solo sul piano giuridico-patrimoniale, ma anche e soprattutto su quello psicologico, educativo e relazionale.
1. La casa familiare: da questione patrimoniale a spazio relazionale
Proprio per l’importanza affettiva e relazionale del tema, affrontare l’argomento della casa familiare nelle separazioni delle coppie di fatto in mediazione, piuttosto che in sede giudiziaria, è preferibile per diverse ragioni, che riguardano sia l’efficacia delle soluzioni che il benessere delle parti coinvolte, in particolare dei figli minori.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la legge italiana, pur distinguendo tra coppie sposate e conviventi, pone sempre al centro delle decisioni giuridiche o meno che si prendono il best interest del minore: principio cardine di derivazione internazionale[1] ormai pacificamente recepito nel nostro ordinamento, tanto da orientare sia la giurisprudenza che la prassi della mediazione familiare.
Per tale ragione, la casa familiare NON viene attribuita secondo criteri di proprietà o di titolarità del contratto di locazione, ma in funzione della tutela dei figli.
L’art. 337 sexies c.c.[2] dispone che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (…)” al genitore che, ancorché non proprietario della stessa, tenendo conto dell’interesse della prole, sia colui o colei con cui i figli vivranno in via prevalente e sempre purché corrisponda all’interesse dei figli stessi di rimanere nell’abitazione familiare.
L’assegnazione non è definitiva: detto diritto viene meno nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non abiti o cessi di abitare stabilmente nella stessa, conviva more uxorio, contragga un nuovo matrimonio ovvero cessi la convivenza con i figli[3]. Va evidenziato che tale disposizione si applica sia alle coppie sposate che a quelle conviventi, come chiarito da una giurisprudenza ormai consolidata[4].
2. La casa familiare: da questione patrimoniale a spazio relazionale
Nella mediazione familiare, lo spazio domestico non è solo un “bene materiale”, ma assume una funzione identitaria e affettiva, rappresentando il luogo della continuità e della sicurezza emotiva per i figli.
Si tratta, pertanto, di un valore tanto simbolico quanto pratico, poiché la casa rappresenta il luogo dove il minore conserva riferimenti affettivi, consuetudini e stabilità. E’ lo strumento di estrinsecazione delle emozioni dei membri della coppia e, proprio per questo, è un potente veicolo di conflitto che può essere utilizzato sia come strumento di vendetta che come mezzo di ricatto. Dunque, affrontare il tema della casa familiare significa affrontare una questione non già strettamente giuridica ed economica, ma un aspetto che spesso cela bisogni ed esigenze molto più profonde.
Proprio per questo, la mediazione familiare può ritenersi un ottimo ambiente per discutere del tema. Durante gli incontri, la coppia di genitori viene accompagnata a riflettere non sulla proprietà, ma sulla funzione della casa familiare rispetto al benessere superiore dei figli, grazie alla figura del mediatore che tenta di disinnescare le dinamiche conflittuali.
Il mediatore può aiutare i mediandi a lavorare dialogicamente e costruttivamente per favorire accordi condivisi e sostenibili, che tengano conto della possibilità di co-genitorialità anche sul piano abitativo, affrontando temi quali: la definizione della residenza abituale dei figli, l’eventuale turnazione dei genitori presso l’abitazione familiare – cd. nido mobile – e la previsione di soluzioni abitative alternative per il genitore non collocatario.
In contesti di separazione, minimizzare il conflitto abitativo è un errore comune, soprattutto considerando che nei contenziosi giudiziari la questione “casa” viene spesso strumentalizzata, finendo per esacerbare il conflitto genitoriale.
Del resto, è oramai noto che, mentre il processo giudiziale tende a standardizzare le decisioni secondo criteri normativi e giurisprudenziali, la mediazione familiare consente di modellare le soluzioni sugli specifici bisogni della famiglia coinvolta. Vieppiù: il contenzioso giudiziario può durare mesi o anni, generando elevati costi non solo economici, ma anche e soprattutto emotivi. Al contrario, la mediazione familiare consente di arrivare a intese rapide, con risparmi significativi anche in termini di stress e conflittualità.
E’, infine, bene sottolineare un ultimo aspetto.
Nel caso delle convivenze di fatto, spesso ci si trova in situazioni di assenza di contratti o accordi patrimoniali e l’assegnazione della casa al momento della chiusura del legame di affetti, soprattutto in presenza di figli, può generare rancori legati alla permanenza. Con la mediazione familiare tali dinamiche vengono elaborate con l’aiuto di un professionista che favorisce una narrazione comune e consapevole, evitando che la casa venga usata come strumento di vendetta o controllo e favorendo anche su questo tema una cultura della genitorialità condivisa, basata sul rispetto reciproco e sulla capacità di assumere decisioni cooperative.
In tribunale, invece, la logica antagonista spesso accentua i contrasti, ostacolando la costruzione di un clima collaborativo tra i genitori e questa diversità di approccio risulta decisiva nella gestione post-separazione, dove l’assegnazione della casa è solo una delle tante decisioni da prendere insieme.
Pertanto, le intese raggiunte in mediazione, che non sono calate dall’alto dal giudice, ma costruite insieme dalle parti, sono generalmente più stabili e rispettate nel tempo, proprio perché frutto della volontà condivisa delle parti. Ciò determina un’effettiva riduzione del ricorso a contenziosi successivi e un rafforzamento della capacità dei genitori di affrontare autonomamente nuove situazioni legate allo stesso tema.
Insomma, certamente, il tema della casa familiare nelle separazioni di coppie di fatto con figli impone un approccio integrato tra diritto e mediazione. La legge e la giurisprudenza pongono giustamente al centro il benessere dei figli, ma è nella mediazione familiare che si costruiscono soluzioni pratiche, personalizzate e sostenibili ed è per questo che detta A.d.r. rappresenta un approccio più umano, costruttivo e sostenibile rispetto al ricorso giudiziale, permettendo di trasformare il conflitto in occasione di dialogo, superando la logica de “WIN-LOSE” e costruendo soluzioni che tutelano non solo i diritti delle parti, ma soprattutto le relazioni.
È indubbio che sia comunque auspicabile un potenziamento degli strumenti contrattuali, quali gli accordi di convivenza, nonché una maggiore consapevolezza giuridica nei percorsi di mediazione, affinché la casa – da bene conteso – torni a essere luogo di continuità e sicurezza affettiva per i minori.
[1] L’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza stabilisce che: “1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo”.
[2] Aggiunto dall’art. 55 del D. lgs. 28.12.2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto dell’art. 155 quater c.c., oggi abrogato.
[3] Cass. Civ., sent. n. 16134 del 17.06.2019.
[4] Cass. civ., sez. I, n. 18066/2014; Cass. civ. n. 16134/2020.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News