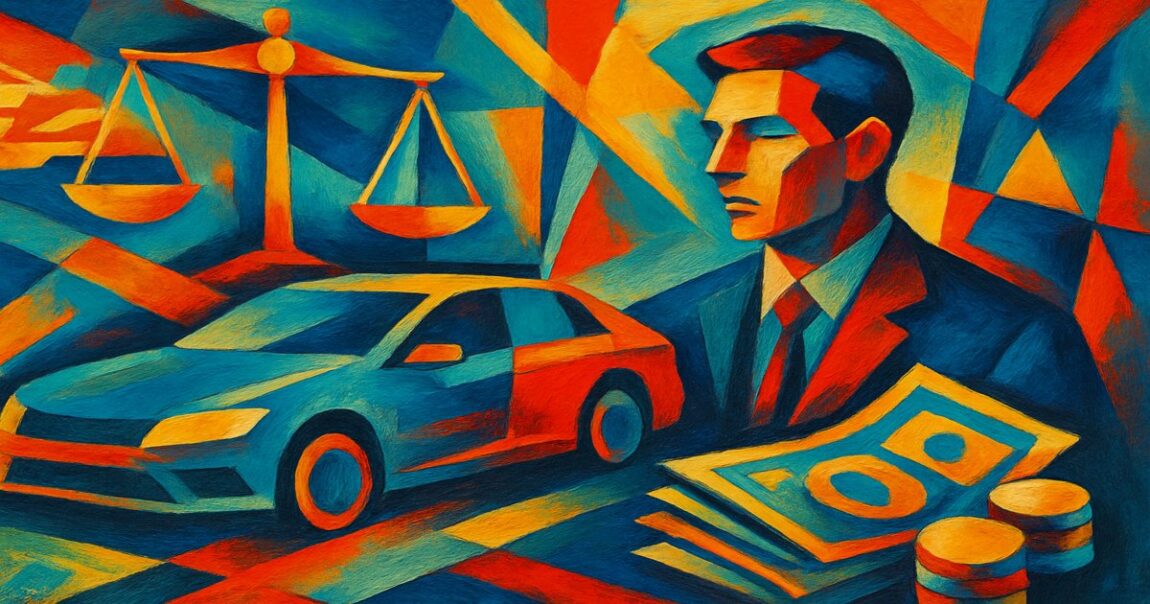
I fringe benefit auto 2025: un tuffo nel passato per una “rivoluzione” ecologica
Sommario: 1. Il conteggio del valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR e la sua applicazione concreta – 2. Analisi delle criticità e possibili soluzioni
1. Il conteggio del valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR e la sua applicazione concreta
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 il legislatore ha pensato di poter raggiungere l’obiettivo di transizione ecologica (in primis la diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera) modificando il conteggio del valore delle auto acquistate o noleggiate dai datori di lavoro e assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti e/o agli amministratori delle società.
Una delle modalità maggiormente utilizzare per incentivare i lavoratori alla stabilità aziendale è data proprio dai fringe benefit auto, in quanto con essi il datore di lavoro ha la possibilità di dedursi i costi sostenuti e, con l’aumento delle soglie di esenzione previste dal TUIR, (utilizzati come strumenti di politica del lavoro ad ogni legge di bilancio), può addirittura capitare che il datore di lavoro non debba versare i relativi contributi previdenziali ed il lavoratore, pur avendo a disposizione un autoveicolo utilizzabile anche per motivi personali, non veda aumentare la sua base imponibile previdenziale e fiscale sulla quale calcolare i relativi importi dovuti agli enti di competenza.
Pensiamo ad esempio ad un dipendente a cui venga concessa un’automobile ad uso promiscuo con un valore di 200,00 euro mensile per 5 mesi all’anno avrà un fringe benefit pari a 1.000,00 euro annui, quindi esenti da imposizione fiscale in quanto le soglie di esenzione ad oggi sono pari a 1.000,00 euro se il lavoratore non ha figli a carico e 2.000,00 euro se lo stesso invece ha figli a carico. In parole semplici quindi: al lavoratore è come se fosse stata regalata per 5 mesi all’anno l’automobile e dato i costi di un’automobile direi che non è male qualunque essa sia.
Per tale ragione è diventato un tema sempre più importante e revisionato negli ultimi anni, con continue modifiche dal nostro legislatore sia innovative che nostalgiche.
Con le ultime variazioni il legislatore ha pensato di far conciliare le esigenze di tutte le correnti di pensiero degli ultimi decenni, distinguendo il valore dei fringe a seconda della data di immatricolazione della vettura, della data in cui è stata assegnata e concessa l’auto stessa.
Per i più “moderni” l’auto immatricolata, concessa e assegnata al dipendente a decorrere dal 1 gennaio 2025 il calcolo del valore del fringe benefit segue le nuove regole dettate dall’ultima legge di Bilancio.
Per le auto ordinate entro la fine del 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore da luglio 2025, invece il legislatore ha stabilito che il fringe benefit deve essere calcolato sulla base del valore normale del bene dedotto l’utilizzo del bene a scopo aziendale-lavorativo.
Tale conteggio, ricordiamo, era già stato utilizzato per valorizzare il fringe benefit dell’auto a favore di dipendenti o amministratori ma, non a caso, si era deciso di accantonare tale modus anche con il fine di aumentare la certezza del calcolo del fringe benefit date le criticità sorte anche per la stessa amministrazione finanziaria e di conseguenza gli aumenti dei contenziosi nelle commissioni tributarie a causa della discrezionalità dei conteggi stessi.
2. Analisi delle criticità e possibili soluzioni
La prima criticità risiede nel calcolare il valore normale del bene. Da definizione è il valore dell’auto al valore di mercato, essendo l’auto concessa come fosse un leasing, quindi, dobbiamo reperire il valore del bene come se il lavoratore si fosse recato in una concessionaria e avesse stipulato un contratto di leasing dell’auto.
Le offerte commerciali sono all’ordine del giorno e quindi è facile intuire la difficoltà nel trovare tale informazione con certezza, non volendo tralasciare le differenze economiche della nostra nazione (non è detto che lo stesso veicolo abbia lo stesso canone in due regioni diverse, pur se confinanti).
Per superare questo primo ostacolo a mio avviso dobbiamo fare riferimento al prezzo di un leasing della concessionaria della zona di residenza del datore di lavoro o del lavoratore (presumendo siano vicini).
In caso però di controllo dell’amministrazione competente dobbiamo anche riuscire a dimostrare tale valore e quindi a livello probatorio sarà opportuno farsi rilasciare una dichiarazione o un preventivo di un leasing privato in una concessionaria limitrofa ai luoghi in cui viene esercitata l’attività lavorativa.
Dopo aver individuato il valore normale del bene e archiviata la documentazione probatoria almeno annuale del valore dell’auto, ad es. 400,00 euro al mese, dobbiamo preoccuparci di scorporare al valore dell’auto l’utilizzo a mero scopo aziendale per poter di conseguenza individuare il valore del fringe assegnato al collaboratore.
Su questo argomento sono nate diverse teorie che andremo ad analizzare:
– Valorizzare i giorni in cui l’auto viene utilizzata dal collaboratore per svolgere la sua prestazione lavorativa come da lettera di assunzione.
Ad esempio: un dipendente che presta attività lavorativa 5 giorni su 7, in percentuale vedrà attribuito un 71,42 per cento utilizzato per scopi aziendali e il restante 28,58 per cento ad uso privato, arrotondato al 30 per cento; così facendo il fringe benefit è pari a 120 euro al mese.
– Scomputare i km mensili svolti dal lavoratore per uso privato dal totale dei km percorsi calcolando i km sulla base delle tabelle ACI.
Ad esempio: in un mese l’auto percorre 500 km di cui 300 a scopo privato, il costo km è pari a 0,50 euro. Pertanto 100 euro (200 km per 0,50 euro/km) devono essere scomputati dal costo del fringe benefit per un valore di fringe mensile pari a 300 euro;
– Suddividere il mese in ore e scomputare le ore stesse non lavorate per differenza, successivamente dividendo il valore normale dell’auto per la disponibilità dell’auto concessa al collaboratore.
Ad esempio: in un mese di 31 giorni sono presenti 744 ore, il dipendente ha lavorato per 190 ore e pertanto il fringe sarà pari a 293,62 euro.
Da quanto emerge, quindi, raggiungiamo tre risultati diversi con conseguenti differenti basi imponibili fiscali e previdenziali con notevoli conseguenze per tutti gli attori (amministrazione finanziaria, istituti previdenziali, costo lavoro per il datore di lavoro, l’importo netto incassato dal collaboratore).
La stella polare a cui dobbiamo fare riferimento risiede nella risoluzione 20 giugno 2017 n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate richiamata dalla risoluzione del 14 agosto 2020 n. 46/E in cui si puntualizza che “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elemento oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero valore normale di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.
Sulla base di quanto sopra, ricordando che le circolari degli enti non sono fonti del diritto ma inevitabilmente condizionano gli orientamenti interpretativi, la scelta di decurtare il valore dell’utilizzo dell’auto su base giornaliera (ipotesi 1^) apre ai seguenti quesiti di difficile risposta: bisogna conteggiare i giorni di ferie? Quid iuris se il lavoratore richiede ore di permesso? Se il lavoratore è in maternità o usufruisce di permessi ai sensi della legge 104/92? La sera, dopo l’orario di lavoro, il collaboratore può utilizzare l’auto e quindi con la decurtazione del 30% non si considera tale variabile?
Anche volendo quantificare le domande di cui sopra a mio avviso non trova soluzioni prive di contenzioso e pertanto apre a probabili riprese dell’Agenzia delle Entrate.
La seconda teoria, invece, anche se apparentemente ancorata su basi più solide come la decurtazione delle spese su base chilometrica si fonda, a parere mio, su un assunto contestabile: solitamente i contratti di leasing richiedono un importo fisso a prescindere dei chilometri percorsi e pertanto il canone è bilanciato sul lasso di tempo in cui l’oggetto del contratto è a disposizione del beneficiario.
Ciò comporta che, inoltre, un lavoratore con una elevata percorrenza chilometrica dell’auto ad uso aziendale possa vedere il suo valore attribuito a titolo di fringe benefit molto basso o addirittura in negativo (paradossalmente) anche se il collaboratore ha utilizzato l’auto anche ad uso privato.
Ad esempio: ipotizziamo un’automobile con valore normale dichiarato dalla concessionaria pari a 350 euro mensili, in un mese percorre in totale 800 km di cui 600 ad uso aziendale e i restanti 200 km ad uso personale. Il costo km dalle tabelle ACI è pari a 0,4792 euro. L’operazione che si andrà ad eseguirà sarà la seguente: 600 km * 0,4792 = 287,52, successivamente 350 – 287,52 = 62,48 euro valore del fringe benefit per una percorrenza di 200 km ad uso personale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore effettuasse 800 km ad uso aziendale e 200 ad uso privato per un totale di 1000 km mensile l’operazione sarà la seguente: 800 * 0,4792 = 383,36, valore superiore per assurdo al valore normale con gli stessi chilometri percorsi ad uso privato.
Anche volendo considerare il rapporto fra chilometri ad uso privato e ad uso aziendale raggiungeremmo dei valori ancora diversi per gli stessi chilometri di percorrenza, con la stessa auto, dallo stesso lavoratore nello stesso lasso di tempo in cui l’auto è stata concessa ad uso promiscuo.
Inoltre, da un punto di vista probatorio, ritengo che sia un c.d. probatio diabolica riuscire a dimostrare ufficialmente la percorrenza suddivisa tra uso privato e uso aziendale del veicolo.
I contratti di leasing o addirittura le auto acquistate direttamente dal datore di lavoro e assegnate al lavoratore come fringe benefit, invece, sono ancorate al lasso di tempo in cui l’auto stessa è stata consegnata.
Senza dover cadere nel paradossale, quindi, suddividendo il mese in ore permetterebbe di soddisfare tutte le esigenze delle parti.
A mio parere, infatti, la terza ipotesi, soddisfa i requisiti di oggettività e di analiticità.
Da un punto di vista sostanziale andrebbe analiticamente a suddividere le ore in cui potenzialmente il lavoratore ha la possibilità di utilizzare l’auto a scopo personale e a scopo aziendale.
Tale soluzione è conforme anche al dettato normativo sull’orario di lavoro, decreto legislativo 66/2003, in cui all’art. 1 rubricato “finalità e definizioni” si definisce “l’orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività e delle sue funzioni”.
I dati utilizzati sono oggettivi e soddisfano facilmente anche l’onere della prova poiché le ore sono indicate nel libro unico del lavoro quale documento ufficiale.
La problematica, però, sussiste e continuerà ad oggi ad essere presente senza ulteriori chiarimenti da parte anche degli organi preposti, a maggior ragione per gli amministratori di società.
Si auspica pertanto, anche se fra pochi mesi sarà in discussione la nuova legge di Bilancio anno 2026, di trovare una soluzione, intanto, per le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in merito all’argomento in esame del presente scritto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Antonio Emanuele D'Isa
Consulente del Lavoro







