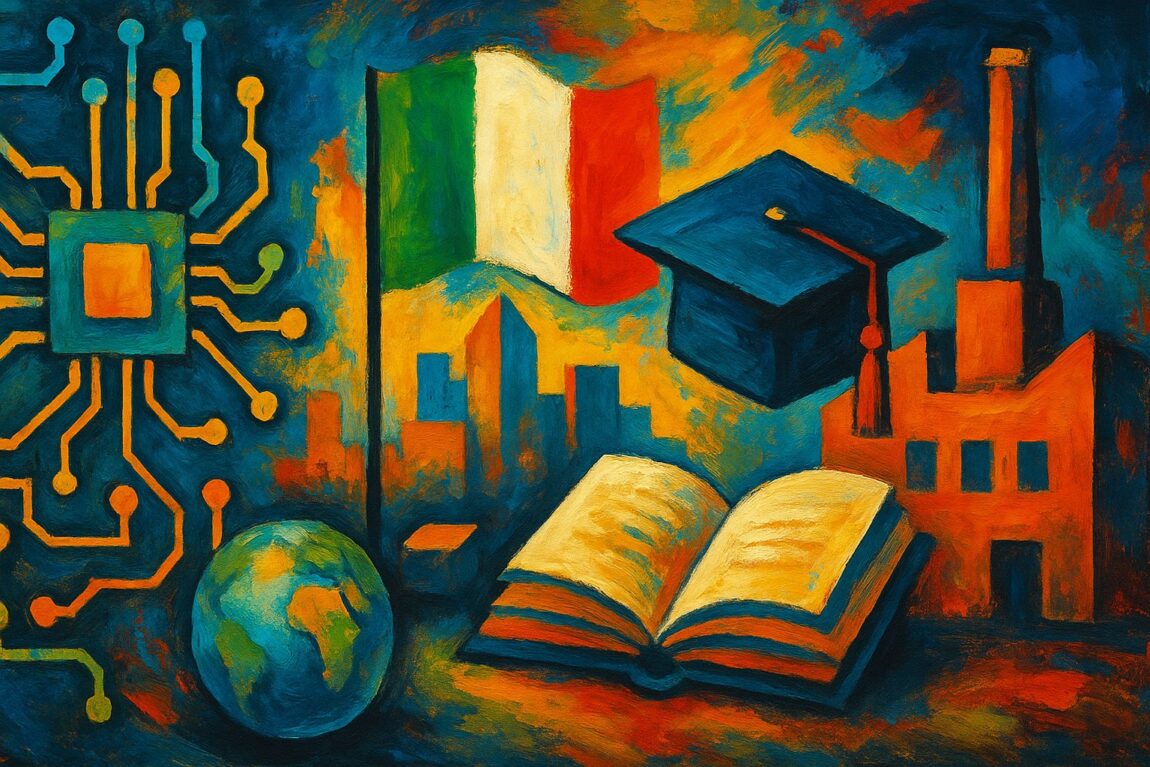
Le politiche di innovazione: l’interazione feconda fra Stato, università ed industria
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le Politiche innovative italiane del secondo dopoguerra – 3. Il ruolo delle ICT e delle Università nelle politiche di innovazione – 4. I vantaggi dei poli di innovazione
1. Introduzione
L’evoluzione sociale ed economica, la valorizzazione del territorio, lo sviluppo della competitività, l’accrescimento dell’attrattività e qualità della vita sono legati a doppio filo alle politiche innovative promosse ed, effettivamente, attuate da ciascuno Stato.
Considerando, infatti, in via comparativa, le esperienze degli altri Stati, Europei e non, in particolare la Germania, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, emerge chiaramente che l’innovazione sia una delle determinanti essenziali della crescita economica di uno Stato. A tal proposito, le risultanze delle indagini effettuate negli ultimi decenni, mostrano quanto l’Italia, rispetto alla maggior parte dei Paesi industrializzati, abbia trascurato le politiche innovative, così provocando delle inevitabili ripercussioni sulla competitività dell’industria ed, in generale, sulla crescita socio-economica del Paese. Non è un caso che la spesa italiana in ambito di Ricerca e Sviluppo, in percentuale del PIL, sia al di sotto della media dell’Unione Europea e di gran lunga inferiore ad alcuni Stati europei, come per esempio la Germania. Sicché, nel 2007, l’Italia viene definita uno Stato innovatore “Moderato”: terzo livello su quattro, ossia dopo “Leader” e “Follower”, ma prima di “Modesto”, mentre i Paesi scandinavi, come la Svezia, la Danimarca e la Finlandia si confermano i leader europei dell’innovazione, seguiti subito dopo dalla Germania.
Precisamente, lo Stato italiano si dimostra forte negli output di innovazione, Knowledge creation e Intellectual property, a fronte di una debolezza negli input, con riferimento agli Innovation drivers e Innovation and entrepreneurship.
Peraltro, la spesa italiana in ambito R&S si concentra maggiormente in alcune Regioni italiane, tendenzialmente quelle del Centro-Nord, ed è anche caratterizzata da un’intensa eterogeneità. Nello specifico, la spesa privata in R&S è più alta al Nord-Ovest, seguito dal Nord-Est, dal Centro e dal Mezzogiorno, diversamente, la spesa pubblica in R&S ribalta l’ordine delle regioni, giacché in testa vi è il Centro, seguito dal Mezzogiorno, dal Nord-Est e, infine, dal Nord-Ovest.
Tali dati non devono però stupire, in ragione della scarsa considerazione rivolta al finanziamento della ricerca da parte della nostra classe politica, probabilmente, pure a causa dell’aggravarsi del debito pubblico, che impone di sottrarre ulteriori risorse finanziarie.
2. Le Politiche innovative italiane del secondo dopoguerra
Le discrepanze attualmente in essere, tra gli Stati europei e tra le Regioni italiane, con riferimento alle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo hanno origini risalenti. Esattamente, nel secondo dopoguerra tutti i Paesi industrializzati, compresa l’Italia, indipendentemente dal fatto di qualificarsi come vincitori o sconfitti, avevano la stessa necessità, ovvero ricostruirsi e riorganizzare le proprie risorse. Queste ultime, però, erano differenti da Stato a Stato e, proprio in virtù di siffatta circostanza, diedero avvio ad altrettanto differenti percorsi evolutivi. Quindi, sebbene all’inizio le direttrici innovative erano identiche per tutti i Paesi del dopoguerra, nel tempo, gli obiettivi, le strategie e le politiche sono andate modificandosi. Ciononostante, ciascuno Stato aveva raggiunto la medesima consapevolezza con riferimento al ruolo della conoscenza, ritenendola uno strumento indispensabile per lo sviluppo, l’implementazione e la crescita tecnologica ed economica.
In Italia, il campo della ricerca ed innovazione è oggetto delle politiche di programmazione ed attuazione delle Regioni solo a partire dagli anni Novanta, poiché fino a quel momento esso è stato prerogativa dello Stato. Specificatamente, con il Decreto Legislativo n.112 del 31 Marzo 1998, lo Stato italiano delegava alle Regioni i poteri di pianificazione ed implementazione delle politiche industriali e tecnologiche, attribuendo contestualmente al Governo il potere di coordinamento ed indirizzo. Ma solo successivamente, ossia con la Legge Costituzionale n.3 del 2001, veniva formalmente riconosciuto il decentramento e, dunque, l’autonomia regionale, sia nell’ambito delle politiche innovative sia in materia di controllo delle risorse necessarie a tal fine. Sicché, a partire da questa riforma costituzionale cominciarono a manifestarsi i primi divari, poi divenuti più intensi, fra le diverse regioni della penisola.
Ennesimo mutamento, in ambito di politiche innovative nazionali, è avvenuto con la costituzione del mercato unico europeo, l’adozione della moneta unica e, dunque, con il perseguimento di politiche innovative a livello comunitario, in virtù della nascita ed adesione dell’Italia all’Unione Europea. Ciò ha consentito ad imprese ed università nazionali di essere coinvolti in partnership di livello internazionale, partecipare a progetti di altissimo livello e di godere della coesione politica, dei finanziamenti europei e della sinergia tra programmi regionali, nazionali e comunitari, finalizzati a garantire nuove occupazioni e promuovere l’innovazione tecnologica e la società dell’informazione.
Di conseguenza, le politiche innovative italiane del XXI secolo subiscono l’influenza delle rispettive Regioni, poiché sono materie di loro competenza, in via del tutto autonomia, seppur subordinata al coordinamento posto in essere dall’U.E., da cui derivano non soltanto vincoli, ma anche vantaggi.
3. Il ruolo delle ICT e delle Università nelle politiche di innovazione
Come emerso nel vertice di Lisbona, passo indispensabile per favorire il processo di innovazione è implementare l’uso e la diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione, meglio note con l’acronimo TIC e/o ICT, poiché, di fatto, l’accesso ad internet consente ai cittadini di partecipare a forme dirette di democrazia, come sondaggi e discussioni, mentre l’utilizzo di risorse on-line, riduce i costi dei servizi pubblici, oltre che migliorarne l’efficacia e l’efficienza. Insomma, digitalizzare il territorio riduce il digital gap, favorisce i rapporti tra i singoli cittadini e le organizzazioni, promuove la coesione economico-sociale e dà vita a comunità on-line ed e-commerce, soprattutto a beneficio delle PMI, consentendo di superare i disagi causati dalla carenza di infrastrutture ed, altresì, ottimizzare l’efficienza della Pubblica Amministrazione. Per quanto attiene specificatamente alla P.A., è pacifico che l’adozione dei nuovi sistemi debba essere associata a strategie di riorganizzazione, poiché l’evoluzione del dominio tecnologico non è sufficiente, in mancanza dei cambiamenti nelle strutture funzionali, istituzionali, sociali e relazionali del territorio in cui opera.
Contestualmente, a livello internazionale, si è corroborato il convincimento secondo cui le università sono capaci di influenzare fortemente l’innovazione, tanto che negli USA, grazie ad una legislazione ad hoc che attribuisce la titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione all’università di appartenenza del ricercatore, è persino nata l’“Università imprenditoriale”, proprio finalizzata a “commercializzare la conoscenza”.
Tutt’altro scenario caratterizza l’Italia, ove si percepisce la costante difficoltà delle PMI di assimilare le conoscenze accademiche della ricerca universitaria. Eppure, anche in Italia si è abbandonata la concezione di università ed imprese quali entità separate, in favore di una che le vede in costante interazione, onde produrre un continuo scambio informativo, in grado di costruire un’innovazione aperta.
Per tale ragione, si è configurato il cosiddetto modello a “tripla elica” per lo sviluppo economico, contraddistinto dall’interazione ed interdipendenza tra Stato, università e industria, tra i quali si verifica un trasferimento continuo di conoscenza.
4. I vantaggi dei poli di innovazione
Nonostante le differenti strategie e modalità di programmazione, attuazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, in tutte le realtà estere prese in esame, l’innovazione è promossa tramite politiche pubbliche che mirano a creare dei cluster, ossia delle reti tra laboratori di ricerca, università, organismi pubblici e privati, PMI e grandi imprese, onde favorire la partnership ed il trasferimento di conoscenze tra i diversi attori del processo innovativo. Nel merito, come anticipato, anche l’Italia ha interiorizzato il convincimento secondo il quale deve essere costruito e corroborato un rapporto tra centri di ricerca/università ed aziende, tale da costituire un c.d. continuum osmotico, idoneo a tradurre le idee accademiche in valore commerciale.
A tal proposito, una nuova forma di organizzazione economica fondata sui collegamenti tra imprese, ricerca pubblica e privata è costituita dai poli di innovazione. Questi ultimi, secondo un’ottica prettamente operativa, rappresentano dei grandi gruppi che pongono in essere tutte le fasi dello sviluppo scientifico e tecnologico, a partire dai test di laboratorio, sino alla produzione e commercializzazione. In sostanza, i poli di innovazione si propongono di integrare imprese innovative, enti di ricerca ed università, che operano in uno o più ambiti scientifico-tecnologici e applicativi del sistema della ricerca ed innovazione di un dato territorio. Perciò si configurano poli “generalisti”, ovvero che attraggono imprese ed attività tipiche di diversi settori tecnologici, e poli “specialistici”, che raggruppano imprese ed attività dedite ad uno o più settori specifici.
Ebbene, tale aggregazione, grazie all’utilizzo in comune di strumenti ed infrastrutture per l’attività di ricerca scientifica e di produzione tecnologica, risulta utile per la razionalizzazione delle risorse, il contenimento dei costi e la promozione di un effetto sinergico fecondo.
Per concludere, si evince chiaramente lo slancio propulsivo del polo, poiché esso consente una proficua intermediazione tra il sistema scientifico ed il sistema imprenditoriale di un territorio, da un lato, dando impulso alla collaborazione tra varie imprese e, dall’altro, agevolando l’innovazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Alessia Aversa
Scopre presto la sua passione per la scrittura, così la coltiva iscrivendosi al Liceo Classico.
Durante gli studi liceali, viene selezionata per effettuare due brevi programmi operativi nel Regno Unito, tra cui stage lavorativo presso un ufficio di consulenza d'affari.
Consegue la maturità classica con il massimo dei voti, elaborando la Tesi: "La parola come strumento di accesso relativistico alla realtà" e dimostrando già un’attenzione particolare per le potenzialità performative delle parole.
Frequenta la Facoltà di Legge dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e sostiene esami extra-curriculari in psicologia sociale e filosofia morale.
Consegue la Laurea in Giurisprudenza Magistrale cum laude e menzione alla carriera accademica, discutendo la Tesi in Diritto Processuale Penale: "La manipolazione della memoria del testimone".
In quest'ultima confluiscono non solo studi giuridici relativi all'istituto della testimonianza ed alla cross-examination, ma anche studi -da autodidatta- di psicologia della testimonianza, scienza della memoria e neuroscienze.
Anche in materia testimoniale, sottolinea la rilevanza delle potenzialità delle parole, in quanto tese alla ricostruzione della verità processuale.Ha conseguito l'abilitazione per la professione forense ed ha collaborato con uno Studio Legale, dopo aver svolto la relativa pratica ed un tirocinio presso l'ufficio affari legali e contenzioso di ARPA Puglia.Attualmente è assistente giudiziario presso la Procura della Repubblica di Bari -specificatamente- Segreteria del Pubblico Ministero.
Ultimi post di Alessia Aversa (vedi tutti)
- Le politiche di innovazione: l’interazione feconda fra Stato, università ed industria - 30 Aprile 2025
- Dai manicomi alle REMS: l’evoluzione storica, giuridica ed organizzativa - 24 Febbraio 2025
- La nuova fisionomia della Criminalità Organizzata - 8 Aprile 2024







