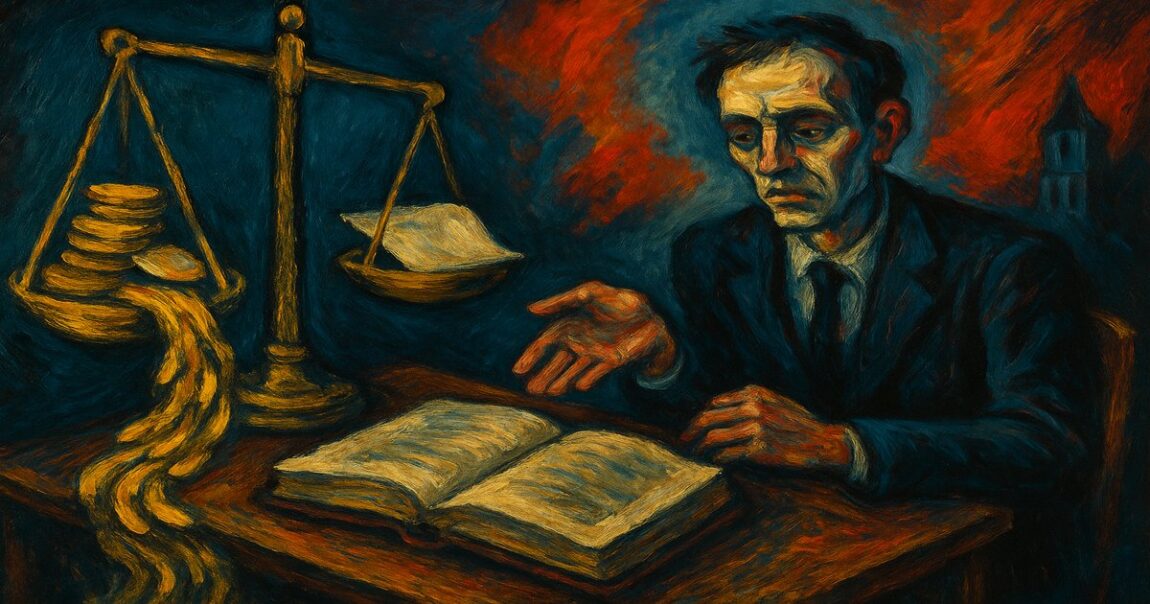
Cassazione 2025: il mutuo solutorio è titolo esecutivo
Nota a Cass. Civ., SS.UU., 5 marzo 2025, n. 5841
Abstract. Il presente contributo ha ad oggetto una recentissima sentenza della Cassazione civile, datata 5 marzo 2025, concernente il cd. mutuo solutorio. La giurisprudenza civile di legittimità perviene alla risoluzione di un rilevante contrasto sorto in seno alle Sezioni semplici in merito alla validità del mutuo al quale si ricorra per il ripianamento di debiti preesistenti del mutuatario, riconoscendo la stessa unitamente alla possibilità che il mutuo solutorio medesimo costituisca valido titolo esecutivo in presenza dei presupposti di cui all’art. 474 c.p.c.
This contribution deals with a very recent ruling of the Civil Cassation, dated March 5, 2025, concerning the so-called solutory mortgage. The civil legitimacy jurisprudence resolves a significant conflict that arose within the simple Sections regarding the validity of the mortgage to which one resorts to repay the borrower’s pre-existing debts, recognizing the same together with the possibility that the solutory mortgage itself constitutes a valid enforcement title ex art. 474 c.p.c.
Sommario: 1. Considerazioni preliminari: nozione di mutuo, mutuo solutorio e i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Le questioni poste dalla Seconda Sezione della Cassazione Civile nel mese di luglio 2024 – 2. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella sentenza n. 5841/2025
1. Considerazioni preliminari: nozione di mutuo, mutuo solutorio e i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Le questioni poste dalla Seconda Sezione della Cassazione Civile nel mese di luglio 2024
Prima di procedere alla disamina della recentissima statuizione delle Sezioni Unite in tema di mutuo solutorio, è opportuno fornire una definizione di mutuo ordinario e di mutuo solutorio nonché mettere in evidenza tanto gli orientamenti contrastanti delle Sezioni semplici oggetto di composizione quanto le questioni sulle quali gli Ermellini si sono pronunciati nel mese di marzo 2025[1].
L’art. 1813 c.c. dispone che il mutuo è “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Ai sensi del successivo art. 1814 c.c. il denaro o le altre res fungibili date a mutuo “passano in proprietà del mutuatario”.
Si è in presenza di un contratto reale, che si perfeziona con la traditio (o consegna) della res – momento nel quale viene attribuita al mutuatario la disponibilità giuridica della res medesima, pur non essendo quest’ultima ancora consegnata materialmente – normalmente oneroso, in quanto l’art. 1815 c.c. prevede la generale corresponsione di interessi (con salvezza di una diversa volontà delle parti contraenti, e dunque con conseguente eccezionalità della gratuità del mutuo) al mutuante da parte del mutuatario.
Il mutuo è così uno strumento che favorisce il reperimento di capitali, essendo di norma il denaro produttivo di frutti e consentendo questa stessa caratteristica la pattuizione di interessi.
Gli effetti che il contratto in questione produce sono sostanzialmente due: uno di tipo traslativo, evincibile dal combinato disposto degli artt. 1813 e 1814 c.c. (trasferimento della proprietà delle res fungibili dal mutuante al mutuatario), e uno di tipo restitutorio, evincibile invece dal combinato disposto degli artt. 1813 e 1815 c.c. (restituzione al mutuante da parte del mutuatario dell’equivalente di ciò che è stato dato a mutuo, ovverosia del tantundem eiusdem generis et qualitatis, unitamente agli interessi normalmente dovuti). Quest’ultimo effetto consente di qualificare il mutuo come contratto a causa di prestito anziché a causa di scambio (causa, quest’ultima, che è invece alla base del differente contratto di compravendita).
Particolare tipologia di mutuo è rappresentata dal cd. mutuo solutorio, che è possibile definire come quel contratto con il quale le somme erogate a titolo di mutuo vengono utilizzate a fini di ripianamento di debiti preesistenti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante.
Come messo in evidenza da certa dottrina, con il mutuo solutorio si facilita la ristrutturazione finanziaria del debitore e non si finanziano nuovi investimenti[2]; in particolari situazioni di ristrutturazione del debito si dà pertanto modo al mutuatario debitore di riequilibrare la sua posizione mediante nuove condizioni contrattuali[3].
Rispetto al mutuo a finalità solutoria si sono formati due orientamenti contrastanti in seno alle Sezioni semplici della Cassazione civile, i quali vengono preliminarmente passati in rassegna tanto nell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024 della Seconda Sezione della Cassazione civile quanto nella sentenza n. 5841/2025 delle Sezioni Unite della quale si dirà a breve[4].
Secondo un primo orientamento maggioritario, il cd. mutuo solutorio, stipulato per il ripianamento della pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non può essere considerato nullo in quanto rispettoso tanto della legge quanto del valore-canone dell’ordine pubblico.
La datio rei tipica del mutuo viene integrata dal semplice accredito delle somme di denaro erogate sul conto corrente del mutuatario-intestatario, perfezionandosi il contratto nel momento in cui la res fungibile sia posta nella disponibilità del mutuatario (e dunque anche laddove non materialmente consegnata, avendosi in ogni caso traditio), non rilevando il fine dell’utilizzazione del denaro (rappresentato in tal caso dall’estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante)[5].
Il ripianamento delle passività rappresenta una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata – potendosi ricorrere al credito a fini di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis e 182-quater del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) – e dimostra che il mutuatario ha avuto modo di disporre del denaro.
Non si tratta neppure di una modalità di utilizzo del denaro lesiva dei diritti o delle aspettative dei creditori, in quanto l’ordinamento tutela il soggetto danneggiato da questo tipo di negozio sia mediante rimedi speciali che attraverso la sanzione dell’inefficacia.
Il mutuo solutorio non costituisce pertanto né mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente né pactum de non petendo.
Stando invece ad un orientamento minoritario emerso già a partire dal 2019[6], il mutuo solutorio configura un’operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente dell’intestatario, non qualificabile come mutuo ipotecario, che postula invece sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.
Può allora ritenersi che l’effetto sostanziale prodotto dal mutuo solutorio sia quello tipico del pactum de non petendo ad tempus, venendo dilatata la scadenza del debito preesistente.
Trova così applicazione l’art. 1231 c.c., nella misura in cui esso si riferisce alle modificazioni accessorie dell’obbligazione non produttive di novazione. Difetta l’animus novandi proprio in ragione del fatto che dal contratto di mutuo solutorio non può desumersi alcuna inequivocabile volontà di estinzione della precedente obbligazione.
Il titolo esecutivo azionabile dall’istituto di credito nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario sarà pertanto costituito dal mutuo originario e non dalla successiva modificazione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto.
Per quanto il mutuo si perfezioni con la dazione giuridica delle somme di denaro, che può aversi anche tramite accredito in conto corrente, la traditio deve comunque determinare l’effettivo passaggio delle stesse somme dal mutuante al mutuatario, determinando l’acquisizione della loro disponibilità da parte di quest’ultimo soggetto.
Tutto ciò non si verifica nell’ipotesi in cui l’istituto di credito, già creditore, ripiani il preesistente debito del mutuatario con tali somme di denaro, non avendosi affatto un transito delle medesime dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro soggetto con conseguente trasferimento della proprietà ex art. 1814 c.c. e acquisizione della disponibilità giuridica da parte del mutuatario ex art. 832 c.c.
Affinchè venga a realizzarsi il presupposto della disponibilità giuridica delle somme è in particolar modo necessario che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma fuoriesce dal patrimonio del primo soggetto per fare il suo ingresso in quello del secondo, che potrà così utilizzare il denaro dato a mutuo senza intermediazione del primo.
In assenza di tale passaggio (e quindi in assenza di un effettivo trasferimento della proprietà della somma di denaro in capo al mutuatario) non può ipotizzarsi neppure la sussistenza dell’obbligo di restituzione del tantundem ex art. 1813 c.c.
Il ripianamento del debito preesistente realizzato mediante il cd. mutuo solutorio determina pertanto la mera effettuazione di un’operazione contabile, non producendo l’intesa tra istituto di credito e cliente alcun trasferimento di proprietà del denaro e producendo invece la posta in dare una modifica del saldo del tutto automatica ed immediata.
Fa eccezione il solo caso in cui la posta a credito sia di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto, potendo farsi rientrare la stessa operazione nell’ambito operativo del contratto di mutuo quantomeno per la parte del supero.
La Seconda Sezione della Cassazione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, ha sostanzialmente posto tre quesiti rispetto ai quali le Sezioni Unite hanno dovuto pronunciarsi.
Il primo quesito attiene alla validità o meno del cd. mutuo solutorio, e dunque in sostanza al se sia corretta l’analisi ermeneuticamente effettuata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritario o quella effettuata dall’orientamento minoritario.
Il secondo quesito concerne invece la possibilità di qualificare il contratto di mutuo solutorio come valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in caso di positiva risposta al primo quesito.
Il terzo quesito riguarda infine il se “l’eventuale risposta positiva ai primi due quesiti possa valere anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca «autonomamente e immediatamente», vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario, e ciò «secondo quanto lamentato dai ricorrenti»”[7].
2. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella sentenza n. 5841/2025
Con sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 le Sezioni Unite della Cassazione civile sono giunte a pronunciarsi rispetto ai tre quesiti delineati dalla Seconda Sezione nel mese di luglio 2024[8].
La statuizione in sé, ad avviso di chi scrive, rappresenta un vero e proprio trattato giurisprudenziale in materia di mutuo solutorio, giungendo i giudici di legittimità a compierne una qualificazione particolarmente esaustiva anche mediante l’individuazione dei discrimina rispetto alle figure del pactum de non petendo ad tempus e del mutuo di scopo, il confronto con la figura del mutuo fondiario e la delineazione dei profili rimediali nell’ipotesi di operazione solutoria lesiva della par condicio creditorum.
Per quanto attiene al primo quesito gli Ermellini, dopo aver ribadito che il mutuo è contratto reale il cui perfezionamento si realizza con la traditio della res fungibile, e che non risulta tanto necessaria la consegna materiale della res medesima quanto invece la realizzazione della “disponibilità giuridica” della stessa in favore del mutuatario – “il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo [il mutuatario], fermo restando l’altro elemento costitutivo rappresentato dall’assunzione da parte del mutuatario dell’obbligazione […] di restituire il tantundem”[9] – sostengono che la risoluzione della questione in tema di validità del mutuo solutorio si incentri proprio sul concetto di “disponibilità giuridica”, essendo l’immediata riappropriazione delle somme di denaro mutuate da parte della banca la circostanza genetica del dubbio sul verificarsi dell’effettiva messa a disposizione delle medesime.
Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario, ritenendo che quello minoritario confonda, nel suo metodo di analisi empirico, il giudizio di validità dell’operazione con l’abuso che dell’istituto possa concretamente farsi.
E dunque, in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini statuiscono che, se con il mutuo solutorio si ha riappropriazione del denaro da parte dell’istituto di credito, “per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario”[10].
Per quanto l’accredito sul conto corrente indubbiamente consista in un’operazione contabile, ciò non può indurre a qualificare lo stesso come operazione soltanto apparente, comportando l’atto in questione l’inserimento di una posta attiva in capo al correntista produttiva di veri e propri mutamenti economico-giuridici nei rapporti di dare ed avere con l’istituto di credito mutuante.
In ragione del più frequente ricorso a strumenti alternativi al trasferimento di denaro dovuto tanto alla normativa antiriciclaggio quanto alla dematerializzazione dei valori mobiliari e alla sostituzione degli stessi con annotazioni contabili, l’accredito delle somme sul conto corrente costituisce l’atto perfezionativo del contratto di mutuo nonché determinativo dell’effettivo conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della somma di denaro erogata.
Bisogna prescindere, stando a quanto statuito dalle Sezioni Unite “dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”[11].
Il sintagma “mutuo solutorio” non ha pertanto valenza definitoria di una fattispecie contrattuale atipica, descrivendo una semplice tipologia di impiego del denaro dato a mutuo.
I giudici di legittimità proseguono poi operando un distinguo tra mutuo solutorio e mutuo di scopo, contratto il quale il mutuante si obbliga a fornire al mutuatario le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità prevista ex lege o pattuita nell’esercizio dell’autonomia privata, e il mutuatario si impegna non solo alla restituzione del tantundem ma pure allo svolgimento delle attività necessarie per il raggiungimento dello scopo.
Mentre con il mutuo di scopo la finalità entra nel contratto, inserendosi nel sinallagma e rilevando causalmente, con il mutuo solutorio l’utilizzo del denaro costituisce elemento logicamente successivo al contratto ed esterno ad esso, collocandosi su di un piano assolutamente distinto e non rientrando affatto nel perimetro causale.
Significativa anche la distinzione tra mutuo solutorio e pactum de non petendo, che le Sezioni Unite incentrano in primis sul trasferimento della somma di denaro, presente nel primo ed assente nel secondo. “L’accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”, ed inoltre “se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno «spostamento di denaro» deve essersi necessariamente verificato”[12].
In secundis, spesso il mutuo solutorio non è soltanto accompagnato dalla concessione di una garanzia ipotecaria, ma pure da modificazioni dell’originario rapporto – attinenti a tassi di interesse, modalità di restituzione della somma di denaro, accessori, garanzie personali – che rendono l’operazione eccentrica rispetto al mero pactum de non petendo.
Gli Ermellini sostengono poi che non vi siano ragioni per ritenere aprioristicamente illegittima l’immediata destinazione del denaro al ripianamento di preesistenti debiti tipica del mutuo solutorio, essendo essa espressione di un principio di ordine pubblico e venendo persino tipizzata dal legislatore con riferimento a determinate forme di finanziamento (i giudici di legittimità citano ad esempio l’art. 2 della legge n. 546/1977 e l’art. 16 del r.d.l. n. 765/1977).
Certo è che laddove vengano accertate condotte delittuose poste in essere mediante il ricorso al mutuo solutorio, esse ridonderebbero in un vizio di nullità sul piano negoziale, come condivisibilmente sostenuto dalla più recente giurisprudenza civile di legittimità[13].
Non può inoltre escludersi che lo stesso mutuo solutorio venga utilizzato quale mezzo anomalo di pagamento o al fine di mascherare un atto in frode ai creditori, rilevando tuttavia tali ipotesi in termini di inefficacia e non di invalidità, non venendo violate norme imperative.
Alla lesione della par condicio creditorum derivante dall’abusivo ricorso all’istituto l’ordinamento pone dunque rimedio non con una tutela reale fondata sulla nullità e finalizzata ad eliminare dalla realtà giuridica il contratto di mutuo, ma a mezzo della revocabilità del pagamento o dell’inefficacia delle garanzie abusivamente concesse.
Neppure la finalizzazione di un mutuo fondiario[14] al ripianamento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante può determinare la nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1418, secondo comma, c.c., o la risoluzione dello stesso per inadempimento ex art. 1453 c.c., in quanto è pacifico che la finalità per cui il finanziamento viene concesso non entri nella causa del contratto, data invece dall’immediata disponibilità di una somma di denaro a fronte della concessione di un’ipoteca su bene immobile e dall’obbligo di restituzione del tantundem.
Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla recente giurisprudenza delle Sezioni semplici della Cassazione civile, nessuna delle disposizioni che regola l’istituto impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né obbliga il mutuatario al conseguimento di una precisa finalità e l’istituto mutuante ad operare un controllo sull’utilizzo che della somma di denaro si faccia, venendo in rilievo la sola possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che intende beneficiare della disponibilità di denaro, di garanzia ipotecaria su immobili rustici o urbani[15].
Dalla disciplina civilistica intra codice del contratto di mutuo, la quale opta per un principio di irrilevanza giuridico-strutturale dei motivi del negozio, discende che non possa discorrersi né di nullità né di risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui nel contratto si indichi una destinazione delle somme di denaro differente da quella in concreto realizzata, mentre la previsione nel contratto stesso della destinazione del denaro al ripianamento di debiti preesistenti costituisce mera esteriorizzazione dei motivi soggettivi non rilevanti.
Le considerazioni operate dalle Sezioni Unite relativamente al primo quesito consentono alle stesse di fornire una risposta positiva anche al secondo: la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni presuppone che il mutuo si sia perfezionato (con l’accredito delle somme sul conto corrente), ciò che fa sì che nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. il contratto di mutuo possa costituire valido titolo esecutivo.
Infine, la risposta al terzo quesito discende dalle riflessioni svolte dagli Ermellini rispetto al concetto di “disponibilità giuridica”.
Come già precisato, l’accredito delle somme date a mutuo sul conto corrente del mutuatario intestatario viene a costituire una posta attiva del patrimonio dell’intestatario stesso, determinando così una modificazione della sua situazione debitoria e creditoria.
L’effetto dell’atto accreditativo è allora anche economico-giuridico oltre che meramente contabile, e l’atto stesso determina il perfezionamento del contratto di mutuo e l’acquisizione della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario, con irrilevanza causale della destinazione del denaro al perseguimento del fine del ripianamento dei debiti preesistenti.
Se è indubbio che la disposizione operata dal mutuatario “presuppone (e quindi di per sé dimostra) l’acquisita disponibilità giuridica, […] non è vero anche il contrario, che cioè ove pure si dimostri che quella disposizione non provenga dal mutuatario, per ciò stesso si dovrebbe anche escludere che la disponibilità giuridica non fosse stata in precedenza acquisita”[16].
Un movimento in uscita di somme di denaro dal conto corrente bancario in assenza di disposizioni dell’intestatario a ciò finalizzate costituisce infatti una condotta illecita alla quale l’interessato può senz’altro reagire mediante i rimedi restitutori o risarcitori opportuni, ma resta pur sempre un fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme avvenuta mediante l’atto perfezionativo (ossia l’accredito su conto corrente).
Per le Sezioni Unite, l’eventuale illiceità di quell’atto “non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l’accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina”[17].
Gli Ermellini peraltro statuiscono che tale ipotesi va distinta da quella dell’accredito delle somme date a mutuo su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, perché in tal caso l’estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme sullo stesso conto corrente debitore, ciò che vale anche con riferimento alla materiale disponibilità da parte del mutuatario delle sole somme che eventualmente eccedano il precedente saldo passivo.
“Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l’estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario medesimo, essendone anche l’intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”[18].
Il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite è allora quello per cui il contratto di mutuo si perfeziona nell’istante in cui la somma di denaro mutuata, benchè non ancora consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario (ed è questo anche il momento dal quale viene a gravare in capo al medesimo l’obbligazione restitutoria del tantundem eiusdem generis et qualitatis).
La disponibilità giuridica delle somme in favore del mutuatario può tranquillamente realizzarsi attraverso l’accredito su conto corrente di cui è intestatario, non avendo rilevanza causale la destinazione delle somme al ripianamento dei suoi preesistenti debiti nei confronti della banca mutuante, che è elemento estraneo alla fattispecie contrattuale.
Pur in presenza di questa peculiare destinazione delle somme, il contratto di mutuo (che è poi in sostanza solutorio in ragione dello specifico utilizzo del denaro) costituisce valido titolo esecutivo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c.
Bibliografia e sitografia
“Il mutuo solutorio, caratteristiche e validità: la pronuncia delle Sezioni Unite”, 11 marzo 2025, in www.diritto.it, https://www.diritto.it/mutuo-solutorio-caratteristiche-validita-sezioni/
FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto civile”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024, pagg. 1630 e ss.
STUDIO LEGALE DAL PIAZ, 2 settembre 2024, “MUTUO SOLUTORIO: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE. Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 18903/2024”, in www.studiolegaledalpiaz.it, https://studiolegaledalpiaz.it/blog/mutuo-solutorio-la-parola-alle-sezioni-unite-corte-di-cassazione-sez-ii-ordinanza-interlocutoria-n-18903-2024/
STUDIO LEGALE DAL PIAZ, 11 marzo 2025, “MUTUO SOLUTORIO: LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841 del 3 marzo 2025”, in www.studiolegaledalpiaz.it, https://studiolegaledalpiaz.it/blog/mutuo-solutorio-la-soluzione-delle-sezioni-unite-corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-n-5841-del-3-marzo-2025/
Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20896
Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7740
Cass. Civ., Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 724
Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517
Cass. Civ., Sez. III, 14 aprile 2021, n. 9838
Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2021, n. 37654
Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2023, n. 16377
Cass. Civ., Sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4376
Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903
Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248
Cass. Civ., SS. UU., 5 marzo 2025, n. 5841
[1] Per quanto attiene alla definizione di mutuo ordinario, si argomenta da FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto civile”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024, pagg. 1630 e ss. Relativamente alla nozione di mutuo solutorio, si argomenta invece da “Il mutuo solutorio, caratteristiche e validità: la pronuncia delle Sezioni Unite”, 11 marzo 2025, in www.diritto.it, https://www.diritto.it/mutuo-solutorio-caratteristiche-validita-sezioni/.
[2] Si veda STUDIO LEGALE DAL PIAZ, 11 marzo 2025, “MUTUO SOLUTORIO: LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841 del 3 marzo 2025”, in www.studiolegaledalpiaz.it, https://studiolegaledalpiaz.it/blog/mutuo-solutorio-la-soluzione-delle-sezioni-unite-corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-n-5841-del-3-marzo-2025/
[3] Si veda “Il mutuo solutorio, caratteristiche e validità: la pronuncia delle Sezioni Unite”, 11 marzo 2025, cit.
[4] Gli orientamenti contrastanti oggetto di composizione sono sinteticamente descritti anche in STUDIO LEGALE DAL PIAZ, 2 settembre 2024, “MUTUO SOLUTORIO: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE. Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 18903/2024”, in www.studiolegaledalpiaz.it, https://studiolegaledalpiaz.it/blog/mutuo-solutorio-la-parola-alle-sezioni-unite-corte-di-cassazione-sez-ii-ordinanza-interlocutoria-n-18903-2024/.
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2021, n. 37654; Cass. Civ., Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2023, n. 16377.
[6] Si veda Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7740; Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517.
[7] Cit. testualmente da Cass. Civ., SS. UU., 5 marzo 2025, n. 5841.
[8] Un’attenta analisi della recentissima statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite viene fornita anche in STUDIO LEGALE DAL PIAZ, 11 marzo 2025, “MUTUO SOLUTORIO: LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841 del 3 marzo 2025”, cit., da cui in parte si argomenta.
[9] Cit. testualmente da Cass. Civ., SS. UU., 5 marzo 2025, n. 5841.
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Idem.
[13] Si veda Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248 e Cass. Civ., Sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4376.
[14] Con il quale, ex art. 38 T.U.B., l’istituto di credito concede un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all’80% del valore degli immobili offerti in garanzia dal mutuatario.
[15] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14 aprile 2021, n. 9838; Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517.
[16] Cit. testualmente da Cass. Civ., SS. UU., 5 marzo 2025, n. 5841.
[17] Idem.
[18] Idem.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Davide Cerrato
Dottore in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno con votazione pari a 110 e lode con menzione speciale alla carriera e con tesi di laurea sperimentale in Diritto del lavoro dal titolo "Qualificazione giuridica dello «smaining» e costruzione di un reticolo (o mosaico) di tutela «ultra-reiterazione»".
Già autore presso la rivista scientifico-giuridica online "Il diritto amministrativo" (www.ildirittoamministrativo.it).







