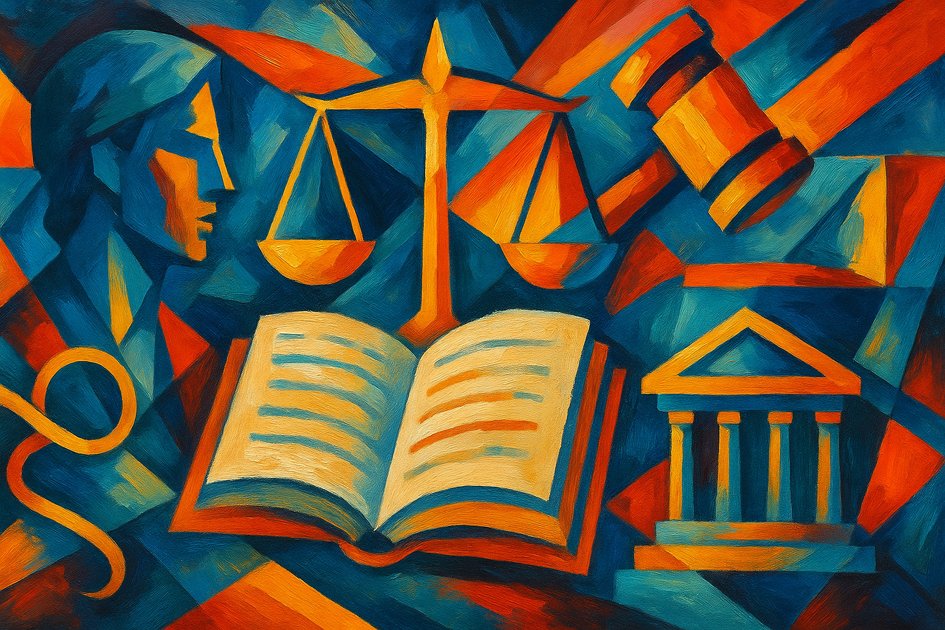
Obbligo di motivazione negli esami forensi: il contrasto giurisprudenziale
avv. Eugenio Catania e avv. Flavia Cascino
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Quadro Normativo di Riferimento – 2.1 L’Art. 3 della Legge 241/1990 e l’Obbligo Generale di Motivazione – 2.2 La Disciplina Specifica degli Esami di Abilitazione Forense – 2.3 Il Principio Costituzionale del Buon Andamento – 3. Il Contrasto Giurisprudenziale: Due Orientamenti a Confronto – 3.1 L’Orientamento dei Tribunali Amministrativi Regionali – 3.2 L’Orientamento del Consiglio di Stato e del CGARS – 4. I Criteri di Valutazione e la loro Genericità – 4.1 La Problematica dei Criteri Generici – 4.2 Il Rapporto tra Criteri e Motivazione – 5. La Discrezionalità Tecnica delle Commissioni Esaminatrici – 5.1 Natura e Limiti della Discrezionalità Tecnica – 5.2 Il Sindacato Giurisdizionale – 6. Le Esigenze di Buon Andamento e Efficienza – 6.1 Il Bilanciamento tra Trasparenza ed Efficienza – 6.2 La Proporzionalità degli Obblighi Motivazionali – 7. I Segni di Riconoscimento e l’Annullamento delle Prove – 7.1 La Problematica dei Segni di Riconoscimento – 7.2 L’Onere della Prova e la Buona Fede del Candidato – 8. Le Prospettive di Riforma e Armonizzazione – 8.1 La Necessità di Criteri Uniformi – 8.2 Il Modello della Riforma Forense – 9. L’Evoluzione della Giurisprudenza Costituzionale – 9.1 Il Ruolo della Corte Costituzionale – 9.2 L’Influenza del Diritto Europeo – 10. Conclusioni
Il presente contributo analizza l’evoluzione giurisprudenziale relativa all’obbligo di motivazione nei provvedimenti delle commissioni esaminatrici negli esami di abilitazione alla professione forense, con particolare riferimento al contrasto interpretativo emerso tra i Tribunali Amministrativi Regionali e la giurisprudenza di legittimità. L’analisi prende spunto da casi giurisprudenziali che evidenziano le criticità nell’applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 alle procedure concorsuali e abilitative, nonché i profili di bilanciamento tra principi di trasparenza, diritto di difesa e buon andamento dell’azione amministrativa.
1. Introduzione
La questione dell’obbligo di motivazione nei provvedimenti delle commissioni esaminatrici rappresenta uno dei nodi più controversi del diritto amministrativo contemporaneo, caratterizzato da un persistente contrasto interpretativo tra diversi orientamenti giurisprudenziali. Il caso degli esami di abilitazione alla professione forense costituisce un paradigma emblematico di tale problematica, evidenziando la tensione tra l’esigenza di garantire trasparenza e diritto di difesa ai candidati e la necessità di assicurare efficienza e speditezza alle procedure concorsuali.
I casi oggetto di analisi presentano elementi di particolare interesse: candidati non ammessi alle prove orali per insufficienza del punteggio conseguito nelle prove scritte, commissioni che si limitano ad attribuire voti numerici senza ulteriori specificazioni, e la conseguente richiesta di annullamento per violazione dell’obbligo di motivazione.
L’esame di tali fattispecie consente di approfondire questioni di rilevante interesse teorico e pratico, dalla natura giuridica della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici alla determinazione dei limiti del sindacato giurisdizionale.
2. Il Quadro Normativo di Riferimento
2.1 L’Art. 3 della Legge 241/1990 e l’Obbligo Generale di Motivazione
L’art. 3 della Legge 241/1990 stabilisce il principio generale secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. La norma specifica che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Tale disposizione ha rappresentato una svolta fondamentale nell’ordinamento amministrativo italiano, introducendo un obbligo generale di motivazione che si estende espressamente anche ai pubblici concorsi. Tuttavia, l’applicazione di tale principio alle procedure concorsuali e abilitative ha generato significative incertezze interpretative, particolarmente evidenti nel settore degli esami di abilitazione professionale.
2.2 La Disciplina Specifica degli Esami di Abilitazione Forense
L’art. 46 della Legge 247/2012 ha introdotto una disciplina innovativa per gli esami di abilitazione alla professione forense, prevedendo al comma 5 che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Tale disposizione, pur non ancora pienamente operativa per effetto delle proroghe legislative, rappresenta un chiaro orientamento del legislatore verso un rafforzamento degli obblighi motivazionali nelle procedure di abilitazione professionale. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tale norma costituisce un criterio interpretativo significativo per la valutazione della disciplina vigente.
2.3 Il Principio Costituzionale del Buon Andamento
L’art. 97 della Costituzione sancisce che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Tale principio assume particolare rilevanza nel bilanciamento tra esigenze di trasparenza e necessità di efficienza nelle procedure concorsuali, caratterizzate spesso da un elevato numero di partecipanti e da tempi ristretti per lo svolgimento delle operazioni.
3. Il Contrasto Giurisprudenziale: Due Orientamenti a Confronto
3.1 L’Orientamento dei Tribunali Amministrativi Regionali
La maggioranza dei Tribunali Amministrativi Regionali ha sviluppato un orientamento rigoroso in materia di motivazione, ritenendo insufficiente il mero voto numerico per giustificare un giudizio di non idoneità. Come evidenziato dal TAR Sicilia-Catania nella sentenza n. 67/2011, “la valutazione negativa delle prove scritte di un concorso pubblico, che determina la non ammissione del candidato alle successive prove orali, deve essere adeguatamente motivata dalla commissione esaminatrice, non essendo sufficiente il mero punteggio numerico”.
Secondo tale orientamento, l’obbligo di motivazione impone alla commissione di rendere ricostruibile per il candidato il percorso logico seguito nella valutazione, individuando gli aspetti della prova non valutati positivamente. La mancanza di annotazioni, correzioni o segni grafici sugli elaborati viene considerata un vizio che inficia la legittimità del provvedimento di esclusione.
3.2 L’Orientamento del Consiglio di Stato e del CGARS
Per contro, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento più permissivo, ritenendo sufficiente il voto numerico quando attribuito in base a criteri predeterminati. Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 688/2013, “la commissione esaminatrice negli esami di abilitazione alla professione di avvocato può legittimamente esprimere la propria valutazione sugli elaborati scritti dei candidati assegnando ad essi solo un voto numerico, senza necessità di ulteriori motivazioni dettagliate”.
Tale orientamento si fonda sulla considerazione che il voto numerico, lungi dall’indicare solo il risultato della verifica, si traduce in un giudizio complessivo sulla prova espletata, che rende palese l’apprezzamento dell’organo esaminatore e risulta suscettibile di sindacato giurisdizionale.
4. I Criteri di Valutazione e la loro Genericità
4.1 La Problematica dei Criteri Generici
Un aspetto centrale della controversia riguarda la genericità dei criteri di valutazione elaborati dalle commissioni centrali. Nei casi esaminati, i criteri includono elementi quali “correttezza della forma grammaticale”, “chiarezza espositiva”, “conoscenza dei fondamenti teorici” e “capacità di argomentazione”, che per la loro ampiezza e indeterminatezza non consentono una valutazione oggettiva dell’operato delle commissioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la genericità dei criteri comporta l’incongruità del giudizio espresso mediante semplice voto numerico. Secondo il principio consolidato, tanto maggiore è la puntualità dei criteri, tanto minore sarà il margine di discrezionalità rimesso alla commissione e tanto minore sarà l’esigenza di motivare la valutazione.
4.2 Il Rapporto tra Criteri e Motivazione
La correlazione tra specificità dei criteri e obbligo di motivazione rappresenta un elemento chiave per la risoluzione del contrasto interpretativo. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la questione relativa all’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione deve essere risolta non in astratto, ma in concreto, facendo riferimento alla tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione.
Il punteggio risulta sufficiente solo quando i criteri siano predeterminati rigidamente, mentre diventa insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche, imponendosi in tal caso che alla sintetica valutazione si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo.
5. La Discrezionalità Tecnica delle Commissioni Esaminatrici
5.1 Natura e Limiti della Discrezionalità Tecnica
La valutazione delle prove d’esame da parte delle commissioni esaminatrici costituisce espressione di discrezionalità tecnica, caratterizzata da un ampio margine di apprezzamento finalizzato a stabilire l’idoneità tecnica, culturale e attitudinale dei candidati. Come evidenziato dal TAR Sicilia-Catania nella sentenza n. 357/2012, “la valutazione delle prove d’esame da parte delle commissioni giudicatrici costituisce l’espressione di un ampio potere discrezionale finalizzato a stabilire l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati”.
Tuttavia, tale discrezionalità non può scadere nella mera arbitrarietà, rimanendo soggetta al sindacato giurisdizionale nei casi di manifesta illogicità, errore di fatto o contraddittorietà. Il giudice amministrativo mantiene il potere di verificare la ragionevolezza e la coerenza delle valutazioni espresse, pur non potendo sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
5.2 Il Sindacato Giurisdizionale
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici è limitato alla verifica dell’esistenza di vizi logici macroscopici o di travisamento dei fatti. Come precisato dalla giurisprudenza consolidata, il controllo giurisdizionale non può estendersi al merito delle valutazioni tecniche, ma deve limitarsi alla verifica della legittimità del procedimento valutativo e della ragionevolezza delle conclusioni raggiunte.
Tale limitazione del sindacato giurisdizionale trova giustificazione nella natura specialistica delle valutazioni richieste e nella necessità di preservare l’autonomia tecnica delle commissioni esaminatrici, composte da esperti della materia dotati delle competenze necessarie per valutare l’idoneità professionale dei candidati.
6. Le Esigenze di Buon Andamento e Efficienza
6.1 Il Bilanciamento tra Trasparenza ed Efficienza
Un elemento centrale del dibattito giurisprudenziale riguarda il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e diritto di difesa dei candidati e la necessità di assicurare efficienza e speditezza alle procedure concorsuali. Come evidenziato dal CGARS nella sentenza n. 687/2013, “tale impostazione risponde a esigenze di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, tenuto conto dei tempi e del numero dei partecipanti alle prove”.
L’elevato numero di candidati che partecipano agli esami di abilitazione professionale e i tempi ristretti per lo svolgimento delle operazioni di correzione rendono problematica l’imposizione di obblighi motivazionali dettagliati, che potrebbero compromettere l’efficienza del sistema e determinare ritardi significativi nella conclusione delle procedure.
6.2 La Proporzionalità degli Obblighi Motivazionali
La determinazione degli obblighi motivazionali deve tenere conto del principio di proporzionalità, bilanciando le esigenze di tutela dei diritti dei candidati con le necessità organizzative e funzionali delle procedure concorsuali. L’imposizione di obblighi eccessivamente gravosi potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa senza apportare benefici significativi in termini di tutela dei diritti.
Tuttavia, tale bilanciamento non può giustificare l’eliminazione completa degli obblighi motivazionali, dovendo essere individuate soluzioni che garantiscano un livello minimo di trasparenza senza compromettere l’efficienza delle procedure.
7. I Segni di Riconoscimento e l’Annullamento delle Prove
7.1 La Problematica dei Segni di Riconoscimento
Un aspetto specifico emerso dai casi esaminati riguarda l’annullamento delle prove per la presenza di presunti segni di riconoscimento. La giurisprudenza ha chiarito che l’annullamento per tale motivo richiede la dimostrazione dell’intenzionalità del candidato nel rendere riconoscibile il proprio elaborato, non essendo sufficiente la mera presenza di elementi anomali.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, i segni di riconoscimento devono avere “carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato” e non devono essere altrimenti spiegabili se non con riferimento all’intendimento di rendere l’elaborato riconoscibile. La presenza di elementi di uso comune, come adesivi utilizzati come segnalibri, non può giustificare l’annullamento delle prove in assenza di una chiara volontà identificativa.
7.2 L’Onere della Prova e la Buona Fede del Candidato
L’accertamento della volontà di farsi riconoscere richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso, tenendo conto della buona fede del candidato e delle modalità di svolgimento delle prove. La presenza di elementi potenzialmente identificativi nella brutta copia, che il candidato non era obbligato a consegnare, depone per l’assenza di intenzionalità nell’identificazione.
La commissione deve dimostrare, attraverso elementi oggettivi e inequivocabili, la volontà del candidato di rendersi riconoscibile, non potendo limitarsi a presunzioni o valutazioni superficiali che non tengano conto del contesto complessivo della prova.
8. Le Prospettive di Riforma e Armonizzazione
8.1 La Necessità di Criteri Uniformi
L’analisi del contrasto giurisprudenziale evidenzia la necessità di un intervento normativo che chiarisca definitivamente gli obblighi motivazionali nelle procedure concorsuali e abilitative. L’attuale incertezza interpretativa genera disparità di trattamento tra candidati e compromette la certezza del diritto.
L’introduzione di criteri uniformi e specifici per la valutazione delle prove, accompagnati da obblighi motivazionali proporzionati, potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata che garantisca trasparenza senza compromettere l’efficienza delle procedure.
8.2 Il Modello della Riforma Forense
L’art. 46 della Legge 247/2012, pur non ancora pienamente operativo, fornisce un modello di riferimento per la risoluzione del contrasto interpretativo. La previsione di annotazioni positive o negative sui vari punti di ciascun elaborato rappresenta una soluzione che bilancia le esigenze di trasparenza con quelle di efficienza, fornendo al candidato elementi sufficienti per comprendere la valutazione senza imporre oneri eccessivi alle commissioni.
Tale modello potrebbe essere esteso ad altre procedure concorsuali e abilitative, contribuendo all’armonizzazione della disciplina e alla risoluzione delle incertezze interpretative attualmente esistenti.
9. L’Evoluzione della Giurisprudenza Costituzionale
9.1 Il Ruolo della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha fornito importanti indicazioni sulla questione dell’obbligo di motivazione nei concorsi pubblici, escludendo che la tesi dell’inesistenza di tale obbligo costituisca “diritto vivente”. Tale orientamento ha contribuito al consolidamento della giurisprudenza favorevole all’estensione degli obblighi motivazionali anche alle procedure concorsuali.
Tuttavia, la Corte non ha fornito indicazioni specifiche sulle modalità di adempimento di tale obbligo, lasciando alla giurisprudenza amministrativa il compito di definire i contenuti concreti degli obblighi motivazionali nelle diverse tipologie di procedure.
9.2 L’Influenza del Diritto Europeo
L’evoluzione del diritto europeo in materia di buona amministrazione e diritti procedimentali ha influenzato l’interpretazione degli obblighi motivazionali nell’ordinamento interno. I principi di trasparenza e diritto di difesa, consolidati nella giurisprudenza europea, hanno contribuito al rafforzamento delle garanzie procedimentali anche nelle procedure concorsuali nazionali.
Tale influenza si manifesta particolarmente nell’interpretazione estensiva dell’obbligo di motivazione e nella valorizzazione del diritto del candidato a comprendere le ragioni delle valutazioni negative espresse dalle commissioni esaminatrici.
10. Conclusioni
L’analisi dei casi esaminati evidenzia la complessità delle problematiche giuridiche che caratterizzano l’applicazione dell’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali e abilitative. Il persistente contrasto tra diversi orientamenti giurisprudenziali riflette la difficoltà di bilanciare esigenze spesso contrapposte: la tutela dei diritti dei candidati e l’efficienza dell’azione amministrativa.
Dal punto di vista sostanziale, emerge chiaramente la necessità di superare l’attuale incertezza interpretativa attraverso un intervento normativo che definisca criteri uniformi e proporzionati per l’adempimento degli obblighi motivazionali. La genericità dei criteri di valutazione attualmente utilizzati non consente una valutazione oggettiva dell’operato delle commissioni e genera inevitabili disparità di trattamento.
La soluzione prospettata dall’art. 46 della Legge 247/2012, basata sull’annotazione di osservazioni positive o negative sui vari punti degli elaborati, rappresenta un modello equilibrato che potrebbe essere esteso ad altre procedure concorsuali. Tale approccio garantisce un livello adeguato di trasparenza senza imporre oneri eccessivi alle commissioni esaminatrici.
Dal punto di vista processuale, la limitazione del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti appare giustificata dalla natura tecnica delle valutazioni richieste. Tuttavia, tale limitazione non può giustificare l’eliminazione completa degli obblighi motivazionali, dovendo essere garantito un livello minimo di trasparenza che consenta al candidato di comprendere le ragioni delle valutazioni negative.
La questione dei segni di riconoscimento evidenzia inoltre la necessità di criteri oggettivi e rigorosi per l’annullamento delle prove, che tengano conto della buona fede del candidato e delle concrete modalità di svolgimento degli esami. L’applicazione di criteri eccessivamente rigorosi può determinare ingiuste penalizzazioni di candidati che non avevano alcuna intenzione di rendersi riconoscibili.
In prospettiva, l’armonizzazione della disciplina attraverso l’introduzione di criteri uniformi e la definizione di obblighi motivazionali proporzionati rappresenta un obiettivo prioritario per garantire certezza del diritto e parità di trattamento. Solo attraverso un approccio equilibrato, che tenga conto tanto delle esigenze di trasparenza quanto di quelle di efficienza, sarà possibile superare l’attuale contrasto interpretativo e assicurare un sistema di procedure concorsuali e abilitative che rispetti i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalle pronunce citate, fornisce già oggi orientamenti chiari sui principali profili della questione, ma l’evoluzione normativa e l’emergere di nuove esigenze di tutela richiedono un costante aggiornamento degli strumenti di garanzia. L’obiettivo deve essere quello di costruire un sistema che, pur mantenendo l’efficienza necessaria per il funzionamento delle procedure, garantisca ai candidati un livello adeguato di trasparenza e possibilità di difesa, in coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento amministrativo e costituzionale.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Eugenio Catania
Ultimi post di Avv. Eugenio Catania (vedi tutti)
- La diffamazione a mezzo radio e mezzi di comunicazione di massa - 28 Settembre 2025
- Diffamazione radiofonica: cronaca, satira e limiti - 16 Agosto 2025
- Obbligo di motivazione negli esami forensi: il contrasto giurisprudenziale - 16 Agosto 2025







