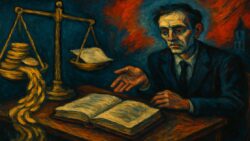Permuta e vendita: differenze, compatibilità e natura giuridica
Il contratto di permuta negli ordinamenti moderni è stato travolto, come ha evidenziato attenta dottrina, dal contratto di compravendita.
Non vi è dubbio che la permuta e la vendita sono contratti affini che sono basati sullo stesso nucleo di regole; tuttavia, il concetto di affinità non deve indurre in errore, in quanto non vi può essere un completo appiattimento tra i due contratti.
La regola necessaria è quella volta ad individuare il discrimen tra i due contratti per poter fissare il regime di disciplina applicabile.
Il codice civile del 1942 nel disciplinare il contratto di permuta, avverte la necessità di inserire una norma, l’articolo 1555 c.c., con cui dispone che le norme sulla vendita si applicano alla permuta in quanto compatibili.
Il giudizio di compatibilità, che deve guidare l’interprete, va inteso su un piano funzionale e non meramente strutturale, per cui non troveranno applicazione le norme previste per la vendita quando da esse deriverebbe un risultato meno favorevole per le parti.
La permuta viene definita dall’articolo 1552 c.c. come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento tra le parti della proprietà di cose o di altri diritti.
Si tratta di un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, commutativo e ad effetti reali.
Al pari del contratto di compravendita, da un punto di vista funzionale, la permuta è un contratto di scambio, dal momento che consiste nella vicenda traslativa del diritto.
La differenza tra permuta e vendita, secondo l’orientamento tradizionale ormai consolidato, si rinviene nell’oggetto di scambio.
Nella vendita lo scambio intercorre tra il bene, o il diritto, e il prezzo; invece, nella permuta lo scambio si ha tra due beni o due diritti.
Laddove una delle prestazioni consista in un facere, occorre chiarire l’esatta qualificazione della permuta, dal momento che questo contratto ha natura essenzialmente traslativa.
La giurisprudenza ha chiarito la questione nel seguente modo.
Quando il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull’area stessa, a cura e mezzi della persona del cessionario, si ha un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuri, laddove il sinallagma negoziale consista in un trasferimento reciproco e con effetto immediato sulla proprietà e differito della cosa futura.
Laddove le parti, invece, si obbligano l’una a costruire un edificio e l’altra a cederlo, in tutto o in parte, quale compenso, tale contratto ha effetti obbligatori e consiste in un do ut facias, analogo alla fattispecie contrattuale di cui agli articoli 1664 ss c.c., il contratto d’appalto, dal quale differisce per la mancanza del corrispettivo in denaro.
Trattasi di una permuta atipica, non del tutto coincidente con quella delineata dal codice civile.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Michela Falcone
Ultimi post di Michela Falcone (vedi tutti)
- La mistake of law rule: una situazione affidante - 26 Ottobre 2025
- Il caso francese: il contratto di affidamento fiduciario - 19 Ottobre 2025
- Il dominio transitorio - 12 Ottobre 2025