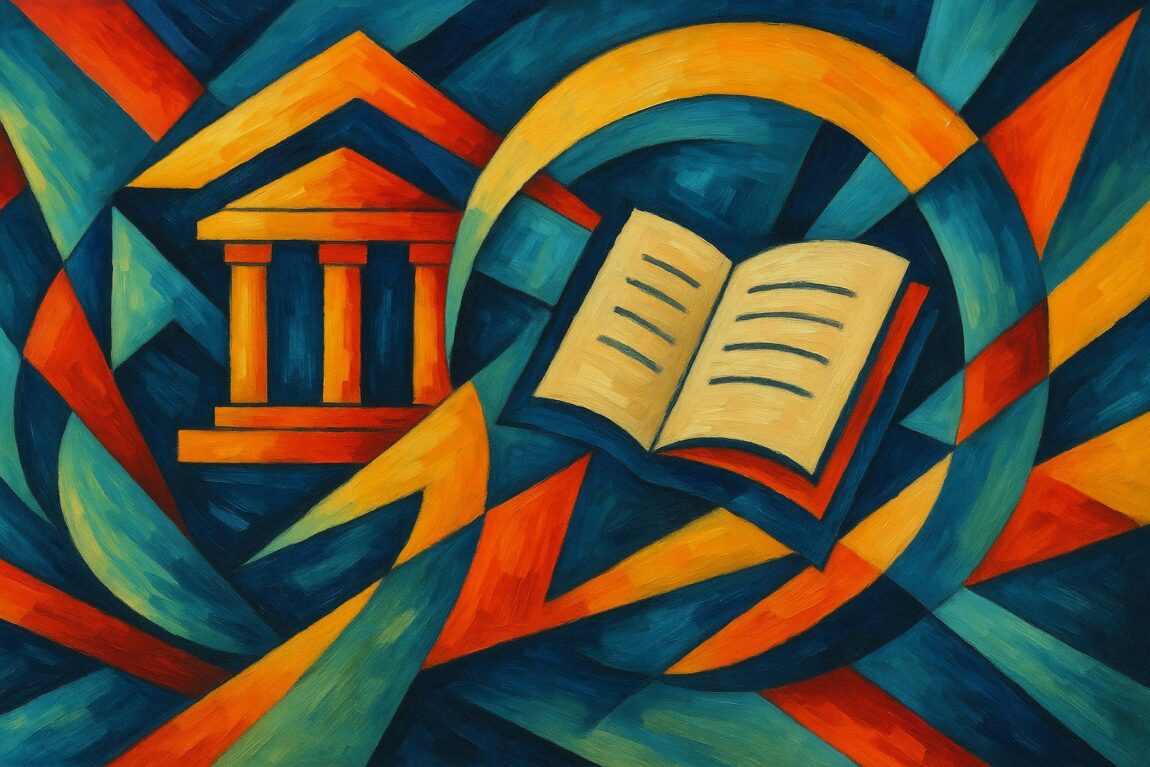
Potestà statutaria degli enti pubblici: natura, limiti e gerarchia nel sistema delle fonti
Sommario: 1. Statuto e potestà statutaria: profili generali – 2. La natura “costituzionale” dello Statuto nell’amministrazione indiretta – 3. Pseudo-statuti e autonomia fittizia – 4. La supremazia dello statuto rispetto agli altri regolamenti – 5. Enti privati ad evidenza pubblica: statuti tra diritto comune e vincoli pubblici – 6. Il potere regolamentare degli enti: generalità e subordinazione
Il tema della potestà statutaria rappresenta uno snodo cruciale nella riflessione giuridico-amministrativa contemporanea. In un contesto sempre più caratterizzato dalla diversificazione organizzativa della pubblica amministrazione, comprendere il significato, la portata e i limiti degli statuti adottati dagli enti pubblici è essenziale per delineare il quadro delle autonomie e delle responsabilità istituzionali. Lo statuto, lungi dall’essere un semplice regolamento interno, è oggi il perno attorno al quale ruota la capacità di autorganizzazione degli enti dotati di personalità giuridica pubblica.
1. Statuto e potestà statutaria: profili generali
La potestà statutaria si distingue dal più generico potere regolamentare. Essa non si traduce semplicemente nella capacità di produrre norme secondarie, ma si configura come espressione di una autonomia organizzativa rafforzata, la quale trova attuazione nello Statuto: un atto normativo che definisce la struttura dell’ente, i suoi organi, le modalità di funzionamento e i principi fondamentali dell’attività istituzionale.
Benché formalmente rientri nel novero delle fonti regolamentari, lo Statuto assume una posizione superiore rispetto ai regolamenti attuativi. In termini di gerarchia delle fonti, esso occupa un livello intermedio, subordinato alla legge e ai regolamenti statali, ma superiore rispetto ai regolamenti interni degli enti pubblici.
Non tutti gli enti pubblici sono però titolari della potestà statutaria. Essa è attribuita espressamente da norme primarie che riconoscono ad alcuni soggetti, come i comuni, le province o le università, un diritto alla propria autorganizzazione. L’attribuzione, quindi, non è automatica, ma condizionata alla presenza di una clausola attributiva di rango legislativo.
2. La natura “costituzionale” dello Statuto nell’amministrazione indiretta
In alcune tipologie di enti, lo Statuto assume una funzione quasi “costitutiva”. Questo è particolarmente vero per i soggetti appartenenti all’amministrazione indiretta, i quali traggono la propria identità giuridica e istituzionale proprio dallo Statuto. In questi casi, lo Statuto non è solo uno strumento operativo, ma è anche il documento che fondamenta l’esistenza e la missione dell’ente, delimitandone ambiti di competenza, relazioni istituzionali e modalità operative.
Ne deriva che, per tali enti, lo Statuto non è solo espressione di autonomia, ma è anche la carta fondamentale, il documento che sancisce la legittimità dell’azione amministrativa esercitata in nome della pubblica funzione.
3. Pseudo-statuti e autonomia fittizia
In contrapposizione alla potestà statutaria propriamente detta, si pongono i cosiddetti pseudo-statuti: atti formalmente definiti “statuti”, ma di fatto imposti direttamente dal legislatore. Questi documenti non derivano da un processo autonomo di deliberazione da parte dell’ente, bensì sono predisposti dal legislatore statale e imposti all’ente pubblico, che è tenuto ad accettarli e applicarli senza possibilità di modificarne il contenuto.
Un esempio emblematico è quello delle Regioni a statuto speciale, i cui statuti sono adottati tramite leggi costituzionali. In tal caso, nonostante la denominazione “autonomo”, lo statuto non è frutto di una potestà autonoma, bensì manifestazione della volontà legislativa statale. Al contrario, gli statuti delle regioni ordinarie, pur essendo adottati con legge regionale, derivano dalla potestà legislativa delle medesime, e quindi non integrano una forma di potestà statutaria in senso stretto.
4. La supremazia dello statuto rispetto agli altri regolamenti
Uno degli aspetti più rilevanti della potestà statutaria è la posizione gerarchica che lo Statuto occupa nell’ordinamento interno degli enti pubblici. Esso si colloca al di sopra dei regolamenti attuativi, i quali devono necessariamente conformarsi alle disposizioni statutarie. Questo principio è rafforzato dal fatto che la procedura di adozione dello statuto è più rigorosa, spesso prevedendo maggioranze qualificate, tempi di pubblicazione più lunghi e, talvolta, forme di controllo esterno (come l’esame da parte degli organi di governo sovraordinati o della Corte dei Conti).
Lo statuto, dunque, rappresenta la fonte di secondo livello che orienta e condiziona l’intera produzione regolamentare dell’ente, assicurando coerenza tra le scelte organizzative di fondo e la disciplina attuativa di dettaglio.
5. Enti privati ad evidenza pubblica: statuti tra diritto comune e vincoli pubblici
Particolare attenzione merita il caso degli enti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici, come fondazioni, associazioni riconosciute o società a partecipazione pubblica. In questi casi, la figura giuridica privata è spesso lo strumento attraverso cui si esplica una funzione pubblica. Di conseguenza, anche se formalmente lo statuto è redatto secondo i canoni del diritto privato, esso è sostanzialmente condizionato da finalità pubbliche.
Un esempio paradigmatico è costituito dalle fondazioni bancarie, il cui statuto – pur teoricamente redatto in autonomia – è stato nella pratica pesantemente condizionato dalla legislazione di settore, in particolare dalla legge n. 461/1998 e dal decreto legislativo n. 153/1999 (il cosiddetto “corpus normativo Ciampi”). Tali norme hanno imposto vincoli stringenti sulla governance, sulle finalità istituzionali e sulla composizione degli organi, rendendo di fatto uniformi gli statuti delle fondazioni, al punto da comprometterne ogni reale autonomia organizzativa.
In casi simili, si assiste a una ibridazione del potere statutario, che oscilla tra autonomia negoziale e vincolo pubblicistico, tra libertà di autorganizzazione e rispetto di una funzione d’interesse generale.
6. Il potere regolamentare degli enti: generalità e subordinazione
Accanto alla potestà statutaria, permane per tutti gli enti pubblici – o ad evidenza pubblica – una generale potestà regolamentare. Questo potere, meno intenso di quello statutario, si concretizza nella possibilità di adottare regolamenti interni che disciplinano aspetti specifici dell’organizzazione o dell’attività amministrativa.
Tale potere è generalmente riconosciuto a tutti gli enti, indipendentemente dal fatto che essi dispongano o meno di potestà statutaria. Tuttavia, i regolamenti restano gerarchicamente subordinati agli statuti, quando esistenti, e ai regolamenti statali, in particolare a quelli governativi di esecuzione, ai sensi dell’art. 4 delle preleggi al Codice Civile.
La gerarchia normativa, in ambito regolamentare, può dunque essere così sintetizzata:
Norme di legge (costituzionali e ordinarie);
Regolamenti governativi;
Statuti degli enti (quando previsti);
Regolamenti degli enti pubblici.
La potestà statutaria si conferma come un indicatore privilegiato del grado di autonomia di un ente pubblico, soprattutto in relazione alla sua capacità di autorganizzarsi, scegliere la propria forma di governo interno e definire le regole essenziali per lo svolgimento della propria missione istituzionale.
Tuttavia, essa non è sinonimo di indipendenza assoluta. La necessità di conformarsi ai principi costituzionali, alla legislazione statale e – in taluni casi – ai regolamenti di attuazione ministeriali o governativi, impone limiti sostanziali all’autonomia statutaria.
In una pubblica amministrazione sempre più segmentata tra enti classici, enti a statuto speciale, enti di diritto privato a funzione pubblica e organismi partecipati, lo statuto diventa lo strumento di equilibrio tra libertà organizzativa e funzione pubblicistica. Un ponte necessario per traghettare l’autonomia nella legalità, e per garantire che ogni ente, pur nella propria specificità, sia parte coerente del più ampio disegno costituzionale dell’amministrazione pubblica.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Riccardo Renzi
Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.
Ultimi post di Riccardo Renzi (vedi tutti)
- La motivazione del provvedimento amministrativo: una garanzia sostanziale di legalità, trasparenza e partecipazione - 27 Dicembre 2025
- Contratti attivi e affidamento nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato: verso una nuova stagione di legalità amministrativa - 2 Novembre 2025
- Il principio del tempus regit actum e la legittimità del deposito cauzionale per i ripristini stradali: tra potestà regolamentare e tutela del bene pubblico - 26 Ottobre 2025







