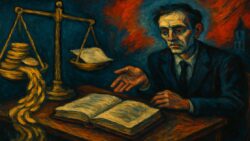Diritto del sistema finanziario e tutela del cliente: trasparenza, costi e ius variandi
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il diritto del sistema finanziario e l’impresa finanziaria: obiettivi di tutela del cliente e integrità del mercato – 3. La disciplina della trasparenza bancaria – 4. Trasparenza e sintesi del costo nei contratti bancari – 5. La forma scritta nei contratti bancari tra neo-formalismo e tutela del cliente – 6. Il contenimento dei costi nei rapporti bancari: anatocismo, usura, remunerazione degli affidamenti e disciplina delle spese – 7. Lo ius variandi nei rapporti bancari: disciplina normativa, limiti applicativi e tutela del cliente
Abstract
Il lavoro analizza l’evoluzione della disciplina del diritto bancario e finanziario con particolare attenzione alla tutela del cliente e all’integrità del mercato. Dopo aver delineato gli obiettivi fondamentali della regolazione nei tre comparti – bancario, mobiliare e assicurativo – viene approfondito il quadro normativo multilivello (nazionale, unionale e internazionale), che ha progressivamente introdotto regole di trasparenza, obblighi informativi e forme di neo-formalismo contrattuale. La ricerca esamina i principali strumenti di protezione del contraente debole: dall’informazione precontrattuale alla sintesi dei costi (TAEG, ICC), dalla forma scritta dei contratti bancari alle regole sul contenimento dei costi (anatocismo, usura, remunerazione degli affidamenti, disciplina delle spese). Particolare rilievo è attribuito alla disciplina dello ius variandi, quale meccanismo di riequilibrio del rapporto contrattuale nel tempo, analizzato nei suoi limiti applicativi e nelle tutele previste a favore del cliente. L’indagine evidenzia come il diritto del sistema finanziario si configuri oggi quale diritto della protezione, fondato su un bilanciamento tra libertà contrattuale, innovazione dei mercati e salvaguardia di interessi collettivi. La prospettiva emersa sottolinea l’interconnessione fra tutela del cliente e stabilità sistemica, mostrando come la fiducia degli utenti costituisca condizione essenziale per l’efficienza e la sostenibilità del mercato finanziario.
1. Introduzione
Il diritto del sistema finanziario rappresenta oggi uno dei settori più dinamici e complessi dell’ordinamento giuridico, in cui la tradizionale centralità del contratto incontra le esigenze di regolazione derivanti dalla tutela del cliente e dalla salvaguardia dell’integrità del mercato. A partire dagli anni ’90, con l’apertura del mercato unico europeo e la crescente sofisticazione degli strumenti finanziari, si è progressivamente consolidata una disciplina multilivello – nazionale, unionale e internazionale – capace di incidere in modo profondo sul contenuto e sulla struttura dei rapporti tra intermediari e clientela.
Il legislatore e le autorità di vigilanza hanno progressivamente introdotto obblighi informativi, forme di neo-formalismo contrattuale e strumenti di riequilibrio economico volti a ridurre le asimmetrie tipiche delle relazioni finanziarie. In tale prospettiva, trasparenza, correttezza e diligenza non costituiscono soltanto clausole generali di comportamento, ma principi-cardine di un sistema che si prefigge di garantire, al contempo, la protezione del contraente debole e la stabilità del mercato.
Il percorso di evoluzione normativa si intreccia con fenomeni strutturali quali la digitalizzazione dei servizi bancari, l’integrazione europea, la diffusione di prodotti sempre più complessi e l’ingresso di nuovi operatori (fintech, istituti di pagamento, piattaforme di criptovalute). Tali cambiamenti hanno reso necessario un costante aggiornamento del quadro regolatorio, che, superando i limiti del codice civile, ha progressivamente delineato un diritto speciale dei contratti finanziari.
Il presente lavoro intende analizzare le principali aree tematiche di questo processo: la disciplina della trasparenza bancaria e della sintesi dei costi; la funzione protettiva della forma scritta nei contratti bancari; gli strumenti di contenimento dei costi, quali anatocismo, usura e remunerazione degli affidamenti; e infine lo ius variandi, quale emblema del delicato equilibrio tra esigenze dell’intermediario e tutele del cliente.
L’obiettivo è mettere in luce come il diritto del sistema finanziario si configuri oggi come un “diritto della protezione”, fondato su un bilanciamento tra libertà contrattuale, innovazione e interessi collettivi. La fiducia del cliente, lungi dall’essere solo un valore etico, emerge come presupposto funzionale della stabilità e della sostenibilità del mercato, confermando l’inscindibile legame tra tutela individuale e benessere sistemico.
2. Il diritto del sistema finanziario e l’impresa finanziaria: obiettivi di tutela del cliente e integrità del mercato
A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, si è sviluppata nei tre comparti del sistema finanziario – bancario, mobiliare e assicurativo – una disciplina articolata e progressivamente più complessa, volta a regolare le relazioni contrattuali tra intermediari e clienti. Tale disciplina si è stratificata su più livelli – nazionale, unionale e internazionale – e mira non solo a garantire la protezione del cliente, ma anche a preservare l’integrità del mercato finanziario nel suo complesso[1].
L’evoluzione normativa ha definito quattro macroaree di regolazione:
informazione precontrattuale e assistenza negoziale: è stato rafforzato l’obbligo degli intermediari di fornire al cliente un’informazione chiara, completa e comprensibile sui prodotti e servizi offerti, così da consentire scelte consapevoli. Questo principio è accolto, tra gli altri, nell’art. 21 d.lgs 24-2-1998 t.u.f., per quanto concerne gli intermediari finanziari, nonché negli artt. 183-191 del Codice delle Assicurazioni Private, d.lgs. n. 209/2005, e trova eco a livello unionale nella Direttiva MiFID II[2]e nella Direttiva IDD[3].
Formalismo contrattuale: l’adozione di forme scritte obbligatorie e di contenuti minimi essenziali dei contratti, intesi come strumenti di tutela ex ante della posizione del cliente, si afferma in numerose fonti, tra cui l’art. 117 del Testo Unico Bancario[4], che prescrive la forma scritta e la consegna di copia del contratto bancario, e l’art. 23 del TUF, con riguardo agli strumenti finanziari[5].
Regole di condotta durante il rapporto: il rapporto contrattuale non è considerato cristallizzato al momento della stipula, ma soggetto a obblighi di comportamento continuo, tra cui l’obbligo di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, come previsto anche dalla Regolamentazione Consob[6]. A livello europeo, tali principi sono enunciati anche nelle Linee Guida dell’ESMA e nelle raccomandazioni dell’EIOPA per il settore assicurativo.
Scioglimento del rapporto contrattuale: sono previste regole specifiche che disciplinano il diritto di recesso delle parti, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, e le procedure di chiusura del rapporto. L’art. 126-sexies TUB e la disciplina sulla portabilità dei mutui (art. 120-quater TUB) sono esempi di normativa finalizzata a contenere i c.d. switching costs e a facilitare la mobilità della clientela.
La ratio che giustifica questo impianto normativo è duplice. Da un lato, si riconosce che il cliente finanziario si trovi generalmente in posizione di debolezza informativa e contrattuale rispetto all’intermediario, il quale dispone di maggiori capacità tecniche, informative e strutturali. Tale asimmetria è strutturale e non agevolmente colmabile, anche a causa della crescente sofisticazione dei prodotti finanziari.
La disciplina prende le mosse da un’asimmetria informativa e sostanziale: l’intermediario detiene capacità elaborative incomparabilmente superiori rispetto al cliente, che, spesso legato da costi di uscita, non può negoziare condizioni equivalenti[7].
Dall’altro lato, la disciplina mira a garantire l’integrità del mercato, promuovendo una concorrenza fondata sulla qualità e sulla correttezza delle pratiche commerciali. Ciò si traduce in un sistema di regole che, pur formalmente rivolto alla tutela del cliente, si giustifica in una prospettiva funzionale più ampia, atta a sostenere la fiducia nei mercati finanziari.
In tal senso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[8], ha sottolineato che la disciplina MIFID è funzionale alla creazione di un mercato interno dei servizi finanziari basato su elevati livelli di tutela dell’investitore. Anche in ambito OCSE e IOSCO si afferma l’esigenza di tutelare l’investitore retail come leva per la stabilità dei mercati[9].
Nel settore finanziario, il contratto non è solo lo strumento giuridico di regolazione del rapporto, ma spesso coincide con il prodotto stesso. Si pensi ai contratti di assicurazione, che costituiscono il prodotto offerto, o ai contratti di garanzia (fideiussione, pegno, ecc.) che sono elementi strutturali dell’operazione economica.
Anche nei casi in cui il contratto ha per oggetto la messa a disposizione di disponibilità finanziarie (prestiti, mutui, affidamenti), le clausole contrattuali incidono significativamente sulla convenienza economica dell’operazione per il cliente, ad esempio in relazione a:
variazioni unilaterali delle condizioni economiche ex art. 118 TUB);
modalità di calcolo del TAEG e delle commissioni[10];
disciplina del recesso anticipato e delle penali applicabili ex art. 120-quater TUB sulla portabilità.
La disciplina delle relazioni contrattuali tra intermediari e clienti ha assunto, nel corso degli ultimi trent’anni, una centralità crescente nel diritto dei mercati finanziari. L’obiettivo è duplice: assicurare la tutela del contraente debole e promuovere un mercato competitivo e trasparente. La tendenza all’armonizzazione normativa su scala unionale e internazionale conferma l’importanza di una regolazione che tenga conto non solo delle esigenze di protezione del singolo, ma anche delle dinamiche sistemiche[11].
Negli ultimi decenni, il sistema finanziario ha conosciuto una profonda trasformazione strutturale e funzionale, determinando la necessità di una revisione sistematica del quadro normativo volto alla tutela del cliente. Tale mutamento è riconducibile a quattro direttrici fondamentali: i) la costruzione di un mercato bancario europeo aperto e concorrenziale, sostenuto dalle libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare dagli articoli 49 e 56 TFUE; ii) la progressiva espansione dei mercati finanziari, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti non bancari, come le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e le Società di Gestione del Risparmio (SGR), introdotte con il d.lgs. n. 415/1996 (c.d. decreto Eurosim), poi confluito nel Testo Unico della Finanza (TUF); iii) l’emersione di nuovi strumenti e servizi finanziari – quali le polizze vita a contenuto finanziario – e l’introduzione di nuovi attori, come gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, disciplinati rispettivamente dalla direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)[12] e dalla direttiva 2009/110/CE[13]; iv) la diffusione della distribuzione multi-canale dei prodotti finanziari, fenomeno emblematico della cosiddetta bancassurance, che ha ulteriormente sfumato i confini tra comparti bancario, assicurativo e finanziario[14].
In tale contesto di profonda innovazione, l’assetto codicistico civilistico si è rivelato rapidamente inadeguato. Il codice civile, infatti, regola i contratti bancari in maniera piuttosto generica agli articoli 1834 ss. c.c. e i contratti assicurativi agli articoli 1882 ss. c.c., lasciando ampio margine all’autonomia negoziale, in assenza di un quadro organico di disciplina protettiva. La scarsa incisività delle norme generali in materia di contratti (artt. 1321 ss. c.c.), seppur integrate da previsioni specifiche sulle condizioni generali di contratto (artt. 1341-1342 c.c.), ha determinato nel tempo una rilevante asimmetria contrattuale a vantaggio degli intermediari finanziari[15].
Emblematica è la vicenda delle Norme Bancarie Uniformi (NBU), elaborate dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e diffuse a partire dagli anni Settanta come modelli contrattuali standardizzati. Tali norme, pur prive di valore vincolante formale, venivano adottate in modo pressoché uniforme dagli istituti bancari, esercitando una funzione di standardizzazione de facto dell’offerta contrattuale. L’adozione sistematica di clausole predisposte unilateralmente dagli intermediari, talvolta anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.), sollevò crescenti dubbi di compatibilità con le regole poste a tutela della concorrenza[16].
Il punto di svolta si registrò con il Provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 3 dicembre 1994, quando l’istituto – allora anche autorità garante della concorrenza nel settore bancario, secondo quanto previsto dalla l. n. 287/1990[17] – intervenne per dichiarare l’illegittimità dell’attività dell’ABI nella predisposizione di clausole contrattuali standardizzate, in quanto potenzialmente costituenti intese anticoncorrenziali vietate ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. L’intervento della Banca d’Italia sancì la necessità di limitare l’attività dell’associazione bancaria a mere raccomandazioni su profili tecnico-giuridici, escludendo qualsiasi possibilità di influenzare l’equilibrio contrattuale a danno della clientela[18].
A rafforzare tale orientamento è intervenuta, sul piano unionale, la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita in Italia con il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che ha introdotto criteri generali di trasparenza, equità e buona fede nei rapporti contrattuali. In ambito finanziario, un’ulteriore svolta è stata determinata dalla direttiva 2004/39/CE (MiFID I), poi rifusa nella direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che ha introdotto obblighi specifici in materia di informazione, adeguatezza, trasparenza e governance dei prodotti nei confronti degli investitori, con recepimento in Italia tramite modifiche al TUF (d.lgs. n. 58/1998) e al regolamento Consob n. 20307/2018.
A livello internazionale, le Guidelines on Financial Consumer Protection emanate dall’OCSE nel 2011 e aggiornate nel 2022 rappresentano un riferimento fondamentale per la definizione di principi minimi a tutela degli utenti di servizi finanziari, promuovendo trasparenza, responsabilità e inclusione.
La costruzione del moderno sistema normativo di tutela del cliente rappresenta la risposta a un’evoluzione irreversibile dei mercati finanziari e delle tecniche contrattuali, che ha imposto un progressivo superamento del paradigma dell’autonomia privata in favore di un approccio regolatorio e protettivo, improntato a garantire l’equilibrio sostanziale nei rapporti tra clienti e intermediari[19].
Il diritto del sistema finanziario – inteso come complesso di norme che disciplinano l’attività degli intermediari, l’organizzazione dei mercati e i poteri delle autorità di vigilanza – è oggi caratterizzato da un equilibrato intreccio fra regole prudenziali (stabilità dell’intermediario) e regole di condotta (protezione degli utenti). L’impresa del sistema finanziario, alla quale la disciplina si rivolge, è al centro di tale architettura: gli obblighi di governo societario, gestione dei rischi e correttezza verso la clientela sono funzionalizzati a due macro-obiettivi di policy: la tutela del cliente finanziario e l’integrità del mercato[20].
Nel contesto italiano la categoria comprende banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, istituti di pagamento e di moneta elettronica, nonché i più recenti operatori fintech. La fonte primaria è il Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998, “TUF”), che definisce l’«impresa di investimento» e statuisce gli obblighi di autorizzazione, organizzazione e condotta (artt. 18 ss.). Le banche restano invece regolate dal Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), mentre le imprese assicurative fanno capo al Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
A livello unionale, la MiFID II[21] introduce una definizione uniforme di “investment firm”, affinata da regolamenti tecnici ESMA, mentre per gli intermediari creditizi valgono il CRR II/CRD V[22] e per i prestatori di servizi di pagamento la PSD 2[23].
La protezione dell’investitore si articola su tre assi:
trasparenza informativa – obbligo di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti (art. 24 MiFID II; art. 21, co. 1-a TUF);
valutazione di adeguatezza/appropriatezza – verifica della coerenza tra bisogni del cliente e prodotto/servizio offerto (artt. 25 ss. MiFID II);
gestione dei conflitti di interesse – politiche e presidi organizzativi volti a prevenire nocumento ai clienti[24].
Una novità sostanziale è il paradigma di product governance: l’intermediario deve progettare il prodotto individuando il “target market” ex ante e monitorandolo lungo l’intero ciclo di vita, come specificato nelle Linee guida ESMA del 2023[25]. Sul piano dottrinale, Petrosino ha sottolineato che tale logica segna il passaggio “dal principio di caveat emptor al principio di cura del prodotto”[26].
L’integrità, intesa come efficienza informativa, assenza di manipolazioni e fiducia degli investitori, è salvaguardata principalmente dal Market Abuse Regulation[27] e dalla Direttiva MAD II[28], che tipizzano insider trading, manipulation e predispongono un apparato sanzionatorio armonizzato. La Consob, in sinergia con ESMA, esercita poteri investigativi e interdittivi.
L’impresa finanziaria deve adottare assetti di governo societario coerenti con il rischio di condotta: board responsabilizzato, funzioni di compliance e internal audit indipendenti, politiche di remunerazione che non incentivano di comportamenti opportunistici[29].
Su scala internazionale, i Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea definiscono gli standard minimi per supervisione e risk management, integrando la prospettiva di stabilità con quella di fair treatment of customers[30]. In materia di crisis management, i Key Attributes of Effective Resolution Regimes del Financial Stability Board impongono che la risoluzione salvaguardi funzioni critiche e minimizzi gli oneri per il contribuente, tutelando al contempo depositanti e investitori al dettaglio.
La governance multilivello combina:
fonti internazionali[31];
right of initiative della Commissione UE[32];
implementazione nazionale (TUF, TUB, Regolamenti Consob/Banca d’Italia).
La soft-law[33] costituisce strumento flessibile di adattamento tecnologico, come prova la recente ESMA work-programme 2024 sui rischi ESG e sull’uso dell’AI nella distribuzione dei prodotti.
L’avvento delle piattaforme di trading algoritmico, dei crypto-asset e dell’intelligenza artificiale impone una rilettura dei concetti tradizionali di abuso di mercato e fairness nelle relazioni contrattuali. La proposta di regolamento MiCA e il DORA estendono l’apparato di tutela del cliente alle cripto-attività e ai rischi ICT. Sul versante ESG, la Corporate Sustainability Reporting Directive[34] amplia gli obblighi informativi a tutela degli investitori attenti alla sostenibilità.
La disciplina delle imprese del sistema finanziario evidenzia la tensione fra libertà d’iniziativa economica e preminenza degli interessi diffusi – la fiducia del pubblico nel mercato e la protezione dell’investitore retail. Gli snodi analizzati mostrano che:
tutela del cliente e integrità del mercato non sono obiettivi separati ma complementari: dove la fiducia dei clienti diminuisce, liquidità e formazione dei prezzi ne risentono, minacciando la stabilità complessiva;
la product governance rappresenta una nuova frontiera di accountability, spostando il baricentro della vigilanza ex post sull’illecito verso un controllo ex ante sull’ideazione del prodotto;
il rafforzamento della cooperazione internazionale (IOSCO, FSB, Comitato di Basilea) è essenziale per evitare arbitraggi regolamentari in un contesto di elevata mobilità dei capitali e di innovazione tecnologica.
In prospettiva, l’evoluzione verso un ecosistema digitale e sostenibile richiederà ulteriori affinamenti normativi e una crescente interazione fra regolatori, intermediari e accademia per mantenere quell’equilibrio delicato fra innovazione, concorrenza e protezione degli interessi collettivi.
3. La disciplina della trasparenza bancaria
La disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è contenuta nel Titolo VI del Testo Unico Bancario[35], il quale rappresenta il quadro normativo di riferimento per i rapporti tra intermediari finanziari e clientela, con una forte ispirazione protettiva nei confronti di quest’ultima.
Il Capo I stabilisce una serie di regole generali applicabili a tutti i contratti bancari, salve le deroghe o specificazioni previste dai successivi capi relativi a settori regolamentati da normative europee settoriali[36]. Le disposizioni attengono a:
pubblicità e informazione precontrattuale;
forma e contenuto dei contratti;
variazioni unilaterali delle condizioni;
recesso e scioglimento del contratto.
A livello di normativa secondaria, la materia è ulteriormente disciplinata dalle Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza[37], adottate ai sensi delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio[38] ex art. 116 TUB.
Le discipline settoriali di derivazione europea incidono in particolare su due ambiti:
credito immobiliare ai consumatori regolato dagli artt. 120-quinquies ss. TUB, il credito immobiliare comprende i contratti:
garantiti da ipoteca su immobili residenziali, o
finalizzati all’acquisto o alla conservazione di proprietà su immobili o terreni.
L’obiettivo è quello di tutelare l’utente in un’operazione che coinvolge una parte rilevante del suo patrimonio e tocca interessi primari (es. l’abitazione principale), potenzialmente esponendolo a gravi rischi economici e personali[39].
2. Credito al consumo, normato dagli artt. 121-126 TUB, interessa le operazioni di finanziamento di importo fino a 75.000 euro, ad eccezione di alcune tipologie escluse (es. credito gratuito di durata ≤ 3 mesi; credito ipotecario > 5 anni).
In questo ambito il legislatore riconosce la debolezza strutturale del consumatore, specie in situazioni di:
frequente ricorso al credito,
cessione del quinto dello stipendio o pensione,
pericolo di sovraindebitamento[40].
La normativa sui servizi di pagamento mira a garantire efficienza, sicurezza e trasparenza nei sistemi di pagamento elettronico[41].
Sono esclusi da tale disciplina strumenti come assegni e cambiali[42].
Particolare attenzione è dedicata ai conti di pagamento[43] intestati ai consumatori, con misure specifiche per:
comparabilità delle offerte[44];
portabilità del conto[45];
conto base: conto a basso costo con servizi minimi garantiti[46], anche gratuito per categorie svantaggiate[47].
La giurisprudenza ha chiarito che l’inadempimento degli obblighi informativi e di trasparenza comporta nullità o inefficacia delle clausole contrattuali, nonché risarcimento del danno per il cliente[48].
La disciplina della trasparenza bancaria nel TUB, integrata dalla normativa secondaria e dai recepimenti delle direttive europee, rappresenta una componente essenziale del diritto bancario moderno, finalizzata alla tutela dell’utente debole, alla correttezza delle relazioni contrattuali e al rafforzamento dell’efficienza e della concorrenza nei mercati finanziari.
In tale contesto, la normativa si evolve dinamicamente, anche alla luce dell’interazione con l’evoluzione tecnologica (fintech, digital banking), imponendo un costante aggiornamento degli strumenti di tutela, in particolare per i servizi più diffusi e ad alto impatto sociale.
La disciplina del Capo I[49] opera come regola-ombrello per tutte le operazioni bancarie, finanziarie e – via BancoPosta – postali poste in essere sul territorio della Repubblica da banche e intermediari ex art. 106 TUB, indipendentemente dallo status della controparte[50]. L’unicità del regime soggettivo distingue radicalmente Capo I dalle regolazioni speciali dei Capi I-bis (credito immobiliare ai consumatori), II (credito al consumo) e II-ter (servizi di pagamento), dove il legislatore ha prescelto un paradigma consumer-oriented (con apertura alle microimprese solo per i pagamenti).
Nella disciplina generale il “cliente bancario” coincide con qualunque soggetto diverso da un intermediario vigilato; sono quindi inclusi professionisti e imprese, ma esclusi banche, SIM, assicurazioni, etc.[51]. Per le discipline settoriali, invece, la categoria rilevante è il “consumatore” – persona fisica estranea a scopi imprenditoriali (artt. 120-quinquies, 121 TUB) – cui si affianca la “micro-impresa” (meno di 10 addetti e fatturato/bilancio ≤ € 2 mln) ai fini dei servizi di pagamento (art. 126-bis, co. 3).
Sul piano formale, il Capo I è residuale: non si applica ipso iure alle operazioni regolate dai successivi Capi. Tuttavia:
(a) molte norme settoriali rinviano espressamente al Capo I (es. forma del contratto ex art. 117 TUB);
(b) il principio di circolarità consente l’uso dell’analogia in bonam partem – es. l’art. 117-bis (remunerazione di affidamenti/sconfinamenti) può estendersi ai crediti al consumo collegati a conti di pagamento[52];
(c) al contrario, istituti nati come settoriali[53] tendono oggi a fungere da standard anche oltre il dominio consumeristico[54].
La giurisprudenza affianca questo dialogo normativo. Le Sezioni Unite Cass. 26242/2014 qualificano la violazione delle regole di trasparenza come “nullità di protezione” rilevabile d’ufficio[55]; la Cass. 12964/2021 estende il rilievo officioso al grado d’appello, mentre Cass. 2338/2024 precisa che la nullità opera solo “a vantaggio del cliente”[56]. Sul versante unionale, CJUE Aziz (C-415/11), Gutiérrez Naranjo (C-154/15) e Lexitor (C-383/18) impongono che l’inadempimento informativo comporti espunzione/inefficacia della clausola e rimedi restitutori integrali, rafforzando l’idea che il Capo I fornisca la matrice di tutela cui gli altri Capi attingono[57].
Quanto alle sanzioni e ai controlli, il Capo III[58] ha portata assolutamente generale: la Banca d’Italia dispone di poteri ispettivi e sanzionatori verso ogni intermediario che violi obblighi informativi o di forma, mentre l’ABF[59] e l’OAM[60] fungono da enforcement pararegulatorio. La comminatoria amministrativa si somma agli effetti civilistici di nullità/risarcimento sanciti dalla giurisprudenza richiamata.
Il Capo I, pur qualificandosi formalmente come disciplina “residuale”, costituisce il nocciolo duro della tutela informativa nel diritto bancario italiano, funge da cassetta degli attrezzi per le discipline settoriali e, tramite la giurisprudenza unionale e nazionale, alimenta un circuito virtuoso di standardizzazione a favore di clienti e consumatori.
4. Trasparenza e sintesi del costo nei contratti bancari
Il TUB[61] prevede una disciplina dettagliata in tema di trasparenza nelle fasi precontrattuale e pre-negoziale[62]. In particolare, l’informazione pubblica concernente i tassi, prezzi e condizioni, resa disponibile nei fogli informativi, è prevista dall’art. 116 TUB, supportata dal CICR sulla base di proposte Banca d’Italia–Consob[63].
I fogli informativi devono essere esposti presso gli sportelli e pubblicati online. Oltre ai tassi, includono dati anagrafici dell’intermediario, caratteristiche dell’operazione e clausole principali (es. recesso, ius variandi).
Viene imposta indicazione dei tassi massimi o minimi praticabili, ma talvolta questi non riflettono condizioni effettivamente offerte ai clienti[64]. L’art. 117 comma 5 TUB vieta di applicare condizioni peggiori di quelle pubblicizzate.
L’art. 117 TUB disciplina[65]:
forma scritta obbligatoria, pena nullità;
contenuto minimo obbligatorio: tassi, prezzi, condizioni, oneri in mora;
nullità delle clausole di rinvio agli usi o peggiorative rispetto alla pubblicità;
tasso sostitutivo (comma 7): in caso di nullità, si applicano tassi legali o dei BOT;
modifiche unilaterali (ius variandi): ammesse solo per giustificato motivo, con clausola specificatamente approvata, preavviso minimo 2 mesi, e comunicazione evidenziata.
La trasparenza serve alla conoscibilità effettiva, non solo formale[66]. Illeciti si traducono in nullità delle clausole, non del contratto, con conseguenti limiti al tasso sostitutivo e tutela risarcitoria.
Le regole generali si estendono anche a credito al consumo e servizi di pagamento mediante richiamo normativo.
Conti di pagamento – art. 126‑terdecies TUB introdotto con recepimento della direttiva PAD[67], impone agli intermediari:
partecipazione obbligatoria ad almeno un sito comparatore indipendente;
standardizzazione europea delle informazioni, posta a confronto;
attuazione tramite DM MEF 22 dicembre 2020 (GU 18 marzo 2021)[68].
La trasparenza appare formale quando i tassi pubblicizzati sono massimali/minimali, ma non rispecchiano le condizioni reali.
La dottrina evidenzia che l’informazione eccessiva può ridurre comprensione effettiva. L’orientamento comunitario spinge verso misure integrative che favoriscano comparabilità e informazione consapevole[69]. Le disposizioni del TUB, integrate da normative settoriali e interventi della vigilanza, disegnano un sistema in cui la trasparenza diventa strumento centrale di tutela del consumatore, corretta concorrenza e buona governance bancaria. Resta aperto il tema della qualità informativa e del suo impatto reale, che reclama strumenti dinamici e un approccio incentrato sull’utente (behavioural law & economics).
La fase pre-negoziale, che precede la conclusione del contratto bancario o finanziario, si configura come momento cruciale nell’ambito delle relazioni tra intermediari e clientela, in particolare per la tutela dell’affidamento del consumatore e per la trasparenza del mercato. In questa fase, il legislatore e le autorità di vigilanza hanno predisposto una serie di obblighi informativi, graduati in funzione della tipologia di contratto e della parte debole del rapporto[70].
Le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, emanate ai sensi dell’art. 116 TUB, sanciscono il diritto del cliente di ottenere gratuitamente, su richiesta, una bozza del contratto ovvero il documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto negoziale. In assenza di una richiesta esplicita, non sussiste un obbligo generalizzato di consegna preventiva della documentazione contrattuale[71].
Nel settore del credito ai consumatori, l’art. 124 TUB e le relative disposizioni attuative[72] prevedono regole più incisive. L’intermediario è tenuto a fornire senza richiesta del consumatore e in tempo utile prima della conclusione del contratto un documento informativo standard europeo[73] contenente il TAEG e tutte le condizioni economiche e contrattuali. Inoltre, deve assistere il consumatore con chiarimenti adeguati affinché possa valutare l’idoneità del contratto rispetto alle proprie esigenze finanziarie[74], in linea con il principio del merito creditizio. Il cliente può esercitare il diritto di recesso penitenziale entro 14 giorni, senza penalità, salvo il pagamento degli interessi maturati[75].
In materia di credito immobiliare ai consumatori, la disciplina è ulteriormente rafforzata dal Capo I-bis del Titolo VI TUB, in recepimento della Direttiva 2014/17/UE[76]. In particolare:
L’art. 120-novies TUB impone la consegna preventiva del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) solo dopo la valutazione del merito creditizio.
Il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, durante il quale l’offerta è vincolante per il finanziatore.
La bozza contrattuale deve essere sempre fornita, anche in assenza di richiesta.
In caso di valutazione errata del merito creditizio, il finanziatore non può modificare in peius le condizioni contrattuali né risolvere anticipatamente il contratto[77].
Tali disposizioni sono coerenti con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE, che ha ribadito l’importanza della chiarezza, comprensibilità e tempestività delle informazioni precontrattuali[78].
Anche per i conti di pagamento, la disciplina armonizzata dalla Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive)[79], recepita in Italia con il d.lgs. 37/2017, prevede la consegna preventiva del Documento informativo sulle spese[80], basato su uno schema europeo uniforme che riporta tutti i costi associati al conto e ai principali servizi. L’elenco dei servizi rappresentativi è stabilito dalla Banca d’Italia, e il documento deve essere disponibile prima della conclusione del contratto.
La fase pre-negoziale, in quanto momento fondativo del consenso consapevole, è oggetto di un complesso regime regolamentare che impone agli intermediari obblighi crescenti di trasparenza e consulenza, proporzionati alla vulnerabilità del cliente e alla complessità del prodotto finanziario. Si osserva una crescente tendenza normativa – anche a livello unionale – ad attribuire valore sostanziale alla trasparenza informativa, non solo come forma, ma come contenuto protettivo della libertà contrattuale.
La crescente complessità dei contratti bancari, spesso articolati in una molteplicità di condizioni economiche (tassi d’interesse, spese, commissioni, imposte), ha reso necessario lo sviluppo di indicatori sintetici di costo volti a semplificare la comprensione del costo complessivo dell’operazione finanziaria da parte della clientela, in particolare dei consumatori. L’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale ed euro-unitario è quello di garantire una trasparenza effettiva, non meramente formale, nell’ambito delle relazioni contrattuali tra intermediari e clientela retail[81].
Nel settore dei conti di pagamento, il principale indicatore è rappresentato dall’ICC (Indicatore dei Costi Complessivi), il quale è disciplinato dagli artt. 123 e 126-undecies TUB e dalle relative Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive). L’ICC è contenuto nel Documento informativo sulle spese (Fee Information Document), ed è espresso in valori assoluti. Esso si basa su simulazioni standardizzate di utilizzo del conto, individuate a livello europeo e riportate nell’allegato tecnico alla normativa di secondo livello.
L’indicatore ha natura orientativa, essendo calcolato sulla base di profili-tipo e non sull’effettiva operatività del cliente. Deve essere riportato sia nella fase precontrattuale che nei riepiloghi periodici dei costi sostenuti, al fine di consentire al consumatore una valutazione ex ante ed ex post dell’onerosità del rapporto[82].
Più strutturato e incisivo è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), obbligatorio per ogni finanziamento destinato ai consumatori (mutui, aperture di credito, prestiti personali, ecc.). Il TAEG è un indicatore percentuale annuo che include il costo totale del credito, comprendente interessi, commissioni, imposte e ogni altra spesa accessoria a carico del cliente, con l’unica eccezione delle spese notarili, non computabili ex lege[83].
Nel caso di aperture di credito, il TAEG si calcola ipotizzando l’utilizzo integrale del fido per tutta la durata del contratto, come specificato nell’allegato 5B delle Disposizioni di trasparenza[84].
L’indicatore assolve a una duplice funzione:
comparativa, in quanto consente al cliente di confrontare agevolmente diverse offerte presenti sul mercato;
informativa, in quanto segnala il reale impegno finanziario derivante dalla sottoscrizione del contratto.
Il TAEG deve essere riportato:
nei fogli informativi (offerta generale),
nel documento di sintesi precontrattuale,
e, nei casi di credito al consumo, anche all’interno del contratto stesso[85].
È essenziale distinguere tra:
gli indicatori contenuti nella documentazione pubblicitaria e nei fogli informativi, che riflettono l’offerta standardizzata dell’intermediario,
e quelli inseriti nella documentazione precontrattuale e contrattuale, che rappresentano le condizioni effettive applicabili al singolo cliente.
Tale distinzione garantisce il corretto bilanciamento tra standardizzazione e personalizzazione del rapporto contrattuale, favorendo una trasparenza calibrata sulla concreta operazione[86].
In sede unionale, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che la comunicazione del TAEG deve avvenire in modo chiaro e tempestivo per consentire un reale confronto tra offerte[87]. L’adozione di indicatori sintetici di costo, quali l’ICC e il TAEG, rappresenta uno degli strumenti principali con cui il diritto bancario contemporaneo cerca di tradurre il principio di trasparenza in una tutela sostanziale del cliente. La standardizzazione informativa, se correttamente implementata, non solo facilita il confronto tra prodotti bancari, ma consente anche una più consapevole assunzione del rischio contrattuale da parte del contraente debole.
5. La forma scritta nei contratti bancari tra neo-formalismo e tutela del cliente
L’art. 117, co. 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) impone, a pena di nullità, che tutti i contratti bancari siano stipulati per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente. La prescrizione è ribadita, con identica sanzione, dai rinvii contenuti nei Capi dedicati al credito ai consumatori[88] e ai servizi di pagamento[89]. La nullità è “di protezione”: può essere fatta valere solo dal cliente[90] e il giudice può rilevarla ex officio in suo favore[91].
La dottrina riconduce il formalismo dell’art. 117 TUB a un neo-formalismo funzionale destinato a: i) garantire trasparenza e completezza informativa; ii) riequilibrare la posizione contrattuale del cliente retail; iii) consentire un controllo esterno sulla validità delle clausole[92]. La Cassazione a Sezioni Unite qualifica perciò la nullità come strumento di ordine pubblico di protezione[93].
La regola scritta copre l’intera contrattualistica bancaria con la clientela “al dettaglio”[94].
Per i contratti “mono-firma”[95] la Cassazione, uniformandosi a SS.UU. 898 e 1653/2018[96], ritiene sufficiente la consegna al cliente dell’esemplare, con sottoscrizione di quietanza distinta[97].
L’art. 117, co. 2 TUB consente deroghe “per motivate ragioni tecniche” demandate a delibera CICR. La delibera 4 marzo 2003 individua due sole fattispecie:
a) operazioni esecutive di un contratto già redatto per iscritto (es. ordini su c/c), con condizione di contratto quadro regolarmente formato e per la tracciabilità dell’operazione l’evidenza nei sistemi contabili;
b) operazioni e servizi occasionali ≤ € 5 000 (es. cambio valuta), con condizione di occasionalità e limite di importo e per la tracciabilità dell’operazione il rilascio della ricevuta al cliente con registrazione interna.
La deroga si integra con le Disposizioni di trasparenza[98] che precisano forme equivalenti di documento elettronico ai sensi del CAD.
Il credito ai consumatori ex art. 10 Dir. 2008/48/CE[99] impone un supporto durevole per il contratto e l’obbligo di fornirne copia al consumatore, recepito in Italia dall’art. 125-bis TUB.
I servizi di pagamento ex artt. 51-56 Dir. (UE) 2015/2366[100] disciplinano la forma del consenso e la messa a disposizione delle condizioni contrattuali su supporto durevole. La Corte di giustizia, nel caso ING-DiBa[101], ha collegato la nozione di “conto di pagamento” all’idoneità a eseguire operazioni verso terzi, valorizzando la trasparenza contrattuale.
La nullità relativa può essere fatta valere solo dal cliente[102] mentre il rilievo d’ufficio è ammesso quando non contrasti con l’interesse del cliente[103].
Per gli effetti restitutori in assenza di contratto valido non sono dovute spese, interessi e commissioni.
La pandemia ha accelerato forme “semplificate” di conclusione a distanza[104] e la dottrina rileva il passaggio da formalismo strutturale a formalismo funzionale[105]. La sfida futura sarà bilanciare innovazione tecnologica (e-sign, biometria, DLT) e garanzie di certezza e trasparenza incarnate dalla forma scritta.
Già la Cass. civ. n. 4564 del 2012 riteneva valido il contratto firmato solo dal cliente, a condizione che fosse indicato che al cliente era stato consegnato un esemplare o che la banca avesse prodotto in giudizio la copia, e che il contratto fosse stato in esecuzione per anni[106].
Tra il 2016 e il 2017, la Corte di Cassazione[107] ha dichiarato l’invalidità del contratto mono-firma: le diciture nel documento non bastano, il comportamento esecutivo non convalida, e la mera produzione in giudizio con effetto ex nunc non retroagisce.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel settore degli investimenti[108], la forma scritta è rispettata se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e firmato da quest’ultimo, anche se privo della firma della banca, il cui consenso è desumibile da comportamenti concludenti[109].
Hanno esteso tale principio anche ai contratti bancari soggetti all’art. 117 TUB, poiché la ratio è la stessa: proteggere il cliente informandolo[110].
L’art. 23, co. 3 TUF e l’art. 117, co. 3 TUB prevedono la forma scritta e la consegna al cliente, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente[111].
La forma ha una funzione informativa e protettiva, tipica dei contratti “asimmetrici”: serve a garantire la consapevolezza del cliente debole[112].
Con l’ordinanza Cass. 21 giugno 2018, n. 16406, la Corte ha applicato all’art. 117 TUB lo stesso orientamento, affermando che, se sussiste: (a) sottoscrizione del cliente, (b) redazione da parte della banca, (c) consegna al cliente e (d) esecuzione del contratto, allora viene soddisfatta la forma scritta, anche se manca la firma dell’intermediario[113].
Per la validità, quindi, è essenziale provare la consegna effettiva di un esemplare al cliente, con prova documentale[114]. Se il cliente non firma, il contratto è nullo ad substantiam (nullità sanabile solo se ci fosse firma di entrambe le parti).
Se firma solo il cliente, ma manca consegna o esecuzione, la nullità regge.
Se firma il cliente, riceve l’esemplare, e la banca esegue il contratto, il contratto è valido; eventuali controversie verteranno sulla prova della consegna o sull’esecuzione concreta .
La tesi secondo cui il contratto firmato solo dal cliente è valido, poiché la forma svolge una funzione meramente informativa e non è una forma ad substantiam classica, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità più recente, purché:
il contratto sia predisposto dalla banca;
il cliente lo sottoscriva;
la banca consegni un esemplare al cliente;
Il contratto venga effettivamente eseguito.
Se anche uno solo di questi elementi viene meno, la forma scritta non è soddisfatta e la nullità può essere rilevata dal cliente[115].
6. Il contenimento dei costi nei rapporti bancari: anatocismo, usura, remunerazione degli affidamenti e disciplina delle spese
La disciplina dei costi bancari si inserisce in un più ampio disegno di tutela del cliente e di riequilibrio del contenuto economico dei contratti bancari, attuato sia tramite previsioni legislative generali[116] sia mediante interventi specifici, tra cui spiccano la disciplina antiusura[117] e quella sull’anatocismo[118]. Tali norme mirano ad impedire che l’intermediario trasli costi occulti sul cliente o agisca in posizione di forza sfruttando la debolezza contrattuale dell’utente.
L’art. 644, co. 4 c.p. punisce penalmente l’applicazione di tassi usurari, mentre l’art. 1815, co. 2 c.c. prevede la nullità parziale delle clausole usurarie e l’esonero dal pagamento degli interessi. Il tasso soglia è determinato sulla base del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) ai sensi dell’art. 2, co. 1, l. n. 108/1996. La giurisprudenza ha chiarito che la nullità colpisce le pattuizioni superanti la soglia al momento della stipula e non in caso di usura sopravvenuta. Le Sezioni Unite, occupandosi di un finanziamento a rimborso rateale, hanno stabilito che la verifica dell’usura va limitata strettamente al momento pattizio, non configurandosi mai la c.d. “usura sopravvenuta” in corso di rapporto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d’usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”[119].
Il TEGM è aumentato di un quarto più quattro punti percentuali, entro un limite massimo di otto punti[120].
Sussistono divergenze sull’inclusione dei tassi moratori nel calcolo dell’usura: secondo l’orientamento prevalente, essi vanno confrontati con la soglia rilevante per la stessa categoria di credito. L’assenza di rilevazioni specifiche del TEGM sui tassi di mora ha reso il tema controverso. La giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 1224 c.c. e la nullità della clausola solo in caso di superamento effettivo della soglia[121].
L’art. 120 TUB, sulla capitalizzazione degli interessi, anatocismo e disciplina, modificato nel 2013[122] e integrato dalla delibera CICR del 2016 (d.l. n. 18/2016), vieta la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, salvo espressa autorizzazione del cliente. La capitalizzazione è legittima solo se simmetrica e pattuita per iscritto per interessi attivi e passivi, con pari periodicità. In assenza di autorizzazione, gli interessi passivi non possono essere addebitati ma richiesti separatamente.
L’art. 117-bis TUB consente l’applicazione di una commissione di affidamento (massimo 0,5% trimestrale) a titolo onnicomprensivo. La commissione remunera la mera messa a disposizione delle somme, a prescindere dall’effettivo utilizzo. In caso di sconfinamenti, la banca può applicare solo commissioni di istruttoria veloce (ad es. 50 euro), giustificate da costi specifici documentabili.
Per la disciplina delle spese su comunicazioni e trasparenza, ai sensi dell’art. 127-bis TUB, le comunicazioni obbligatorie sono gratuite se fornite in formato elettronico; per comunicazioni cartacee o richieste del cliente, possono essere addebitate spese purché proporzionate ai costi sostenuti. Tale disposizione mira a garantire la trasparenza e a evitare l’imposizione di costi occulti.
L’insieme delle norme esaminate è volto a riequilibrare i rapporti contrattuali tra banche e clienti, garantendo la trasparenza delle condizioni economiche e prevenendo fenomeni di abuso, usura o anatocismo. La corretta applicazione delle disposizioni analizzate, unite a un’adeguata vigilanza da parte delle autorità di controllo, costituisce un presidio essenziale a tutela del risparmio e della fiducia nel sistema bancario.
7. Lo ius variandi nei rapporti bancari: disciplina normativa, limiti applicativi e tutela del cliente
Il rapporto bancario è caratterizzato da numerose disposizioni che regolamentano la sua esecuzione e modifica nel corso del tempo. Centrale tra queste è l’art. 118 del TUB, richiamato anche dagli artt. 120-noviesdecies e 125-bis, co. 2, che disciplina il c.d. ius variandi. Tale facoltà consente alla banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, purché prevista da una specifica clausola contrattuale approvata espressamente dal cliente[123]. Tale diritto potestativo risponde alla necessità di adattare il rapporto creditizio ai mutamenti oggettivi e soggettivi intervenuti nel tempo, quali variazioni nei tassi di mercato o nella situazione economica del cliente[124].
L’esercizio del potere di modifica richiede il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali: la banca deve comunicare in forma scritta al cliente, con almeno due mesi di anticipo, la proposta di modifica, indicando chiaramente il giustificato motivo della stessa, come ad esempio variazioni specifiche di indici come l’Euribor o modifiche normative. Il cliente, entro tale periodo, può recedere senza penalità mantenendo le precedenti condizioni fino alla liquidazione del rapporto ex art. 118, co. 3 TUB[125].
L’applicazione illegittima o abusiva dello ius variandi rende inefficace la modifica sfavorevole al cliente, che potrà chiedere la restituzione degli importi illegittimamente addebitati. Nei contratti a tempo determinato, quali mutui, lo ius variandi può riguardare esclusivamente condizioni diverse dai tassi di interesse, salvo che il cliente non sia consumatore né microimpresa, e a condizione che le circostanze siano previamente indicate nel contratto[126].
La disciplina varia leggermente per i servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 126-sexies TUB, dove il cliente può non solo recedere ma anche rifiutare espressamente la modifica. Per i consumatori resta obbligatoria la giustificazione della modifica contrattuale ex art. 126-sexies, co. 4-bis TUB.
Il d.lgs. 11/2010 introduce specifiche tutele in materia di operazioni di pagamento fraudolente, imponendo agli intermediari finanziari di adottare misure di sicurezza rigorose[127]. L’adozione di sistemi di autenticazione forte (Strong Authentication) è divenuta obbligatoria per le operazioni online. Il cliente deve comunicare tempestivamente l’uso fraudolento per ottenere il rimborso, salvo dolo o colpa grave nella custodia delle credenziali[128].
Altrettanto rilevante è la regolamentazione della decorrenza della valuta e disponibilità delle somme, stabilita dagli artt. 22-23 d.lgs. 11/2010 e dall’art. 120 TUB per gli assegni. Le disposizioni mirano a sincronizzare l’accredito degli interessi con l’effettiva disponibilità delle somme, limitando le pratiche dilatorie bancarie precedentemente diffuse[129].
In tema di comunicazioni periodiche, l’art. 119 TUB impone alla banca l’obbligo di inviare un documento chiaro e dettagliato sull’andamento del rapporto, noto come estratto conto, con periodicità annuale, trimestrale o mensile. In mancanza di contestazioni entro sessanta giorni, le operazioni si intendono approvate. Inoltre, il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione entro novanta giorni dalla richiesta[130].
Per i servizi di pagamento, si aggiunge l’obbligo di rilasciare ricevute individuali e un dettagliato rendiconto mensile ex art. 126-quater TUB. Infine, nel credito al consumo è previsto l’obbligo di avvisare il cliente di eventuali sconfinamenti ex art. 125-octies TUB.
La normativa bancaria europea, in particolare la Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), recepita dal d.lgs. 218/2017, rafforza ulteriormente tali garanzie, enfatizzando la sicurezza e la trasparenza nelle operazioni di pagamento transfrontaliere[131].
[1] F. Capriglione, Diritto dell’economia tra passato e futuro, Utet, 2025, 15 ss..
[2] Direttiva 2014/65/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
[3] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa.
[4] D.lgs. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
[5] F. Capriglione, Diritto dell’economia tra passato e futuro, Utet, 2025, 73.
[6] v. Regolamento Intermediari, n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari.
[7] V. Troiano, & R. Motroni, La MiFID II, Cedam, 2016, 59.
[8] v. causa C-604/11, Genil 48 SL e Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL contro Bankinter SA, 2013.
[9] G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection, 2011.
[10] Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
[11] F. Capriglione, Diritto dell’economia tra passato e futuro, Utet, 2025, 118.
[12] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
[13] Direttiva 2009/110/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
[14] F. Capriglione, Manuale di diritto bancario e finanziario, Cedam, 2024, 22-67.
[15] M. De Poli, Asimmetrie informative e contratti bancari: l’esperienza italiana, in Revista de la Facultad de Derecho de México, 2019, 809-843.
[16] M. Grillo M., & M. Polo, La standardizzazione dei contratti bancari con particolare riferimento alle Norme Bancarie Uniformi, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 49, 1999, 31-46.
[17] Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
[18] N. Salanitro, Disciplina antitrust e contratti bancari – in Nota a Banca d’Italia, Provv. 3 dicembre 1994, n. 12, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1995, II, 393 ss..
[19] A. Sciarrone Alibrandi, Dalla tutela informativa alla product governance: nuove strategie regolatorie del rapporto tra clientela e intermediari finanziari, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 2016, 1 ss..
[20] V. Mungari, Il danno all’integrità del mercato, in Studi sul diritto delle imprese, Aracne, 2024, 18 ss..
[21] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
[22] CRR II e CRD V: in GU UE le nuove regole sui requisiti di capitale, in Diritto bancario, 2019.
[23] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
[24] Consob, Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, artt. 40-45.
[25] ESMA, Final Report on MiFID II Guidelines on Product Governance, 2023.
[26] F. Petrosino, Product governance e rimedi nel diritto dei mercati finanziari, Tesi PhD, Univ. di Trento, 2021, 57 ss..
[27] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato).
[28] Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato).
[29] Consob, Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, artt. 9-10.
[30] Basel Committee, Core Principles for Effective Banking Supervision, 2024, 16-18.
[31] IOSCO Objectives & Principles, Objectives and Principles of Securities Regulation, 2017; Basel Standards.
[32] Consiglio dell’Unione europea, Il pacchetto sulla finanza digitale: il Consiglio raggiunge un accordo su MiCA e DORA, 2021.
[33] Q&A ESMA, guidelines, opinioni delle European Supervisory Authorities.
[34] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
[35] TUB, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
[36] Art. 115 TUB.
[37] Disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 11 febbraio 2025.
[38] CICR, Deliberazione 4 marzo 2003 – disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
[39] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 – recepisce la Direttiva 2014/17/UE e inserisce il Titolo VI-bis (artt. 120-quinquies ss.) nel TUB; Cass. SS.UU., 5 marzo 2025, n. 5841 – qualifica e limiti del “mutuo solutorio” garantito da ipoteca – raccordo con disciplina anti-usura.
[40] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori (Consumer Credit Directive – CCD1); Artt. 121-126 TUB – disciplina di dettaglio del credito al consumo (ambito, trasparenza, recesso, estinzione anticipata).
[41] Capo II-bis, TUB; Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
[42] Art. 114-terdecies TUB.
[43] Capo II-ter, TUB.
[44] Anche tramite portali pubblici.
[45] Entro 12 giorni lavorativi, art. 126-sexiesdecies TUB.
[46] D.M. MEF 3 maggio 2018, n. 70.
[47] Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive) – del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; Regolamento Delegato (UE) 2018/32 della Commissione del 28 settembre 2017 che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento.
[48] Trib. S. Maria C. Vetere, 30 settembre 2024, 3536 – dichiara nullità delle clausole sui costi, ordina restituzione di € 68.908,51 e condanna la Banca al risarcimento per violazione degli obblighi informativi.
[49] Artt. 115-120-quater TUB.
[50] A. Tucci, La trasparenza come clausola conformativa e i rimedi, in Riv. dir. banc., 2024, 511 ss..
[51] M. De Poli, La contrattazione bancaria: tra tutela della liquidità ed obblighi di trasparenza, Cedam, 2012, 76 ss..
[52] AA.VV., & E. Capobianco, Profili generali della contrattazione bancaria, in Contratti bancari, Wolters Kluwer, 2021, 5 ss..
[53] Verifica del merito creditizio ex art. 120-undecies; credito collegato ex art. 121.
[54] F. Forcellini, Il nuovo contratto di credito ai consumatori: profili rimediali, in Riv. Dir. Econ., 2011, 109 ss..
[55] Cass., SS.UU., 12-XII-2014, n. 26242 – nullità di protezione.
[56] Cass., III, 13-V-2021, n. 12964 – trasparenza art. 117 TUB; Cass., I, 24-I-2024, n. 2338 – forma e nullità relativizzata.
[57] CJUE, 14-III-2013, C-415/11, Aziz; CJUE, 21-XII-2016, C-154/15, Gutiérrez Naranjo; CJUE, 11-IX-2019, C-383/18, Lexitor.
[58] Artt. 127-128-ter TUB.
[59] Arbitro Bancario Finanziario.
[60] Organismo Agenti e Mediatori.
[61] D.Lgs. 385/1993.
[62] Capo I, Titolo VI.
[63] G. De Nova, La semplificazione della normativa di trasparenza bancaria, in Diritto Bancario, 2019, 409 ss..
[64] G. Piagnerelli, Il Testo unico bancario non è retroattivo sugli interessi ultralegali praticati prima dell’entrata in vigore, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 2022.
[65] Art. 117 TUB, forma, contenuto, nullità, tasso sostitutivo.
[66]A. Tucci, La trasparenza come clausola conformativa e i rimedi, in Diritto bancario, 2024, 515 ss..
[67] Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) – Trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento.
[68] DM MEF 22/12/2020 e G.U. 18/3/2021, attuazione art. 126‑terdecies.
[69]A. Barenghi, Appunti sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo, in Questione giustizia, 2017.
[70]A. Mirone, Diritto commerciale IV – Diritto del sistema finanziario. Le regole dell’attività: la tutela del cliente, Torino, 2024, 223.
[71] Disp. trasp., sez. II, 6-7.
[72] Disp. trasp., sez. VII.
[73] SECCI – Standard European Consumer Credit Information, in https://www.24oreprestiti.ilsole24ore.com/guide-prestiti/glossario-prestiti/secci-(standard-european-consumer-credit-information) asp.
[74] Art. 124, comma 5 TUB.
[75] Art. 125-ter, co. 2, lett. b) TUB.
[76] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
[77] Art. 120-undecies TUB.
[78] Corte di Giustizia UE, causa C-42/15, Home Credit Slovakia c. Klára Bíróová, 9 novembre 2016.
[79] Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
[80] Art. 126-undecies TUB.
[81] D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 120-quinquies, 123–126-undecies – Definizioni di TAEG e ICC, obbligo di indicare gli indici sintetici nei documenti informativi e contrattuali; Disposizioni di trasparenza Banca d’Italia, Parte II (agg. 2024) – Modalità di calcolo e di esposizione dell’ICC (Allegati 5A-5B), obbligo di riportarlo nel Documento informativo sulle spese e nei riepiloghi periodici, in https://www.bancaditalia.it; CGUE, 18 dicembre 2014, C-449/13, CA Consumer Finance, https://eur-lex.europa.eu – Ribadisce che il TAEG va comunicato in modo chiaro e tempestivo quale indice-chiave di comparazione.
[82] Disposizioni di trasparenza Banca d’Italia, Parte II, Sez. II, § 8; Cass. civ., ord. 11 luglio 2023, n. 14000 – Qualifica l’ICC/TAEG come indice puramente informativo; la sua omissione incide sulla responsabilità dell’intermediario ma non sulla validità del contratto (salvo credito al consumo: art. 125-bis TUB).
[83] Art. 120-quinquies, lett. d) TUB.
[84] TUB, artt. 120-quinquies lett. d), 121, 125-bis; Cass. civ., 9 dicembre 2021, n. 39169 – la mancata indicazione del TAEG in un’apertura di credito integra violazione degli obblighi di trasparenza ma non determina, di per sé, la nullità del contratto; resta la tutela risarcitoria.
[85] Art. 125-bis TUB.
[86] T.U. Bancario (d.lgs. 385/1993) art. 116: pubblicità e “avvisi” – informazioni standardizzate destinate al mercato, art. 117: forma e contenuto dei contratti – condizioni effettive applicabili al singolo cliente; Corte di Giustizia UE, causa C-42/15, Home Credit Slovakia c. Klára Bíróová, 9 novembre 2016 – la trasparenza pubblicitaria esige dati standardizzati; le informazioni pre-contrattuali integrano poi il contratto.
[87] CGUE, 18 dicembre 2014, causa C-449/13, CA Consumer Finance SA.
[88] Art. 125-bis TUB.
[89] Artt. 120-noviesdecies e 126-quinquies TUB.
[90] Art. 127 TUB.
[91] U. Malvagna, Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB, in Diritto bancario, 2015.
[92] G. Molle, & L. Desiderio, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2005; F. Capriglione, Manuale di diritto bancario e finanziario, Cedam, 2024.
[93] U. Malvagna, Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB, in Diritto bancario, 2015 – Nullità di protezione rilevabile d’ufficio solo nell’interesse del cliente – Cass. SS.UU. 26242/2014.
[94] Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, Sez. III, § 1.
[95] Sottoscritti solo dal cliente.
[96] M. Chironi, La Cassazione sulla validità dei contratti “bancari” monofirma, in Diritto del risparmio, 2018 – Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 16406 del 21.06.2018, rel. Falabella – Validità del contratto “mono-firma” se consegnato al cliente.
[97] Cass. VI, 22640/2019 – Consegna con quietanza distinta sufficiente a integrare la forma.
[98] Sez. III, § 2.
[99] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori.
[100] Direttiva (UE) 2015/2366 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno – PSD2.
[101] CGUE, 4 ottobre 2018, C-191/17, ING-DiBa.
[102] Art. 127 TUB.
[103] U. Malvagna, Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB, in Diritto bancario, 2015 – Nullità di protezione rilevabile d’ufficio solo nell’interesse del cliente – Cass. SS.UU. 26242/2014.
[104] Art. 4 d.l. 23/2020, c.d. decreto Liquidità.
[105] S. Santamaria, Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei contratti bancari. Fu vera gloria?, in Dir. econ., 2022, 312-313.
[106] Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898 – Le Sezioni Unite della Cassazione sul contratto “monofirma”.
[107] Cass. Civ. 5919/2016, 7068/2016 e 8395/2016: invalidità dei contratti firmati solo dal cliente, in assenza di consegna/esecuzione.
[108] Art. 23 TUF.
[109] Diritto.it, La forma del contratto nel contratto-quadro relativo ai servizi di investimento: la parola alle Sezioni Unite, in https://www.diritto.it, 2020.
[110] Diritto bancario, Valido per le Sezioni Unite il contratto quadro sottoscritto dal solo investitore, in https://www.dirittobancario.it, 2018.
[111] S. Cosentino, Le Sezioni Unite della Cassazione sul contratto “monofirma” (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898), in https://www.giappichelli.it.
[112] M. Di Martino, La forma del contratto e i contratti di investimento “monofirma”: verso la affermazione della forma “in concreto” del contratto, in Executivis, 2022.
[113] M. Chironi, La Cassazione sulla validità dei contratti “bancari” monofirma, in Diritto del risparmio, 2018.
[114] Diritto del risparmio, Nel requisito di forma del contratto bancario rientra anche la consegna di un esemplare al cliente, in https://www.dirittodelrisparmio.it, 2024.
[115] L. Colombo, & L. L. Spangaro, Validità del contratto bancario sottoscritto dal solo correntista – Cassazione Civile, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16362 – Pres. Didone, Rel. Fichera, in Diritto bancario, 2018.
[116] Art. 117-bis TUB.
[117] Legge n. 108/1996 sull’usura.
[118] Art. 120 TUB e delibere CICR.
[119] Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675.
[120] Art. 2, co. 4, L. n. 108/1996.
[121] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27442 del 30-10-2018 – Gli interessi moratori rientrano a pieno titolo nella disciplina anti-usura; vanno confrontati con il tasso-soglia della medesima categoria di credito. Se sono usurari, la clausola è nulla e gli interessi di mora si convertono in interessi al tasso legale ex art. 1224 c.c.; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 38555 del 06-12-2021 – Ribadisce che il confronto si fa con il tasso-soglia “puro”; bocciata la prassi di aggiungere il +2,1 % indicato nelle vecchie istruzioni Banca d’Italia. Il giudice deve quindi verificare se il tasso di mora pattuito (o preteso) superi la soglia del periodo di riferimento; solo in tal caso scatta la nullità della clausola.
[122] L. 47/2013.
[123] A.A. Dolmetta, & A. Sciarrone Alibrandi, Ius variandi bancario. Sviluppi normativi e di diritto applicato, Giuffrè, 2012.
[124] Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110 – Sul tasso “per relationem”: la banca deve determinare ex ante i criteri del tasso e non può “scaricare” sullo ius variandi lacune del contratto. L’art. 118 TUB ha condizioni e modalità precise e non è scorciatoia per variare ciò che doveva essere pattuito.
[125] Corte d’Appello di Trieste, 18 luglio 2019, n. 511 – Caso-scuola: richiama l’art. 118 TUB e ribadisce che la banca deve inviare una comunicazione espressa con la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, preavviso di almeno 2 mesi, giustificato motivo concreto (non mere “policy” interne) e facoltà di recesso entro 60 giorni con diritto del cliente all’applicazione delle condizioni precedenti in sede di liquidazione. In difetto, la variazione è inefficace.
[126] Corte d’Appello Torino, 29.4.2025, n. 381 – Causa su conto corrente con contestazione anche di ius variandi: esito di ricalcolo e condanna della banca al pagamento delle somme risultanti.
[127] Artt. 7-9 d.lgs. 11/2010.
[128] M.C. Paglietti, Questioni in materia di prova nei casi di pagamenti non autorizzati, Roma Tre Press, 2020.
[129] Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2022, n. 27449. In tema di assegno circolare, la clausola “salvo buon fine/salvo incasso” è condizione sospensiva: se il titolo non viene pagato, la banca negoziatrice può stornare l’accredito. Chiarisce la diversa logica tra disponibilità e definitività dell’accredito su assegni, coordinabile con l’art. 120 TUB sui tempi/valute.
[130] Cass. civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2021, n. 12662 — collega espressamente l’approvazione tacita dell’estratto a 1832 c.c. e al termine di 60 giorni ex art. 119, co. 3 TUB; richiama anche la periodicità di invio prevista dall’art. 119 (annuale/semestrale/trimestrale/mensile).
[131] C-351/21, ZG / Beobank SA (Corte di giustizia, 16.03.2023) – Sotto PSD1 (regime poi rifluito in PSD2) la Corte ribadisce: obblighi informativi verso il pagatore (art. 47), onere di rimborso per operazioni non autorizzate (artt. 58, 60, 61). È un tassello che consolida il quadro di trasparenza e responsabilità armonizzata dei PSP su cui PSD2 ha costruito.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.