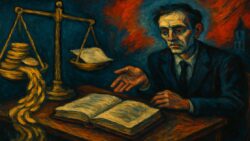Il sale and lease back: natura giuridica e divieto del patto commissorio
Le origini. A partire dagli anni’90 la giurisprudenza di legittimità ha cominciato a sostenere la configurabilità del contratto di sale and lease back di matrice prettamente anglosassone.
Secondo i Giudici di legittimità, il contratto in questione realizzava un’operazione negoziale complessa, sovente adoperata nella prassi finanziaria, in quanto utile all’esigenza degli operatori economici di ottenere pronta liquidità, mediante l’alienazione di un bene strumentale, conservandone l’uso e con la possibilità di acquistarne la proprietà al termine del rapporto.
L’operazione negoziale, nonostante il non infrequente pericolo di un’elusione fraudolenta del divieto di patto commissorio posta dall’articolo 2744 c.c., veniva considerata lecita laddove le circostanze del caso concreto non evidenziavano un uso “preordinato” a realizzare risultati confliggenti con il divieto codicistico; in pratica ogni qualvolta il sale and lease back non aveva uno scopo di garanzia.
Sicuramente non può negarsi che il contratto oggetto della presente analisi, costituisca la prima “spia” dell’erosione del divieto del patto commissorio, giunta all’apice con la proliferazione incessante del patto marciano, di cui non si è mai dubitato della sua validità.
La struttura: le tesi. Il leasing di ritorno, a differenza del leasing finanziario avente struttura trilaterale, si caratterizza per una struttura tipicamente bilaterale, ove sono presenti due soggetti: il primo è il proprietario del bene che ne diventa l’utilizzatore, invece, il secondo è colui che, dopo aver acquistato il bene dal proprietario, concederà a quest’ultimo il godimento del bene attraverso la stipulazione di un contratto di leasing.
Il riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità della liceità del sale and lease back non è stato sempre facile, anzi, in un primo momento si è dimostrato essere alquanto tortuoso.
In passato, infatti, si era sostenuto che il leasing di ritorno fosse nullo perché confliggente con il divieto del patto commissorio, ed era altresì caratterizzato da un’incongrua distribuzione di pesi e vantaggi a scapito del soggetto che aveva la duplice veste di venditore e di utilizzatore; in buona sostanza attraverso questa operazione negoziale si realizzava un risultato non meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico.
Oggi non si nega più la validità del sale and lease back, tuttavia, non è sempre facile per gli operatori del diritto ricondurre la fattispecie in esame, chiaramente atipica, all’interno di discipline tipiche, infatti, diverse sono state le tesi elaborate ai fini della sua corretta qualificazione.
Una tesi che merita di essere analizzata è quella che ha qualificato il contratto in esame come un’ipotesi di collegamento negoziale, in quanto, da un punto di vista pratico l’operazione si attua mediante il collegamento tra il contratto con il quale un’impresa vende un bene strumentale di sua proprietà ad una società finanziaria, la quale paga un prezzo, ed il contratto con il quale quest’ultima concede il bene contestualmente in locazione alla venditrice, verso il pagamento di un canone periodico e con la possibilità di riacquisto del bene alla fine del contratto.
Una tesi, oggi del tutto superata, è quella che considerava il leasing di ritorno come una vendita con patto di riscatto ai sensi dell’articolo 1503 c.c.
In realtà, la vendita con patto di riscatto si caratterizza per il fatto di realizzare una compravendita di beni mobili o immobili, ove il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà dei beni, attraverso la restituzione del prezzo e delle spese sostenute per la vendita e la conservazione del bene.
Tuttavia, nel leasing di ritorno il riscatto, che è automatico nell’ipotesi di cui all’articolo 1503 c.c., invece, non lo è; non si può prescindere dall’esercizio dell’opzione all’acquisto.
I due istituti sono diversi: vi è incompatibilità tra alienazione in garanzia e riscatto.
Va dato atto, nell’ambito della presente analisi, di un orientamento volto a ricondurre l’istituto del leasing di ritorno nell’ambito del contratto di riporto disciplinato agli articoli 1548 ss. c.c.
In base al contratto di riporto, un soggetto trasferisce la proprietà di titoli di credito ad un altro soggetto, che si assume l’obbligo di trasferire al primo, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, dietro il corrispettivo di un prezzo, aumentato o diminuito in misura convenuta.
Lo scopo perseguito è quello di garantire la temporanea disponibilità di denaro al titolare del titolo senza privarlo del diritto dominicale e al tempo stesso di trasferire temporaneamente quei titoli a chi intende averne una disponibilità limitata per un certo scopo da realizzare.
Le tesi finora prospettate, allo stato attuale, e nonostante i punti di contatto con le fattispecie codicistiche richiamate, non permettono di inquadrare il leasing di ritorno in nessuna delle stesse.
Ad oggi, infatti, appare di gran lunga prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, la tesi che qualifica il contratto di sale and leaseback come un contratto d’impresa socialmente tipico.
Resta ferma la necessità di verificare in concreto, l’assenza di indici sintomatici di un’alienazione di garanzia volta ad eludere il divieto del patto commissorio, sanzionabile con la nullità di cui all’articolo 1344 c.c., per illiceità della causa, in relazione all’articolo 1418 co.2 c.c.
Trattasi, pur sempre, di un contratto non codificato dal legislatore, quindi, atipico e rispetto al quale è sempre necessaria da parte del giudice un’indagine in merito alla meritevolezza ai sensi dell’articolo 1322 co. 2 c.c.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Michela Falcone
Ultimi post di Michela Falcone (vedi tutti)
- Mandati successori e divieto dei patti successori: guida essenziale - 8 Dicembre 2025
- La prelazione impura - 1 Dicembre 2025
- Il trust e il suo utilizzo nell’arte - 24 Novembre 2025