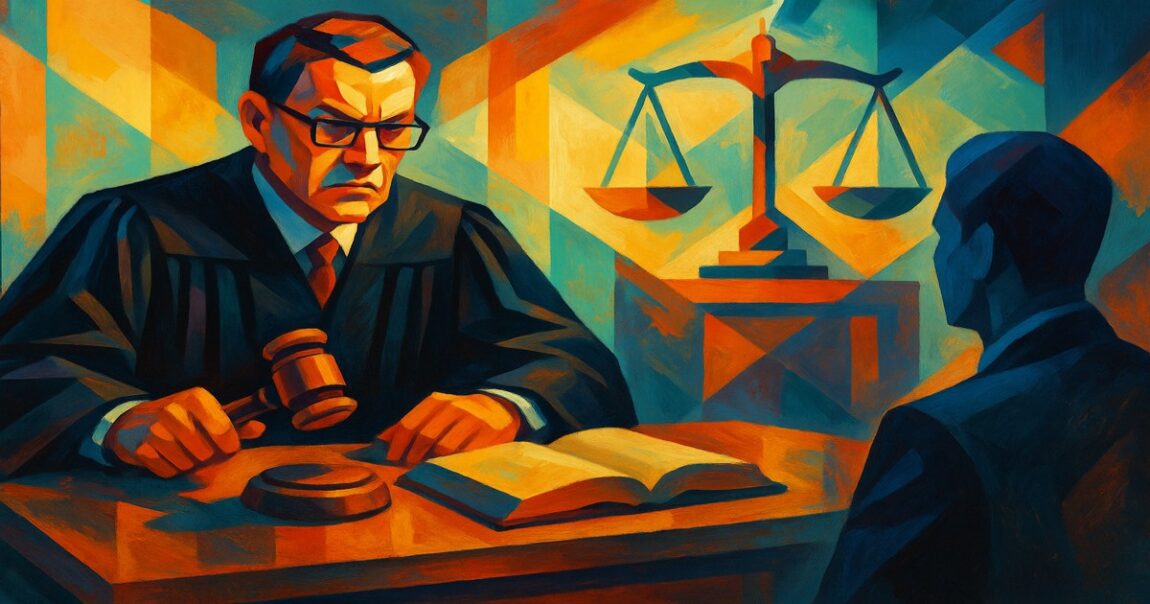
L’udienza preliminare: analisi degli istituti processuali e critica delle prassi applicative illegittime
1. L’udienza preliminare: la naturale funzione di filtro predibattimentale
L’udienza preliminare rappresenta una sorta di terra di mezzo tra la fase investigativa tipica delle indagini preliminari e la fase dibattimentale tipica del “processo” accusatorio. L’udienza filtro, di cui ci accingiamo a trattare, riveste in realtà una duplice funzione all’interno dell’ordinamento giuridico, ovvero quella di fungere da centro di controllo sull’attività investigativa svolta in fase investigativa, quindi attraverso l’analisi del fascicolo di indagini da parte del magistrato investito di tale compito, oltre al controllo della regolarità dell’atto di impulso di natura inquisitoria (che il codice di rito disciplina all’art. 417) che promana dal magistrato incaricato di dirigere la suddetta attività inquirente.
Il quale, oltre a indicare sommariamente le fonti di prova che ritiene di aver acquisito, oltre a descrivere il fatto di reato presunto in forma chiara e precisa con annesse le circostanze aggravanti e quelle che possono giustificare la messa in pratica di misure di sicurezza, allegando sempre le norme di legge di riferimento, dovrà anche indicare l’identità dell’indagato divenuto imputato. Ebbene sì, un altro elemento di non poco conto, che caratterizza l’udienza de quo, è rappresentato dal fatto che proprio in tale fase intermedia della giurisdizione penale, il soggetto o i soggetti, attinti dall’azione inquisitoria che li ha costretti a subire un’indagine a loro carico per un periodo più o meno lungo (in certi casi l’organo inquisitore si è spinto a inquisire dei soggetti, rivelatisi poi del tutto innocenti, per ben otto anni!!) passano dall’essere definiti “indagati” all’essere definiti imputati, e questo quando ancora non si è dato inizio a nessuna fase processuale, nemmeno di tipo speciale, come vedremo in seguito.
L’altra funzione cui assolve l’udienza preliminare è quella di essere la sede, in questo caso “processuale”, di alcuni procedimenti speciali tipizzati dal codice di rito, i quali sono in pratica dei micro-processi che, al di là degli aspetti peculiari di natura processuale che li contraddistinguono, svolgono tutti la funzione deflattiva dibattimentale.
Tornando al requisito dell’identità dell’imputato, è necessario in questa sede specificare che questa può essere desunta anche da altre circostanze (che non sono quelle tipiche del riconoscimento anagrafico): infatti può capitare che, ai fini dell’identificazione dell’imputato (requisito vincolante ai fini della richiesta di rinvio a giudizio come per l’udienza filtro in commento ai sensi degli artt. 66 c.p.p. e 417 c.p.p.), si debba ricorrere agli alias presenti nel Casellario centrale di identità delle forze di polizia¹, agli esiti degli accertamenti fotodattiloscopici, al C.U.I. (codice di Spangher G., ed. UTET giuridica, pag.857. univoco individuo), tutti elementi che possono svolgere la funzione di garantire che il soggetto imputato sia stato realmente identificato.
Stesso dovere incombe sul magistrato in relazione all’identificazione della persona offesa: anche in questo caso, qualora lo stesso non riesca a identificare la persona offesa, rischia la restituzione degli atti con la conseguente retrocessione del procedimento in sede di indagini.
La formula dell’art. 417 c.p.p. possiamo definirla come una sorta di precetto preparatore che il magistrato richiedente deve osservare puntualmente e minuziosamente al fine di presentarsi in sede di udienza preliminare con coscienza libera da omissioni procedurali nocive al pacifico svolgimento della stessa.
In questa sede saranno trattati i punti salienti dell’istituto sopra richiamato, in forma sintetica anche in considerazione della loro comprensione che, sin dalla prima lettura, appare abbastanza facile per l’interprete, in modo da dedicare il nostro focus analitico direttamente sullo svolgimento dell’udienza preliminare, concludendo la nostra analisi con l’esame della riforma Cartabia in relazione ai punti di interesse sin qui accennati.
Se prima abbiamo analizzato il requisito dell’identità dell’imputato e della persona offesa, ora l’attenzione si sposta sulla descrizione dell’ipotetico fatto di reato contestato all’imputato. Nella specie, dobbiamo in questa sede specificare quali sono gli elementi del fatto presunto che sono sufficienti per definirlo e per descriverlo come realmente avvenuto. Nel far questo si deve partire da una considerazione: il fatto ipotetico di reato deve essere ricostruito in forma chiara e precisa, ovvero questo racconto del fatto di reato deve essere puntuale nella ricostruzione di tutti gli elementi oggettivi che lo compongono.
Pertanto, il magistrato richiedente dovrà ricostruire per intero tutta la dinamica dell’evento antigiuridico al fine di conferirgli il titolo giustificativo di una richiesta di rinvio a giudizio. Tale operazione si mostra da subito di difficile applicazione, anche in considerazione del fatto che l’organo dell’azione penale, seppur obbligato dalla legge alla ricerca di elementi di prova anche a favore dell’indagato, è portato geneticamente all’utilizzo compulsivo dello strumento accusatorio in commento: a meno che non emergano fatti di lampante natura scagionatrice, egli si determina sempre nel richiedere l’approfondimento processuale per l’indagato.
Questo fenomeno, per come è stato descritto, determina di fatto un’approssimativa descrizione dell’ipotetico fatto di reato in sede di richiesta di rinvio a giudizio da parte dell’organo requirente, vanificando quindi la formula di condotta in esame; ma vi è di più: a rendere ulteriormente privo di effetti giuridici il dispositivo in parola è l’omissione posta in essere da molti G.U.P. (appartenenti allo stesso ufficio dei magistrati requirenti) i quali, avendo il potere e l’obbligo di chiedere al magistrato richiedente di circoscrivere meglio i termini del fatto di addebito penale, specificandone gli elementi essenziali che lo caratterizzano e, soprattutto, indicandone gli elementi che lo definiscono antigiuridico sotto il profilo penale, spesso rimangono inermi e ammettono de plano la richiesta di rinvio a giudizio, la quale è mancante dei requisiti essenziali e quindi, di fatto e di diritto, nulla; con la diretta conseguenza che, all’esito confermativo dell’udienza stessa, l’imputato sarà costretto a subire un processo senza alcuna ragione di fatto e di diritto.
Sulla scorta di quanto appena affermato, ci si chiede lecitamente se non sia realmente giunto il momento di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Altro requisito importante previsto dall’articolo in commento è quello inerente all’indicazione delle circostanze aggravanti e delle circostanze che possono comportare l’applicazione delle misure di sicurezza, al fine di riuscire a qualificare in modo compiuto, sotto il profilo giuridico, il fatto storico oggetto del procedimento penale.
1.2. L’organo giudiziale dell’udienza preliminare
L’organo giudiziale dell’udienza preliminare è un magistrato che, in relazione al procedimento del quale dovrà occuparsi, non deve aver svolto alcun ruolo attivo; ovvero non ha ricoperto cariche di magistrato inquirente o G.I.P. in merito a quel procedimento che poi è giunto all’udienza preliminare. Quanto detto discende dalle disposizioni del comma 2-bis ex art. 34², introdotto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che di fatto ha modificato la situazione antecedente, dove purtroppo era consentito a un magistrato che aveva prestato la propria opera come G.I.P. in un procedimento in sede di indagini preliminari di rivestire il ruolo di G.U.P. nella conseguente udienza preliminare.
Quest’incompatibilità non riguarda i casi previsti dall’art. 34, comma 2-ter, dove l’organo giudiziale dell’udienza, nella fase precedente, ha ricoperto ruoli nello stesso procedimento dove non si richiedeva l’anticipazione di giudizi sull’indagato. Allo stesso modo, si ammette, a norma dell’art. 34, comma 2-quater, in quanto compatibile con le funzioni de quo, l’operato del suddetto magistrato giudicante che ha svolto incarichi di organo giudiziale in sede di incidente probatorio, o che abbia disposto dei provvedimenti già disciplinati dal codice in esame.
Da ultimo, a completamento dell’analisi sin qui proposta, è necessario specificare che, al fine di individuare il magistrato competente per lo svolgimento dell’udienza preliminare, si deve ricorrere anche allo strumento dell’art. 4-bis del d.l. n. 82 del 2000, convertito in l. 144/2000, il quale, mediante un’interpretazione autentica del disposto dell’art. 328, comma 1-bis, prescrive che, per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, anche le funzioni dell’organo giudicante dell’udienza preliminare sono rivestite da un magistrato del tribunale sito nel capoluogo del distretto giudiziario di competenza.
1.3. Gli atti introduttivi: la discovery
La fase antecedente la celebrazione dell’udienza preliminare si compone di alcuni passaggi preliminari. Nella specie, tutto inizia con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico accusatore presso l’ufficio del G.U.P., allegando il fascicolo delle indagini preliminari ex art. 416, comma 2. Giunta questa richiesta all’organo giudicante, sarà quest’ultimo a fissare il giorno e il luogo in cui sarà celebrata l’udienza (art. 418, comma 1). Il tempo trascorso tra il ricevimento della richiesta suddetta da parte dell’organo giudicante e il giorno deciso per la celebrazione dell’udienza non potrà essere superiore a 30 giorni (art. 418, comma 2).
Le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo che abbiano un termine libero per svolgere e depositare atti a supporto delle attività già documentate e depositate in sede di indagini preliminari (art. 419, comma 4). L’avviso della celebrazione dell’udienza è notificato all’imputato e alla persona offesa, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio; l’imputato è avvisato che, in caso di sua mancata comparizione, sarà giudicato in assenza a norma dell’art. 419, comma 1.
Lo stesso avviso è notificato al pubblico accusatore che ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio e al difensore dell’imputato (in questo caso però il difensore riceverà soltanto l’avviso relativo all’udienza e non anche la richiesta di rinvio a giudizio), il quale ha facoltà di prendere visione degli atti e degli oggetti pertinenti al procedimento depositati in cancelleria; allo stesso modo è riconosciuta la facoltà alle parti di presentare memorie e produrre documenti.
Da questa fase in avanti, ogni atto integrativo delle indagini preliminari, svolto sia dalla pubblica accusa che dalla difesa o da altre eventuali parti, deve essere reso immediatamente conoscibile; infatti, non essendo più in essere la fase di indagini preliminari coperta dal segreto istruttorio, si prescrive come obbligatoria la discovery immediata di ogni atto integrativo o comunque successivo alla suddetta fase procedimentale, successivo alla richiesta di rinvio a giudizio. Tale ulteriore ed eventuale documentazione deve essere depositata presso l’ufficio del G.U.P. a norma dell’art. 419, comma 3, in modo che tutte le parti coinvolte possano prenderne visione (art. 131 disp. att. c.p.p.). Il difensore dell’imputato o della persona offesa può presentare la loro documentazione integrativa nelle forme previste dall’art. 391-octies c.p.p.
Da quanto sin qui esplicato, si assume l’importanza dell’istituto in commento, volto a garantire alle parti della controversia la piena conoscenza di tutti gli elementi sino a quel momento acquisiti, sia in ordine all’accusa che alla difesa. Ovviamente, questa garanzia si presume sia più utile alla difesa che all’accusa, dato che ormai il magistrato inquirente ha cristallizzato la sua teoria accusatoria nella richiesta di rinvio a giudizio, allegando l’attività di indagine svolta (che spesso è molto deficitaria) nel fascicolo delle indagini preliminari.
È proprio in questa fase antecedente la celebrazione dell’udienza che si viene a conoscenza delle distorsioni della procedura penale, poste in essere da magistrati inquirenti che spesso abusano del loro potere al fine di ottenere facili condanne, sulla base di risultanze investigative totalmente improduttive di reali segni di colpevolezza nei riguardi dell’imputato. Ecco che questa fase assume per la difesa un’importanza strategica al fine di delineare e pianificare al meglio la propria strategia a contrasto dell’indomabile foga accusatoria che spesso pervade l’organo dell’azione, a danno di persone innocenti che, in ogni caso, se non riusciranno a smentire la tesi accusatoria, dovranno subire un “ingiusto processo”.
1.4. Lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio
Prima di addentrarci nel trattare il tema oggetto di questo paragrafo, è necessario soffermarci brevemente sulle principali circostanze, previste dall’art. 420 c.p.p.³, che si riferiscono ai casi in cui il difensore dell’imputato non sia presente all’udienza e all’eventualità dell’assenza dell’imputato. In relazione a queste eventualità, posta l’obbligatoria presenza del difensore e del pubblico ministero all’udienza in commento, il codice di rito prescrive specifici accorgimenti per garantire il normale svolgimento dell’udienza.
Nella specie, il codice segue un principio generale che possiamo sintetizzare così: in relazione all’assenza del difensore, se questa è giustificata o giustificabile e annunciata con sufficiente preavviso, determina lo spostamento dell’udienza a nuova data; se invece tale assenza non appare giustificata o giustificabile, l’organo giurisdizionale deve determinarsi nel rintracciare un difensore prontamente reperibile, posto che tutti gli avvisi e le notifiche siano stati regolarmente recapitati ai difensori. In caso contrario, egli dovrà procedere con la rinnovazione degli avvisi e delle relative comunicazioni che siano state considerate giuridicamente nulle.
Stessa cosa deve intendersi in relazione all’assenza dell’imputato: se questi non ha ricevuto tali comunicazioni, ha diritto alla rinnovazione degli avvisi; come per il difensore, anche l’imputato è legittimato a non presenziare all’udienza preliminare. Oltre al caso sopra indicato, l’imputato potrebbe non presentarsi in udienza a causa di circostanze (caso fortuito, forza maggiore, legittimo impedimento) che ne hanno determinato l’effettiva impossibilità a partecipare alla suddetta udienza; in questo caso l’organo giudiziale deve spostare l’udienza a nuova data, premurandosi di rinnovare gli avvisi per tutte le parti.
Da ultimo, si richiama la circostanza espressamente prevista dal codice di rito, a beneficio dell’imputato, che attiene alla sua scelta libera di non essere presente all’udienza: in tale evenienza, posto che sia dimostrato che l’imputato abbia ricevuto tutti gli avvisi con le specifiche notifiche, l’organo giudicante (G.U.P.), con ordinanza, ne dispone la prosecuzione in assenza⁴ dell’imputato, dopo aver interpellato le parti a norma dell’art. 420-bis, comma 1-bis e comma 2. Per successivi approfondimenti si rimanda all’analisi sistematica degli artt. 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater c.p.p.
Al netto delle prescrizioni sopra enunciate e di quelle indirettamente richiamate, risolte le questioni preliminari, l’udienza preliminare può avere inizio. Come primo compito, l’organo giudicante dovrà decidere sull’ammissibilità (art. 421, comma 3, c.p.p.) di atti e documenti prodotti dalle parti, in base a criteri di utilità, legalità e rilevanza. A questa prima analisi del magistrato giudicante segue la discussione, che si svolge tramite l’esposizione dell’organo accusatore, il quale “sinteticamente”⁵ è chiamato a rendere conto delle prove acquisite a carico dell’imputato e del risultato complessivo delle indagini svolte.
Sul punto è necessario specificare che l’istituto in commento prescrive che il pubblico accusatore non si possa limitare a una sintetica elencazione delle norme penali che si ritengono inosservate, bensì è tenuto a fornire un’attenta valutazione degli elementi accusatori, contestualizzandoli al reale svolgimento del fatto storico (ammesso che tale fatto sia realmente accaduto). Di tali prescrizioni, purtroppo, in concreto, i pubblici ministeri non tengono conto, con la complicità di magistrati giudicanti appartenenti al loro stesso ufficio giudiziario, con la conseguenza che i suddetti inquisitori, di fatto, assolvono all’onere della prova penale tramite una lettura striminzita, di poche righe, che ricalca quanto accennato dallo stesso organo dell’azione in sede di richiesta di rinvio a giudizio.
All’esposizione del magistrato requirente seguono le dichiarazioni spontanee dell’imputato nelle forme prescritte dagli artt. 64 e 65 c.p.p., o tramite l’esame incrociato su richiesta di una delle parti. A seguire, si svolgono le argomentazioni dei difensori delle parti private (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ed infine l’imputato). Alle argomentazioni dedotte in discussione, il pubblico ministero e il difensore possono replicare solo una volta.
La discussione si conclude con le conclusioni del magistrato requirente e dei difensori, i quali svolgono tali compiti anche facendo ricorso agli atti e documenti prodotti direttamente in sede di udienza (come anticipato in precedenza), nonché al fascicolo delle indagini preliminari. Conclusa la discussione, l’organo decidente si ritira per la decisione. Tale decisione può essere definitiva (sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio) oppure interlocutoria, ovvero nei casi in cui l’organo giudiziale dichiari di non poter decidere allo stato degli atti; in tal caso il magistrato indica al pubblico ministero gli ulteriori atti di indagine da compiere⁶, come potrà anche indicare gli atti di indagine che il pubblico inquisitore non ha mai compiuto pur avendo l’obbligo di compierli; oppure il magistrato potrà disporre l’assunzione diretta (art. 422 c.p.p.) delle prove in udienza, dando inizio a una fase interlocutoria speciale. Di quanto sin qui accennato si darà conto nel paragrafo seguente.
1.5. Le indagini su iniziativa dell’organo giudicante
A norma dell’art. 421-bis, il magistrato giudicante ha la facoltà di chiedere al pubblico ministero l’approfondimento investigativo su temi di prova che sino a quel momento non erano stati esplorati. Tale attività suppletiva di matrice investigativa deve essere ugualmente orientata sia nell’interesse dell’organo accusatore (anche se rientra nel suo interesse e nei suoi obblighi di legge quello di ricercare elementi investigativi anche a favore dell’indagato sin dall’inizio delle indagini preliminari, ma spesso si contraddistingue per la tendenza a tralasciare elementi probatori a discarico), sia nell’interesse dell’imputato, il quale ha diritto allo svolgimento di indagini neutrali, non contaminate dall’obiettivo della pubblica accusa di ricercare in modo univoco solo frammenti probatori utili alla precostituita tesi accusatoria, a discapito della presunzione di innocenza.
In questo caso il pubblico accusatore deve indirizzare la sua azione suppletiva di indagine anche a favore dell’imputato qualora vi fossero elementi probatori a discarico. All’esito di queste integrazioni, il magistrato giudicante è chiamato a decidere sulla richiesta oggetto dell’udienza, ovvero dovrà emettere sentenza di non luogo a procedere se gli elementi raccolti siano privi di portata accusatoria idonea a reggere al successivo dibattimento.
Sul punto occorre richiamare il nuovo principio che si desume dalla recente riforma Cartabia: a differenza di quanto accadeva prima, non è più sufficiente, ai fini della richiesta in commento per la pubblica accusa, presumere di avere elementi probatori sufficienti per ottenere una condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” in dibattimento; è richiesto di prospettare la colpevolezza dell’imputato oltre una “ragionevole previsione di condanna” in sede dibattimentale.
Quanto detto, se realmente considerato ed applicato dall’organo dell’azione e dal magistrato giudicante dell’udienza preliminare, rappresenta un’ulteriore garanzia a tutela dell’imputato: non è sufficiente una previsione di superamento del ragionevole dubbio, ma si necessita un’allegazione probatoria che integri e giustifichi una futura ipotetica “ragionevole previsione di condanna”.
Sulla scorta di quanto descritto, e considerata la prassi di indagini preliminari lacunose e approssimative, appare improbabile che un pubblico ministero possa determinarsi nella richiesta di rinvio a giudizio presumendo di poter ottenere una sicura condanna; principio che, purtroppo, viene spesso violato da pubblici inquisitori che, nonostante l’insufficienza di elementi, esercitano temerariamente l’azione penale. Se a ciò si aggiunge l’opera spesso deficitaria del magistrato giudicante, il quale, nonostante la carenza investigativa e la mole di elementi a discarico, non chiede l’integrazione investigativa al P.M. né si determina nell’assunzione diretta di nuove prove ex art. 422 c.p.p., si rinvia a giudizio l’imputato senza elementi tali da consentire una “ragionevole previsione di condanna”.
In ordine a quanto sin qui esplicato, chi scrive ritiene che il legislatore debba determinarsi nell’approvazione della norma che prescriva la separazione delle carriere giudiziarie, perché – sulla base di quanto dedotto – le attività dell’organo inquirente, seppur deficitarie, saranno quasi sempre avallate dagli organi giudicanti preliminari che fanno parte dello stesso ufficio, con conseguente compromissione dell’obiettività di giudizio, a discapito dell’imputato.
A completamento, si chiarisce l’attività del magistrato giudicante in ordine all’art. 421-bis: può tale organo indicare specifici atti di indagine o deve limitarsi a indicare temi di prova? Alla luce di quanto dedotto, il G.U.P., in funzione dell’obiettivo dell’udienza (vagliare ogni elemento probatorio ai fini del dibattimento), ha l’obbligo di esplorare ogni aspetto investigativo; ciò è possibile solo indicando anche specifici atti di indagine da compiere o da integrare. Solo attraverso l’esercizio di questo potere di integrazione specifico – a differenza della semplice indicazione di temi di prova – il giudice potrà avere gli elementi su cui fondare la decisione; in caso contrario non può assolvere all’obbligo di motivazione conclusiva.
1.6. La modifica dell’imputazione
Sulla base delle evidenze processuali, a norma dell’art. 423 c.p.p. è possibile la modifica dell’imputazione se il magistrato accusatore ravvisa nelle condotte dell’imputato novità rispetto a quanto approssimativamente descritto nella richiesta di rinvio a giudizio, ovvero se risulta che il fatto si è svolto diversamente da come descritto. Il magistrato suddetto si adopera a far pervenire tale comunicazione al difensore dell’imputato se assente, oppure direttamente all’imputato se presente in udienza.
Stessa cosa vale per i casi in cui si debba procedere per contestare una circostanza aggravante, un nuovo fatto commesso in esecuzione di quello per cui si procede, oppure un reato commesso tramite la stessa condotta oggetto di richiesta di rinvio a giudizio. Sul piano procedurale si riscontrano differenze rispetto al dibattimento: non è prevista la possibilità di richiedere i termini a difesa ex art. 519 c.p.p.; non è prevista, a favore dell’imputato assente, la notifica del verbale contenente la nuova contestazione, con la conseguenza che dovrà essere richiesto un rinvio dell’udienza.
Per questo motivo il pubblico ministero è tenuto a contestare il fatto di reato con tutte le sue modifiche direttamente in udienza al difensore dell’imputato, che informerà l’assistito.
Se nel corso dell’udienza emergono elementi che possono portare alla contestazione di nuove responsabilità penali (fatti nuovi), il pubblico ministero ha facoltà di comunicare tali modifiche direttamente in udienza all’imputato, sempre che il reato sia procedibile d’ufficio e se l’imputato accetti la modifica in udienza preliminare. In caso contrario, il P.M. dovrebbe aprire un nuovo fascicolo di indagini con oggetto il nuovo fatto di reato, con i tempi conseguenti; per tali ragioni il legislatore consente alle parti necessarie di definire la questione direttamente in udienza preliminare, sottoponendo all’organo giudicante anche il fatto nuovo, evitando di attendere un nuovo procedimento.
1.7. Il non luogo a procedere: la sentenza che rende giustizia all’imputato innocente
Gli esiti dell’udienza preliminare si riducono a due possibili pronunce: la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio. Il tema del non luogo a procedere è delicato e divisivo: tale decisione è spesso mal tollerata dai pubblici inquisitori, che pregustano il rinvio a giudizio come un traguardo da conquistare ad ogni costo; di contro, i difensori la accolgono come riconoscimento dell’innocenza (poi si vedrà in che modo) dell’assistito e del lavoro difensivo, nonché come “ricompensa morale” per chi abbia subito indagini e, talvolta, misure cautelari, con danni materiali e morali.
La scienza giuridica del processo penale ci consegna una formula tipizzata nell’art. 425 c.p.p., che prescrive: «Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo (1). 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del Codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (2). 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537.»
I tratti salienti di questa formula si possono sintetizzare richiamando i principi posti a fondamento dell’“azione penale illegittima”⁷ (definita in forma sintetica: a.p.i.): errori procedimentali che determinano la chiusura con non luogo a procedere. Il magistrato giudicante deve pronunciare non luogo a procedere anche quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, ecc.; e di ciò deve dare conto nel dispositivo.
Quanto dedotto costituisce parte fondamentale dell’opera del P.M., che, prima di esercitare l’azione penale, deve ponderare attentamente la decisione: in mancanza degli elementi richiamati non può chiedere il rinvio a giudizio, ma deve chiedere l’archiviazione; e, in taluni casi, non avrebbe dovuto nemmeno iniziare le indagini per un fatto non previsto come reato o non integrante la fattispecie.
L’“azione penale illegittima” è il risultato della somma algebrica di elementi con valore 0: se ogni elemento raccolto ha valore 0 (non rilevante penalmente), il risultato è 0, dunque l’azione intrapresa è nulla. Ciò va considerato anche dal giudice, ultimo baluardo di garanzia per evitare un “ingiusto processo” all’imputato innocente: egli ha l’obbligo di pronunciare non luogo a procedere quando ricorrano i presupposti.
Il legislatore prevede il procedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere: con l’art. 434 c.p.p. si disciplina la revoca quando il P.M. rinvenga nuovi elementi probatori a sostegno dell’accusa (anche sommati ai precedenti), sottoponendoli al G.I.P. per ottenere la revoca. A norma dell’art. 435 c.p.p., i nuovi elementi possono provenire da altri procedimenti o da terzi; il G.I.P. decide sull’ammissibilità e, in base alla presenza effettiva di novità, può concedere il rinvio a giudizio (se gli elementi siano già acquisiti) o disporre nuove indagini entro sei mesi dalla nuova iscrizione della notizia di reato.
Tale attività si svolge in camera di consiglio nelle forme dell’art. 127 c.p.p., avvisando P.M., imputato, difensore (o difensore d’ufficio) e persona offesa. Secondo l’art. 435 c.p.p., nella prima ipotesi il G.I.P. revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone una nuova udienza preliminare con ordinanza: circostanza definita “fenomeno inconsueto… è l’unico caso in cui ordinanze revocano sentenze”⁸. All’esito della nuova udienza, il giudice deciderà se rinviare a .giudizio l’imputato (nuovamente giudicato sul medesimo fatto) oppure emettere nuovo non luogo a procedere. Non è ammessa impugnazione avverso il provvedimento che accoglie la richiesta di revoca, mentre è ammesso ricorso per Cassazione del P.M. contro l’ordinanza che la rigetta (art. 437 c.p.p.).
1.8. Il decreto che dispone il giudizio
L’alternativa alla sentenza di non luogo a procedere è il decreto che dispone il giudizio disciplinato dall’art. 429 c.p.p.⁹, il quale prescrive: «1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento (con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;); (310) g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste. 2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis c.p., il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.»¹⁰
Come scritto all’inizio, il decreto che dispone il giudizio rappresenta l’alternativa alla primaria decisione di non luogo a procedere. È la diretta conseguenza della portata giuridica dell’udienza preliminare, strumento di garanzia a beneficio dell’imputato (o, se si preferisce, argine alla “esuberanza inquisitoria” della pubblica accusa). È la sede naturale di analisi definitiva degli elementi raccolti in sede investigativa, al fine di vagliare ogni elemento che possa giustificare il non luogo a procedere.
Tali elementi, secondo la scienza giuridica, non devono per forza essere reali elementi probatori a favore dell’imputato; possono essere rappresentati dall’assenza di elementi accusatori fondati, o dalla totale assenza di elementi a carico. In altri termini, l’assenza di reali elementi probatori a discarico non è segno di mancanza di elementi discolpanti: la sentenza di non luogo a procedere può basarsi anche solo sull’assenza di elementi a carico dell’imputato.
Altro profilo è la diversa forma di chiusura: con il non luogo a procedere si decide con sentenza; con il rinvio a giudizio si procede con decreto. La scelta del legislatore risiede nel tentativo di non condizionare il giudice del dibattimento con una sentenza che chiude la fase precedente; tramite decreto, il G.U.P. si limita a indicare brevemente le fonti di prova a sostegno.
Sul piano procedurale, si richiede che il fatto contestato sia ben qualificato e descritto in tutto il suo ipotetico decorso, così da essere percepito dall’imputato e dal giudice. Ne consegue la non necessaria indicazione specifica delle norme violate, a meno che la mancata qualificazione possa generare equivoci per la difesa¹¹.
L’udienza si conclude così in senso sostanziale, ma, a seguito dell’emissione del decreto, l’organo giudicante deve sovraintendere alla formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p.¹² e del fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 c.p.p.¹³. Tale procedura si svolge in udienza, in contraddittorio tra le parti; se una di esse lo richiede, il giudice fissa apposita udienza, entro 15 giorni, per la formazione del fascicolo. L’obiettivo è consegnare al giudice del dibattimento un oggetto di giudizio libero da condizionamenti investigativi precedenti alla formazione della prova, secondo il principio costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost.)¹⁴.
Tale procedura, per chi scrive, dovrebbe essere totalmente scissa dall’udienza preliminare, con svolgimento in sede specifica e, preferibilmente, dinanzi a organo diverso per garantire la necessaria obiettività in ogni fase del procedimento penale.
Da quanto sin qui dedotto, si assume – in termini necessariamente scientifici – l’importanza dell’udienza preliminare quale filtro di garanzia per l’imputato, nonché ultimo baluardo di tutela dei diritti in regime di presunzione di innocenza, prima di un eventuale “ingiusto processo” il cui esito finale potrebbe condizionare negativamente l’esistenza dell’imputato, al quale, ancora una volta, da presunto innocente, saranno negati i propri diritti.
Note
cfr. artt. 66 e 417 c.p.p., che impongono l’indicazione delle generalità dell’imputato e disciplinano le modalità di identificazione, anche attraverso alias, accertamenti fotodattiloscopici e codici identificativi univoci.
Sul punto si rimanda l’interprete alla lettura dell’articolo in commento in: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51!vig=Art. 420 c.p.p.: «1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (1). 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (2). 2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis (3). 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale (3). 3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.» — estratto da: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ix/art420.html
Sul punto si rimanda l’interprete, per approfondimenti, alla lettura dell’art. 420-bis, comma 1-bis e comma 2, c.p.p., con relativi commenti alle norme in “CODICE DI PROCEDURA PENALE, Studium”, a cura di Tramontano L., 22ª edizione, La Tribuna, da pag. 1117 a pag. 1129.
Termine da intendersi in questa sede nella sua accezione negativa, posto che per l’autore di questa monografia, in materia processuale, la “sintesi” non è foriera di ottimi risultati in termini di raggiungimento della prova, anzi è il presupposto di un’acquisizione approssimativa e altamente fuorviante degli elementi probatori, a diretto discapito della difesa dell’imputato.
Quanto detto trova applicazione ai sensi dell’art. 421-bis c.p.p.
Definizione scientifica coniata dall’autore di questa monografia per spiegare quelle che sono le patologie processuali conseguenti al non corretto utilizzo dell’azione penale da parte degli organi accusatori del procedimento penale.
Sul punto si rimanda l’interprete allo studio delle teorie del Prof. Cordero F. in “Procedura Penale”, di Cordero F., ottava ed., Giuffrè, pagg. 911-923.
Per approfondimenti si rinvia l’interprete alla consultazione degli aggiornamenti normativi in: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art429
Articolo del c.p.p. estratto con modifiche da: https://www.normattiva.it
Sul punto si segnala ex plurimis la sentenza di Cass. Penale: Cass., Sez. III, n. 46689 del 21 novembre 2023 (UP 2 nov. 2023), in: https://lexambiente.it/index.php/materie/acque/cassazione-penale159/acque-superamento-limiti-ed-eventi-eccezionali-o-imprevedibili.>>
Art. 431 c.p.p.: «1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all’estero, mediante rogatoria internazionale, e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236 (nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo); h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.» — parzialmente estratto da: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=5&art.idGruppo=59&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=088G0492&art.idArticolo=431&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&art.progressivo=0
Art. 433 c.p.p.: «Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza (1). 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore (2) è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.» — estratto da: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ix/art433.html
Estratto da: https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione.pdf
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Cristiano Tripodi
Ultimi post di Avv. Cristiano Tripodi (vedi tutti)
- Il decreto ingiuntivo: nuove prassi operative all’interno del procedimento di arbitrato - 28 Settembre 2025
- L’udienza preliminare: analisi degli istituti processuali e critica delle prassi applicative illegittime - 21 Settembre 2025
- Il procedimento civile arbitrale: trattamento elettivo su domanda giudiziale ex art. 216 c.p.c. - 4 Aprile 2024







